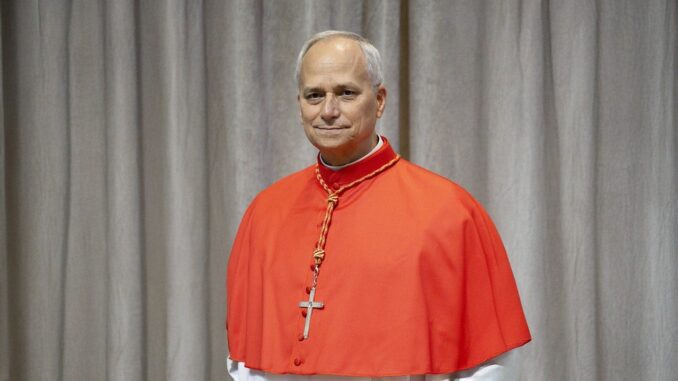
di Andrea Filloramo
Dal giorno della sua elezione, Papa Leone XIV ha impresso un segno preciso nel volto della Chiesa: quello di una liturgia ricca, solenne, partecipata. Le sue celebrazioni papali, trasmesse in mondovisione, nelle televisioni pubbliche e in quelle private, hanno mostrato un ritorno alla grandezza cerimoniale che molti pensavano relegata ai tempi del barocco romano.
Non pochi parlano di un vero e proprio “surplus di liturgia”.
Roma non ha mai brillato tanto.
Le liturgie papali di Leone XIV sembrano sfilate solenni: paramenti scintillanti, cori monumentali, incensi a profusione, dirette televisive con regie spettacolari, multilingue.

Per Leone XIV, la liturgia sembra essere non è un accessorio ma il cuore della vita ecclesiale. In un tempo di divisioni interne, di discussioni sulle riforme, di spinte centrifughe, di conferenze episcopali, il rito diventa il linguaggio comune, la grammatica che unisce vescovi e popolo di Dio. La scelta di amplificare il carattere comunitario delle concelebrazioni – con cori polifonici, processioni solenni, partecipazione massiccia di laici – risponde, secondo il Papa, al bisogno di visibilità e unità.
C’è chi legge, perciò, questa abbondanza rituale come un dono. Dopo decenni di sobrietà e sperimentazioni liturgiche, Leone XIV, infatti, avrebbe restituito centralità alla dimensione simbolica, facendo riscoprire al popolo cristiano la bellezza del sacro. Per il Papa, quindi, le liturgie papali diventerebbero delle “catechesi visive”, capaci di evangelizzare con il linguaggio dei segni prima ancora che con le parole.
Ma non è per tutti così. Per tanti il “di più” può diventare “troppo”. A nessuno sfugge, infatti, il rischio di estetismo. Liturgie che sfiorano lo spettacolo televisivo, curate nei dettagli fino al punto di oscurare la spontaneità e la vita reale dei fedeli, possono lasciare molto perplessi. Il pontificato di Leone XIV mostrerebbe, pertanto, una tensione irrisolta.
Le domande sono forse necessarie e, quindi, ci chiediamo: “Come, evitare che il surplus liturgico si trasformi in eccesso rituale?” “Come custodire la bellezza senza cadere nell’autoreferenzialità del rito?
La sfida è indiscutibilmente aperta.
Il Concilio Vaticano II ci ricordava che la liturgia è “culmine e fonte” della vita della Chiesa e mai deve diventare o apparire come un un orpello da esibire. Deve essere un’energia da trasformare in carità, giustizia, riforma.
Una liturgia così carica di simboli, trasmessa in mondovisione, rischia di diventare più uno show che un sacramento. In esso il popolo non celebra ma assiste; i sacerdoti non guidano ma recitano, la comunità cristiana si trasforma in pubblico, più che in assemblea viva.
Leone XIV difende questa scelta come ritorno alla bellezza del sacro.
La domanda, tuttavia, resta: la liturgia deve affascinare o trasformare? Deve stupire l’occhio o scuotere le coscienze?
Il rischio non è nuovo.
Già il Vaticano II denunciava il formalismo rituale che svuota i segni di senso.
Eppure, mezzo secolo dopo, ad alcuni o a molti sembra che la Chiesa di Leone XIV torni a vestire i panni di un clericalismo cerimoniale. Sarebbe più preoccupata della perfezione del rito che della concretezza della vita.
Ma è proprio così?
Una cosa appare certa: è proprio nell’intendere la liturgia che Papa Leone XIV si distanzia e non di poco dal suo predecessore.
Mentre, infatti, Papa Francesco ha semplificato alcuni segni (es. ridotto uso del trono, preferenza per paramenti semplici, gesti umili). Leone XIV: sottolinea la dimensione simbolica tradizionale.
Mentre le liturgie di Francesco erano pensate per la vicinanza ed erano facilmente trasmissibili in immagini semplici e dirette (abbracci, lavanda, gesti umili). Quelle di Leone XIV: si prestano a una narrazione estetica e simbolica (processioni solenni, arredi ricchi, cori, folla multilingue), che i media raccontano come eventi globali.
Entrambi però cercano lo stesso obiettivo: far parlare la liturgia al cuore dei fedeli — uno attraverso l’immediatezza, l’altro attraverso la solennità.



