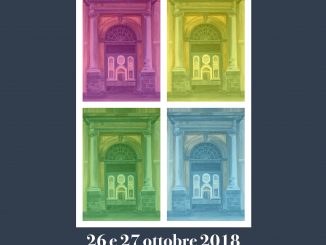di Andrea Filloramo
“Ah, come vorrei una Chiesa povera e per i poveri!” È la notissima esclamazione, uscita dalle labbra di Papa Francesco durante l’incontro coi rappresentanti dei media, il 16 marzo 2013, mentre rievocava pubblicamente le circostanze che l’avevano indotto alla scelta del nome: Francesco.
Tale scelta fu allora accolta col sapore della novità, tuttavia, in qualche modo, essa era già stata pronunciata nel secolo precedente.
Su di essa è opportuno fare alcuni accenni, utili a far comprendere, quello che stato e che continua a essere in senso più ampio possibile un processo storico o movimento, protratto nel tempo, attraverso il quale si e determinato, con l’avvento di Papa Francesco, un radicale mutamento di fatto della vita della Chiesa, dal quale si ritiene che difficilmente, con il conclave che si celebrerà fra alcuni giorni, si possa tornare indietro.
Si tenga presente che, negli anni Cinquanta e Sessanta del XX secolo, insieme all’incremento dei consumi e al boom economico in Europa e in Nord America, emergevano le contraddizioni di un mondo che iniziava a scoprirsi globale e la questione della povertà assumeva contorni nuovi che si presentavano già allora drammatici.
Giovanni XXIII, pochi giorni prima che iniziasse il Concilio Vaticano II (1962-1965), affermò che di fronte a quelle contraddizioni che la Chiesa aveva il dovere di presentarsi come «Chiesa dei poveri».
Da quelle parole scaturì un dibattito che coinvolse un movimento di vescovi e teologi nel tentativo di promuovere, da una parte, una radicale semplificazione degli apparati ecclesiastici e, dall’altra, l’evangelizzazione dei poveri come la principale missione ricevuta dalla Chiesa cattolica.
Durante il Concilio Vaticano II, voluto da Papa Giovanni, un gruppo di vescovi si è riunito più volte informalmente per promuovere una “Chiesa dei poveri”.
Nacque così un movimento – era l’anno 1962 – che ha assunto proprio quel nome, come un’iniziativa extra ufficiale di padri conciliari sensibili al tema della povertà, le cui riunioni si tenevano inizialmente presso il Collegio Belga a Roma.
L’obiettivo era quello di spingere la Chiesa verso un impegno più coerente di solidarietà con i popoli oppressi e formulare quella che sarebbe stata chiamata “opzione preferenziale per i poveri”.
Questa iniziativa culminò nel “Patto delle Catacombe“, firmato il 16 novembre 1965 da circa 40 vescovi, principalmente latino-americani, fra di essi molti brasiliani e latinoamericani e un unico italiano: mons. Luigi Bettazzi, vescovo di Ivrea (1966-1999), nelle catacombe di Domitilla a Roma.
Nel documento, i firmatari si impegnavano a vivere in povertà, a rinunciare ai simboli e privilegi del potere, e a mettere i poveri al centro del loro ministero pastorale.
Questi incontri e impegni rappresentarono un tentativo concreto di orientare la Chiesa verso una maggiore attenzione ai poveri, influenzando le discussioni conciliari e ispirando successivi movimenti ecclesiali, specialmente in America Latina.
Da dire con estrema chiarezza che il movimento della Chiesa dei poveri non riuscì ad affermarsi all’interno della struttura ufficiale della Chiesa per diversi motivi.
Nonostante alcuni dei suoi membri fossero vescovi partecipanti al Concilio Vaticano II, le loro proposte, infatti, non vennero recepite come linee guida ufficiali nei documenti conclusivi del Concilio.
Ciò accadeva perché molti settori della gerarchia ecclesiastica erano diffidenti o contrari a una messa in discussione dei privilegi clericali e il richiamo alla povertà evangelica e alla rinuncia al potere disturbava equilibri consolidati nella Chiesa.
La povertà evangelica e la rinuncia al potere, contrastavano e non poco con le strutture di potere e le ricchezze accumulate dalla Chiesa, che aveva sempre cercato di affermare la propria autorità anche a livello temporale.
Questo conflitto, pertanto, portava a una tensione tra il modello proposto dal Vangelo e la realtà della Chiesa come istituzione.
Da tenere, oltretutto, presente che, negli anni ’60 e ’70, parlare di “Chiesa dei poveri” o di “opzione preferenziale per i poveri” veniva spesso associato al marxismo o alle rivoluzioni sociali.
Dopo la fine del Concilio, molti dei promotori del movimento tornarono nei propri paesi e il gruppo non riuscì a mantenere un’organizzazione stabile. Non nacque un vero “movimento ecclesiale” globale strutturato su queste basi e, pertanto – diciamolo pure – si sciolse.
Il movimento, tuttavia, influenzò fortemente la Teologia della Liberazione, sviluppatasi in America Latina, che parlava di un nuovo tipo di peccato, quello “sociale”, dal quale non era possibile liberarsi con la confessione e la penitenza, ma soltanto attraverso la giustizia, non quella divina ma quella degli uomini, che dovevano avere una vita degna su questa terra.
Paolo VI (1963–1978), successo a Papa Giovanni, non prese una posizione netta contro la Teologia della Liberazione. Accolse con attenzione il desiderio di giustizia sociale, ma mise in guardia contro il rischio di politicizzare il Vangelo.
Essa fu duramente criticata e, in parte, repressa dal Vaticano, soprattutto durante i pontificati di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, per il suo presunto legame con ideologie marxiste.
Giovanni Paolo II (1978–2005) fu il papa più critico verso la Teologia della Liberazione.
Egli, provenendo dalla Polonia comunista, era molto sensibile al rischio dell’influenza marxista.
Nel 1984 e 1986, sotto la guida del cardinale Joseph Ratzinger (poi papa Benedetto XVI), la Congregazione per la Dottrina della Fede pubblicò due istruzioni: “Libertatis Nuntius” (1984), in cui condanna della teologia della liberazione nelle sue versioni ispirate al marxismo e “Libertatis Conscientia” (1986): nella quale ha riconosciuto gli aspetti positivi (impegno per la giustizia), ma ha ribadita la necessità di rimanere fedeli alla dottrina cattolica.
Da allora l’idea della Chiesa dei poveri è rimasta nascosta nelle pieghe della coscienza di alcuni cristiani.
E’ riemersa, improvvisamente con forza nel pontificato e nella viva testimonianza di Papa Francesco, che ha ripreso molti dei temi del Patto delle Catacombe: semplicità, vicinanza ai poveri, riforma della curia, rifiuto del clericalismo.
Papa Francesco ha ripreso e reinterpretato in modo molto chiaro lo spirito del Patto delle Catacombe e della Chiesa dei poveri in diversi aspetti del suo pontificato e ha posto i poveri al centro della missione della Chiesa, con parole e gesti.
Fin dal primo giorno del suo pontificato, ha scelto, infatti, uno stile sobrio e non cerimonioso; ha rifiutato l’appartamento pontificio, vivendo nella Casa Santa Marta; ha rinunciato a simboli di potere come la croce d’oro o le scarpe rosse papali; si è presentato come “vescovo di Roma” piuttosto che come “Papa” nel senso più solenne del termine.
Papa Francesco, inoltre, ha denunciato spesso il clericalismo come una delle principali malattie della Chiesa “Il clericalismo è una perversione” – ha detto più volte.
Ha avviato una riforma della Curia per renderla più snella, missionaria e decentrata, coerente con la visione di una Chiesa “in uscita”:
Le sue encicliche, specialmente: “Evangelii Gaudium (2013)”,Laudato Si’ (2015)” ,” Fratelli Tutti (2020)” , hanno offerto una visione profetica e sociale del Vangelo, parlando di giustizia, ambiente, fraternità e cura dei più deboli. Sono testi che traducono in termini attuali lo spirito della Chiesa dei poveri.
Nel 2019, durante il Sinodo sull’Amazzonia, un gruppo di vescovi ha rinnovato il Patto delle Catacombe per una “Chiesa dal volto amazzonico e povera”, e Francesco ha appoggiato con favore l’iniziativa, anche se non ufficialmente.
È un segno che quel sogno conciliare non è stato mai dimenticato.
Cosa succederà con il prossimo pontefice che verrà fuori dal conclave che si aprirà il prossimo 7 maggio? Il sogno di una Chiesa dei poveri continuerà a essere una realtà? Una cosa sembra certa: molti pensano o sperano che la Chiesa non può tornare indietro ma porterà a compimento la rivoluzione iniziata da Papa Bergoglio.