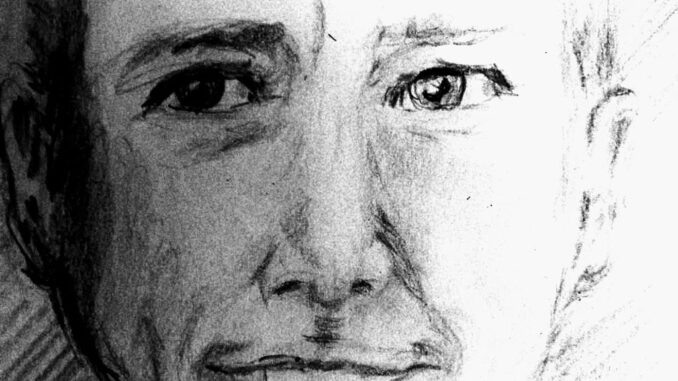
di Davide Romano
Nel silenzio dei conventi e nel frastuono delle città, i Frati Minori Conventuali continuano a custodire l’eredità di San Francesco con l’arte più difficile: restare umili tra gli uomini, poveri ma non fuggitivi, fedeli senza clamore.
Non tutti i santi hanno avuto la fortuna di essere compresi dai loro discepoli. E non tutti i discepoli hanno avuto la forza di capire fino in fondo il maestro. San Francesco d’Assisi, che voleva soltanto “vivere il Vangelo sine glossa”, si ritrovò dopo pochi anni con una famiglia spirituale già divisa: chi voleva restare scalzo per le strade e chi, invece, capì che anche dietro le mura di un convento poteva nascondersi una povertà più autentica. Di questi ultimi sono figli i Frati Minori Conventuali, i “minori” che non se ne andarono nei boschi, ma decisero di restare tra le pietre delle città.
C’è in questo un paradosso tutto francescano. Francesco aveva mal sopportato i chiostri, eppure i suoi seguaci più fedeli capirono che, per custodire il seme gettato dal poverello, bisognava anche proteggerlo dal vento. I Conventuali furono, in un certo senso, i giardinieri della pianta francescana: meno romantici, più concreti, ma capaci di farla fiorire nei secoli. Mentre gli altri camminavano per le strade polverose, loro costruivano biblioteche; mentre qualcuno predicava ai passeri, loro insegnavano ai chierici. E così, senza far rumore, divennero una delle colonne portanti della Chiesa d’Occidente.
Il nome stesso li tradisce: “Conventuali”, cioè legati al convento, alla comunità stabile, alla casa che non si abbandona. Non era una rinuncia alla povertà, ma un modo diverso di declinarla. La loro povertà non era quella dell’eremita, ma del cittadino: sobria, laboriosa, quotidiana. Vivevano tra la gente, non per confondersi con essa, ma per servirla meglio. E quando la storia — quella con la “S” maiuscola — decise di farsi turbolenta, loro restarono. Restarono nelle città assediate dalla peste, nelle università inquiete del Medioevo, nei confessionali delle grandi basiliche. Sempre con il saio grigio, i sandali consumati e un sorriso che non faceva proselitismo ma compagnia.
Fu nel 1517 che il Papa, stanco delle dispute interne al movimento, decise di mettere un po’ d’ordine. Nacquero così ufficialmente le due famiglie: gli Osservanti, custodi del rigore originario, e i Conventuali, custodi dell’equilibrio. E se i primi scelsero la via dei boschi, i secondi restarono a presidiare i crocicchi del mondo. La storia, in fondo, ha bisogno di entrambi: dei profeti che gridano nel deserto e dei monaci che traducono il loro grido in catechismo.
Chi passa oggi da Assisi, o da Padova, o da ogni città che abbia avuto la ventura di ospitare un convento francescano, incontra ancora i figli di quella scelta. Sono uomini semplici, che non fanno notizia e non cercano applausi. Hanno l’aria di chi ha visto tutto e non si stupisce più di nulla, ma continua a credere che la bontà valga la pena anche quando non rende. Li riconosci perché parlano piano, camminano piano e sorridono piano. Sono, come direbbe Montanelli, “italiani all’antica”: un po’ sognatori e un po’ contabili di anime.
Hanno educato generazioni di studenti e accolto eserciti di poveri. Hanno costruito scuole, ospedali, oratori, e ancora oggi li trovi con la scopa in mano o il computer acceso, secondo le esigenze dei tempi. Non hanno mai avuto il fascino ruvido dei Cappuccini, né la fama romantica degli Osservanti. Ma forse proprio per questo sono rimasti fedeli al Vangelo più di molti altri: perché non hanno mai sentito il bisogno di dimostrarlo.
Eppure, dietro la loro modestia, si nasconde una storia di grandezza. Furono loro, i Conventuali, a custodire il corpo di San Francesco nella cripta di Assisi, quando le liti tra i rami dell’Ordine rischiavano di trasformare la tomba del Santo in un campo di battaglia. Furono loro a edificare e custodire la Basilica di Sant’Antonio a Padova, divenuta un faro di devozione popolare e di cultura teologica. Furono loro a partire come missionari verso l’Oriente e il Nuovo Mondo, con lo stesso saio e la stessa certezza: che la povertà evangelica non è fuga dal mondo, ma dono al mondo.
Il loro segreto è stato, ed è, l’equilibrio. Una virtù rara, che oggi sembra perfino sospetta. Vivere in città senza diventare cittadini del potere; servire la Chiesa senza restarne prigionieri; studiare senza inorgoglirsi del sapere: questa è la loro santità quotidiana. San Francesco li avrebbe forse rimproverati, ma poi — conoscendolo — li avrebbe abbracciati. Perché, dopotutto, anche lui sapeva che la grazia non si misura dalla quantità di fango sui sandali.
I Conventuali non predicano crociate, non scrivono trattati di morale, non fanno proclami. Fanno qualcosa di più difficile: restano. Restano nei luoghi dove gli altri passano. Restano accanto ai malati, ai ragazzi inquieti, ai fedeli che non sanno più pregare ma entrano in chiesa per caso. Restano con il silenzio delle loro preghiere, che è il contrario del silenzio sterile del mondo.
Nel secolo dei social, in cui ognuno grida per essere notato, loro continuano a parlare sottovoce. Non cercano like, ma confessioni. E quando ti salutano con quel “Pace e bene” che sembra una formula di altri tempi, capisci che c’è ancora speranza: che in mezzo alla confusione della modernità sopravvive una razza di uomini che non hanno bisogno di vincere per avere ragione.
I Frati Minori Conventuali sono, insomma, l’altra faccia del miracolo di Assisi: quella che non fa notizia ma dura. Non hanno inventato la povertà, ma l’hanno organizzata. Non hanno gridato la fede, ma l’hanno vissuta. E forse per questo, dopo otto secoli, la loro voce si sente ancora, limpida e discreta come il suono di una campana al tramonto.
In un mondo che cambia ogni cinque minuti, loro restano lì: un po’ anacronistici, un po’ fuori moda, ma ostinatamente fedeli a un ideale che non invecchia. Ed è difficile non provare per loro quella simpatia che Montanelli riservava ai perdenti di lusso — quelli che non hanno mai smesso di credere nell’uomo, pur conoscendolo troppo bene.



