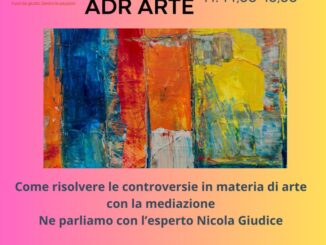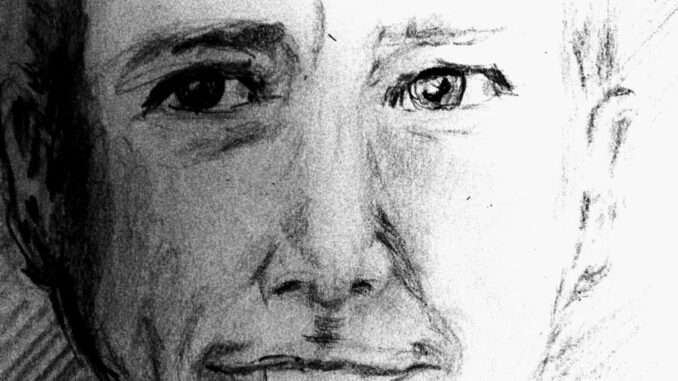
di Andrea Filloramo
A chi, scrivendomi, chiede se è vero che, nella pratica religiosa dei cattolici, la fede si accompagna sempre alla superstizione, rispondo che prima di trattare un tema così importante nella Chiesa Cattolica, occorre separare la fede dalla superstizione, in quanto chi mi scrive fa riferimento a concetti che afferiscono a due ambiti completamente diversi fra loro.
Affermo, innanzitutto, che la fede, correttamente intesa e vissuta, è credere a realtà invisibili, ma che sono fondate e nutrite da una costante e sincera ricerca razionale, che non vede contrasti nell’affidamento che l’uomo fa di se stesso ad un Essere Superiore.
La superstizione, invece, abbraccia l’irrazionale ed ha a che fare con l’ignoranza e con un concetto fondato sul sentimento e sulla paura che qualcosa possa accadere, particolarmente sul desiderio di stornare da sé un fatto ritenuto pernicioso. E’ vero che la superstizione si può anche ritenere una fede, che, però, è solo istintiva, ciecamente seguita da quanti si affidano a presunti poteri di oggetti e feticci delle sottoculture superstiziose, simboli di ataviche credenze.
Ciò perché nessuna superstizione cristiana tutt’oggi praticata nella Chiesa è, infatti, da considerare totalmente inedita, ma – come risulta da alcune ricerche moderne – è frutto di plagio, di travestimento e di appropriazione dell’antica mitologia classica, pagana, una “pia fraus”, cioè un “pio inganno” come la definisce Deschner ( Il gallo cantò ancora, Massari 1998).
Da sempre si ripetono, con o senza l’approvazione della Chiesa, le formule per risolvere i problemi della vita, espressioni di una religione dei “rimedi immediati”, in cui i fedeli considerano Dio come un farmacista e il prete come un medico di turno, dove con un po’ di preghiera per la salute, una benedizione per il lavoro, una novena per l’amore, un santino contro l’ansia, essi cercano sollievo e cercano di curare un sintomo. La fede diventa, perciò, per loro un pronto soccorso dell’anima. Il loro obiettivo non è, perciò, la conversione, ma soltanto la stabilizzazione emotiva.
Ciò è comprensibile; viviamo, infatti, in un’epoca di fragilità diffusa, solitudini e ansie che chiedono balsami rapidi di libertà, ma il cristianesimo, quello autentico, non promette guarigioni, promette resurrezioni e passa sempre dalla croce. Per questi motivi, il prete di oggi da tanti non è visto come un pastore, ma come un operatore che gestisce parole e riti come strumenti tecnici del potere clericale, per il quale la comunità diventa il pubblico, la liturgia diviene spettacolo e il Vangelo solo scenografia.
Il risultato è quello di una fede infantile, che non interroga e non cambia proprio nessuno.
Da tenere presente che, intorno a questo concetto, gira anche una fiorente economia, in cui le reliquie itineranti, i cadaveri mummificati creduti incorrotti, i ceri “miracolosi”, i gadget religiosi, i pellegrinaggi a tema, le madonne che piangono sangue, creano un mercato nel quale la grazia diventa un prodotto solo simbolico e il prete diviene un mediatore privilegiato.
A questo fenomeno, la Chiesa – è bene dirlo – mostra di non avere la forza di opporsi e, pertanto, si limita soltanto a incoraggiare le persone a una fede più profonda, dicendo loro che l’incontro con Dio offre una salvezza e una verità più grandi di quelle che si possono ottenere attraverso tali credenze. Dinnanzi a tutto ciò, essa, quindi, preferisce tacere; a volte, incassa e così il cattolicesimo si trasforma in un mix di consumo spirituale e folklore benedetto.
E i vescovi che dovrebbero essere i “guardiani” della fede, cosa fanno? La risposta a questa domanda non è facile. Diciamo soltanto che in molti casi essi osservano con distacco, tollerano la ritualizzazione e la spettacolarizzazione della fede senza intervenire; a volte prendono parte e solennizzano così le celebrazioni approvando, così, con la loro presenza e partecipazione, ciò che dovrebbero vigilare; altre volte, infine rimangono silenziosi.
Quando intervengono, l’intervento è spesso timido e formale, limitato a note o circolari che non scalfiscono il fenomeno. Il loro messaggio, quindi, rimane ambiguo e, pertanto, il clero si sente autorizzato a continuare e i fedeli a ricevere via libera alla religiosità delle grazie e dei miracoli garantiti.
Così, il ruolo dei vescovi — custodi della coerenza della Chiesa — appare debole, lontano e a volte complice, ma la responsabilità istituzionale non può limitarsi, però, a osservare: serve sempre una guida che ristabilisca l’equilibrio tra rito e Vangelo, fra il gesto e conversione.
Lo sappiamo che la vera alternativa è scomoda: una fede che non promette miracoli, ma conversione, che non risolve, ma accompagna, che non funziona come un incantesimo, chiede libertà, fatica e pensiero.
Concludiamo dicendo che Dio non è né può essere visto come un amuleto, ma è un mistero da incontrare. Finché la Chiesa promette protezione invece di libertà, Dio resterà solo una fiaba devota — raccontata bene, ma senza verità.