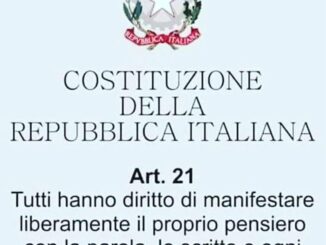di Roberto Malini
La città di Pesaro, affacciata sull’Adriatico e protetta dal Parco San Bartolo, custodisce una biodiversità sorprendentemente ricca. È un patrimonio silenzioso, spesso invisibile agli occhi frettolosi, ma tenace e profondamente radicato nei boschi, nei fossi, nelle aree agricole e persino nei margini urbani. In poche decine di chilometri quadrati convivono mammiferi, uccelli, rettili, anfibi, insetti e molluschi che condividono la stessa fragile promessa di sopravvivenza. Eppure, questa ricchezza naturale è oggi minacciata dalla cementificazione progressiva, dall’uso indiscriminato di sostanze chimiche, dall’inquinamento dell’aria e delle acque e da una gestione del territorio spesso più orientata al profitto che alla tutela dei suoi abitanti non umani.
A Pesaro vivono e si riproducono specie che altrove stanno scomparendo. Nei campi e nei margini boscati si muovono volpi, ricci, tassi, faine, mentre nei corsi d’acqua trovano rifugio piccoli anfibi come ululoni, raganelle, tritoni crestati. Il cielo è attraversato da bianconi, falchi pecchiaioli, gabbiani reali, aironi, mentre tra i rami si posano picchi verdi, capinere, cinciallegre e un’infinità di passeriformi migratori.
Le dune costiere, antiche custodi di un equilibrio delicato, ospitano orbettini, lucertole campestri, gechi, insieme a una miriade di insetti impollinatori: api selvatiche, sirfidi, farfalle, coleotteri, tutti protagonisti silenziosi degli ingranaggi della vita.
E poi ci sono loro, i molluschi terrestri, piccole meraviglie elicoidali spesso ignorate, ma indispensabili per la salute del suolo e il riciclo delle sostanze nutritive.
È proprio su un vecchio muro calcareo, vicino al litorale pesarese, che avviene l’incontro. Una creatura minuscola, quasi un sussurro minerale, ascende lentamente la superficie rugosa della parete bianca, come se stesse seguendo una mappa invisibile. La sua presenza non colpisce per la grandezza, ma per la perfezione geometrica racchiusa nel guscio: una spirale conica, composta da giri regolari che sfumano dal crema al bruno, come un microcosmo dipinto da un artista attento alle proporzioni. Passeggiando con amici, ho incontrato una piccola chiocciola del genere Cochlicella, più precisamente una Cochlicella acuta, specie tipica delle zone costiere e dei terreni calcarei dell’Adriatico. La sua conchiglia allungata, alta circa un centimetro, termina in un apice sottile; le fasce spirali bruno-rossicce raccontano la sua crescita in anelli biologici, come gli anni di un albero.
Dal punto di vista scientifico, questa specie appartiene alla famiglia Geomitridae, un gruppo di gasteropodi terrestri adattati ad ambienti aridi e assolati.
La Cochlicella acuta possiede particolari strategie evolutive: può estivare fissandosi a superfici esposte, chiudendo l’apertura con un sottile epifragma calcifico per trattenere l’umidità; si nutre di microrganismi, alghe epilitiche e residui vegetali, contribuendo alla pulizia naturale delle superfici; è sensibile ai cambiamenti del microclima, diventando un piccolo ma preciso indicatore ecologico.
Nella sua lentezza meditativa, la chiocciola racconta una storia di resistenza: sopravvive dove l’uomo porta calce, cemento, rumore, industrie inquinanti. In tali difficoltà, la Cochlicella colonizza spazi verticali e aridi trasformandoli in habitat improvvisati; ricorda che, anche in una città frenetica, la vita continua a reclamare i suoi margini. Questa ricchezza, però, non è garantita.
Gli stessi muri che oggi ospitano microhabitat possono domani essere ricoperti da vernici impermeabili o abbattuti per lasciare spazio a nuove costruzioni.
Le sostanze chimiche disperse nei campi e tra le aiuole— erbicidi, pesticidi, diserbanti — riducono drasticamente la presenza di insetti e molluschi, interrompendo catene alimentari essenziali.
L’inquinamento dell’aria e del suolo altera il pH delle superfici, corrodendo gusci delicati come quelli delle chiocciole e avvelenando i terreni dove vivono gli anfibi.
Ogni nuova colata di cemento, ogni intervento di “pulizia” non ecologica, può rappresentare la perdita di decine di microhabitat, spesso invisibili ma cruciali.
Pesaro possiede una biodiversità straordinaria, un equilibrio di forme di vita che vive accanto a noi, spesso senza che ce ne accorgiamo.
L’incontro con una piccola chiocciola su un muro calcareo, vicino al mare, è il simbolo di questo intreccio di fragilità e resistenza.
Proteggere questo patrimonio significa ridurre l’uso di sostanze chimiche, preservare aree naturali e corridoi ecologici, limitare la cementificazione, favorire una cultura di rispetto per ogni forma di vita, anche la più piccola.
Perché ogni guscio, ogni piuma, ogni zampa che sfiora il terreno racconta una parte della stessa storia, che è storia della nostra terra e prefigura il suo futuro.