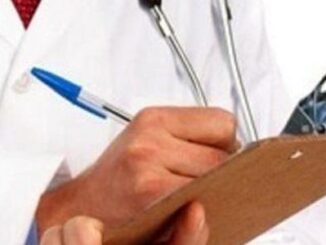di Davide Romano
Nelle democrazie mature — quelle vere, non le caricature che spesso ne scimmiottano i rituali — la libertà d’informazione non è un lusso da salotto né un accessorio di civiltà. È la spina dorsale che regge tutto il corpo istituzionale. Quando si piega o si corrompe, non è solo il giornalismo a morire: è la coscienza civile che s’inceppa, l’aria che si fa irrespirabile.
Prendiamo il caso — piccolo solo in apparenza — dell’ex presidente della Regione Siciliana, Rosario Crocetta, condannato in primo grado per diffamazione ai danni del giornalista Gregorio Arena. Una vicenda che, a prima vista, potrebbe sembrare uno dei tanti contenziosi giudiziari che punteggiano il paesaggio della nostra vita pubblica. Ma se ci si ferma un momento, si scopre che dietro la multa di 800 euro e la provvisionale da 20.000 mai versata, si nasconde qualcosa di più serio: la fragilità dell’equilibrio tra parola e responsabilità, tra diritto di critica e dovere di rispetto.
Crocetta, uomo di battaglie civili e polemiche feroci, in quella famosa puntata de L’Arena su Rai 1, si lasciò andare a dichiarazioni che il Tribunale di Catania — giudice Consuelo Corrao — ritenne lesive della reputazione professionale di Arena, allora in servizio presso l’Ufficio Stampa della Regione a Bruxelles. Parole, non colpi di pistola. Ma, come sapevano bene i vecchi cronisti, le parole sono proiettili che non tornano indietro.
Il giudice scrisse che quelle frasi contribuirono alla perdita dell’incarico del giornalista e alle difficoltà successive di reinserimento lavorativo. E qui si apre una ferita che non riguarda solo due uomini e una querela, ma un’intera categoria: quella di chi informa. Perché se un cronista, nell’esercizio del suo mestiere, diventa bersaglio di un potere politico che usa la parola pubblica come randello, allora la libertà di stampa non è più un diritto: è un rischio professionale.
Crocetta ha fatto appello. Ed è giusto: la giustizia non è infallibile, e l’appello è un pilastro dello Stato di diritto. Ma resta un fatto — direbbe Montanelli — che, a distanza di sei anni, la provvisionale non è stata versata. E in un Paese dove la memoria è corta, sei anni bastano perché l’opinione pubblica dimentichi, e la giustizia stessa si trasformi in un capitolo di archeologia giudiziaria.
Eppure, questa storia ci parla ancora. Ci dice che l’informazione, per essere libera, deve essere anche protetta. Non dalle leggi — che anzi la libertà di stampa la insidiano con troppa facilità — ma dal costume, dal senso civico, dalla coscienza collettiva. Ci vuole un popolo che capisca che la parola del giornalista non è un capriccio, ma un servizio pubblico. E che la diffamazione non è una semplice “scivolata verbale”, ma un colpo alla credibilità dell’informazione stessa.
Il giornalismo vive di fiducia, come la democrazia. Quando la fiducia si spezza, resta solo il rumore di fondo delle chiacchiere e dei processi infiniti. E allora la notizia, da strumento di conoscenza, diventa un’arma di vendetta.
A chi crede che queste siano quisquilie, basterebbe ricordare che la libertà di stampa non è mai stata concessa: è sempre stata conquistata. Ogni volta che un cronista viene colpito, anche solo verbalmente, un pezzo di quella conquista si sbriciola.
E forse, se Crocetta avesse pagato non solo la multa ma anche il prezzo morale delle sue parole, l’Italia — almeno la Sicilia — sarebbe oggi un po’ più vicina a quella democrazia dove il potere rispetta l’informazione, e l’informazione non teme di guardare il potere negli occhi.
Perché il vero scandalo non è una diffamazione in tv. È l’indifferenza che la segue.