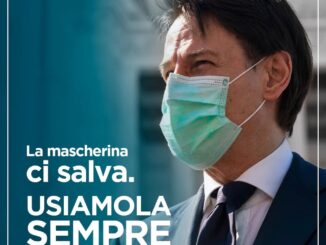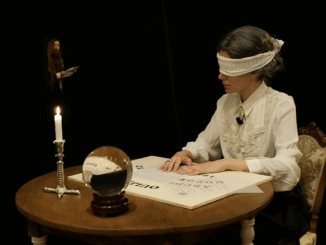di Andrea Filloramo
Nella storia della Chiesa, anche quella recente, il linguaggio e il metodo teologico del magistero papale hanno oscillato tra due poli: il “tomismo sistematico”, che ha dominato l’insieme delle dottrine filosofiche e teologiche sviluppate da San Tommaso d’Aquino (1224 e il 1225) e dai suoi seguaci, che mirano a sintetizzare la filosofia aristotelica con la teologia cristiana e che cercano di armonizzare la ragione e la fede, affermando che la ragione, pur avendo un suo ambito di validità, non è in contrasto con la verità rivelata dalla fede e la spiritualità di S. Agostino ( 354- 430), centrata sulla ricerca di Dio attraverso la contemplazione, l’esperienza interiore, il primato della grazia, la preghiera, l’ascolto della Parola e la condivisione della vita, con un forte accento sulla comunione fraterna e il servizio alla Chiesa.
Se bene osserviamo, infatti, Pio XII, con l’ enciclica “ Humani generis” (1950), ha ribadito la centralità del metodo tomista per difendere la dottrina contro le derive relativiste; Giovanni Paolo II, pur essendo aperto a correnti personaliste, ha mantenuto la struttura tomista, soprattutto in Fides et Ratio (1998), dove S. Tommaso è indicato come modello di equilibrio tra ragione e fede; Benedetto XVI ha combinato la teologia agostiniana (nella spiritualità e nella lettura della storia) con precisione dottrinale di matrice sempre tomista.
Oggi al soglio pontificio c’è Papa Leone XIV, che, da agostiniano, riporta Agostino al centro, non come antagonista di Tommaso, ma come voce necessaria in un’epoca segnata da crisi profonde, che possono portare a una perdita di significato, a un senso di vuoto interiore e a difficoltà nel trovare uno scopo nella vita.
Nel suo pontificato, il tomismo – ne siamo certi – stando ai suoi discorsi fatti da vescovo e cardinale, resterà un pilastro dottrinale, ma sarà l’agostinismo a dare il tono, lo stile e la direzione del cammino ecclesiale che egli intenderà dare.
In Leone XIV, da quel che sappiamo di lui, l’agostinismo non è un esercizio di erudizione ma ha un respiro a pieni polmoni: la sua teologia nasce dall’esperienza di statunitense, di nipote di emigrati, di prete, di missionario in una parte più povera del mondo. Per lui la Chiesa potrà camminare solo se partirà dal cuore e se la storia sarà letta con lo sguardo di chi sa che solo la grazia di Dio può salvare davvero l’uomo.
Egli non abolirà il tomismo, ma sposterà il suo baricentro; privilegerà l’esperienza interiore e la narrazione biografica rispetto alla definizione concettuale, insisterà sul fatto che ogni opera della Chiesa inizia dall’azione gratuita di Dio, più che da strategie pastorali.
Riprenderà, sottolineando il conflitto dietro le vicende politiche e sociali, la visione agostiniana delle due città, che, come si comprende, non sono città fisiche, ma concetti filosofici e teologici che rappresentano due modi di vivere e di amare. Sono la città terrena, guidata dall’amore per se stessi e dal desiderio di beni materiali, e la città di Dio, basata sull’amore per Dio e sul desiderio di beni spirituali.
Per convincerci di ciò è sufficiente rileggere la sua prima omelia da papa, quando egli citò l’incipit delle Confessioni di Agostino — “Ci hai fatti per Te, e inquieto è il nostro cuore finché non riposa in Te” — molti intuirono che il nuovo pontificato avrebbe avuto un respiro diverso. Non un ritorno nostalgico, ma una rilettura viva di Sant’Agostino per il XXI secolo. Molti capirono che egli non parla partendo da definizioni astratte, ma da esperienze concrete.
Nei suoi discorsi, la conversione personale è più importante di qualsiasi strategia pastorale. Basta pensare al fatto che spesso racconta episodi autobiografici, paragonandoli ai momenti di crisi e di rinascita di Agostino: la ricerca, lo smarrimento, l’incontro con Cristo.
Sotto il suo pontificato, molte celebrazioni papali saranno accompagnate dal canto: “chi canta prega due volte”, ritroveranno lunghi momenti di silenzio. Leone XIV, infatti, sostiene che “il silenzio è la grammatica di Dio” e invita a riscoprire la Messa come “luogo dove il cuore si lascia raggiungere”.
Ripete spesso che “nessuna riforma della Chiesa è possibile senza un cuore che si lasci toccare da Dio”. Non crede nelle sole ristrutturazioni organizzative: come Agostino, vede nella grazia preveniente l’inizio di ogni vera conversione.