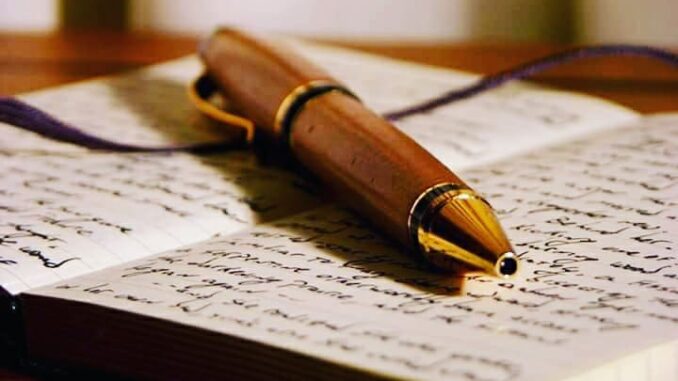
di Andrea Filloramo
Rispondo alla email (……@gmail.com ) che mi ha fatto molto pensare e riflettere, in cui una Signora mi scrive: “Sarebbe forse necessario, sapendo che la Chiesa è protetta dallo Spirito Santo e sa quindi come pubblicizzarsi e difendersi, non più scrivere su Papa Francesco o su Leone XIV come fa lei, ma, guardando in faccia la realtà internazionale e italiana, scrivere che andiamo verso il disastro, che non è assolutamente religioso, ma è voluto, anche in nome della religione, dal Presidente degli Stati Uniti. Ci rendiamo conto che il nostro Presidente del Consiglio e il suo governo stanno trascinando l’Italia nel burrone Trumpista?”
………………………………………………………………………………………
Ho cercato sempre nei miei scritti di evitare di essere attratto dalla contesa politico – partitica, che oggi è gestita da un sistema – che potremmo chiamare telecrazia – in termini di retorica o sofistica, che per questo diviene spesso incomprensibile a molti. Ma non ho potuto fare a meno di rispondere alla provocazione della mittente della email, facendo presente che esprimo solo pareri personalissimi.
Nella stagione delle leadership forti, delle identità gridate e delle promesse ipersemplificate, il rischio più grande non è solo la radicalizzazione del linguaggio politico, ma è lo svuotamento delle istituzioni, la corrosione silenziosa della cultura democratica, l’assuefazione al populismo come stile permanente di governo.
In questo senso, l’Italia non può permettersi di seguire la strada tracciata da Donald Trump, e nessuno a cominciare dal nostro Presidente del Consiglio, persona intelligente e capace, può diventare il suo emulo europeo.
Il contesto italiano – lo sappiamo – è diverso. Il nostro è un sistema parlamentare con un tessuto sociale e politico molto più articolato rispetto agli Stati Uniti.
Tuttavia, le tentazioni trumpiste possono esistere o sicuramente esistono anche da noi, e si manifestano nei segnali che vengono inviati in modo sempre meno ambiguo.
Il ricorso sistematico a una narrazione di “nemici interni” — le ONG, i magistrati “militanti”, i giornalisti “faziosi”, l’Europa “interventista” è un copione ben noto a chi ha studiato l’ascesa del trumpismo. Ed è un copione che funziona, perché semplifica, polarizza e mobilita.
Chiunque governa in Italia deve per molti versi essere una figura più disciplinata e meno caotica di Trump.
Ma l’ambiguità diventa evidente se, da un lato rassicura Bruxelles con toni moderati e gesti diplomatici, dall’altro alimenta nei suoi discorsi interni il risentimento sovranista, il culto della nazione, la logica dell’“uno contro tutti”.
È una doppia velocità politica che rischia di sfociare in un modello autoritario soft, in cui le forme della democrazia rimangono intatte ma la sostanza viene svuotata a colpi di slogan e decreti.
A questa ambiguità potrebbe aggiungersi un segnale economico tutt’altro che marginale: la simpatia per misure protezionistiche, come l’ipotesi di dazi difensivi su alcune filiere strategiche.
Anche qui si potrebbe intravedere l’ombra lunga del trumpismo, che ha fatto del protezionismo una bandiera ideologica prima ancora che una strategia economica.
Da osservare, però, che l’Italia non è l’America: la nostra economia è fondata sull’export, sulle catene del valore europee, su una fitta rete di interdipendenze che verrebbero colpite proprio da un ritorno al nazionalismo commerciale. I dazi, se pensati come strumento simbolico più che realistico, rischiano di diventare un boomerang retorico prima ancora che economico.
Ma ci potrebbe essere un aspetto ancora più inquietante, che non riguarderebbe le scelte politiche in sé, bensì il metodo con cui possono essere comunicate: lo stile menzognero, sistemico e ripetuto, che fa scuola con Trump e che potrebbe o già minaccia anche il dibattito pubblico italiano.
Quando si manipolano i dati, si falsificano i contesti, si creano nemici ad arte per coprire le proprie contraddizioni, non si è più nella sfera del conflitto politico legittimo: si entra nel terreno minato della distorsione deliberata.
L’uso delle fake news in chiave governativa, l’arte del dire e disdire, dell’insinuare e smentire a comando, mina la fiducia dei cittadini non solo nella politica, ma nella realtà stessa.
Sarebbero questi dei segnali preoccupanti: dalle narrazioni tossiche sull’immigrazione alle promesse economiche inconsistenti, fino all’uso selettivo dei numeri per alimentare un consenso fondato più sull’emozione che sui fatti.
Il punto critico non è la legittima esistenza di una Destra o anche di una Sinistra al governo: è la sua mutazione in un apparato personale, impermeabile alla critica e pronto a riscrivere le regole del gioco quando le istituzioni pongono dei limiti.
È accaduto negli Stati Uniti, dove Trump ha provato a ribaltare l’esito elettorale con menzogne e pressioni indebite. Accade ovunque il potere si chiude in se stesso e smette di ascoltare.
Non si possono rincorrere i fantasmi americani di un governo identitario e paranoico o dimostrare che è possibile governare con fermezza senza minare le fondamenta democratiche.
Uno Stato non ha bisogno di eroi solitari, ma di istituzioni forti, pluralismo, responsabilità. Scivolare nel burrone trumpista sarebbe un disastro.



