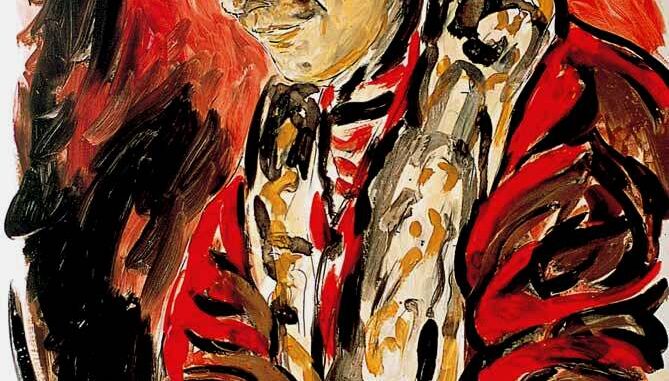
di Andrea Filloramo
L’abbiamo sentito più volte e non ci stanchiamo di ripetere che l’elezione di Leone XIV al pontificato ha acceso un entusiasmo straordinario perché il Papa non è solo il capo della Chiesa o il vescovo di Roma ma è il volto visibile della Chiesa universale. La sua figura unisce oltre un miliardo di fedeli e rappresenta continuità storica, unità spirituale e speranza in tempi molto complessi come sono quelli in cui noi viviamo e in cui il Papa svolge l’unica leadership spirituale alla quale in tutto il mondo fa riferimento.
Da evidenziare che, per i cattolici, il Papa, in quanto capo della Chiesa, coincide con l’immagine che egli attraverso gesti, parole, e stile personale – trasmette di sé, che incide profondamente sul modo in cui i fedeli percepiscono la fede e la comunità ecclesiale.
Dai viaggi di Giovanni Paolo II° alla teologia di Benedetto XVI e alla “vicinanza”, che è stata una parola chiave del magistero di Papa Francesco e, infine, alla “concretezza” di Papa Leone XIV, con cui ha ribadito più volte che “non basta una fede di parole ma serve che la fede trasformi la vita concreta, i comportamenti, le scelte difficili, i sacrifici”, ogni pontificato ha lasciato e continua a lasciare un’impronta specifica.
Karol Wojtyła ha incarnato l’energia di una Chiesa in uscita, cioè una Chiesa che non rimane chiusa nei propri confini, autoreferenziale o ripiegata sulla gestione interna, ma che sceglie di andare verso il mondo, incontro alle persone. Viaggiatore instancabile, capace di parlare ai giovani come alle folle oceaniche, ha offerto ai cattolici l’immagine di una fede vigorosa e combattiva. Per molti egli indubbiamente è stato un punto di riferimento morale e spirituale, ma la sua figura quasi “eroica” ha rischiato di apparire lontana dalle fragilità quotidiane, rese però evidenti nell’ultimo tratto della vita quando ha mostrato pubblicamente la malattia e la debolezza fisica e ha spezzato l’idea di un papato intoccabile o sempre forte.
Con Joseph Ratzinger l’immagine è cambiata radicalmente: meno piazze, più libri. Papa Benedetto si è presentato come maestro e custode della dottrina, conquistando chi cercava profondità intellettuale. Tuttavia, la sua figura riservata ha alimentato in parte l’idea di una Chiesa distante, più a suo agio nelle biblioteche che tra la gente, una Chiesa del dialogo più intellettuale che emozionale. I suoi interventi erano apprezzati dagli studiosi e da chi amava il rigore concettuale, ma meno immediati per i fedeli abituati a un linguaggio più semplice e diretto.
Con Jorge Mario Bergoglio la Chiesa ha ritrovato un volto semplice e popolare. Dal gesto di pagare il conto in albergo il giorno dopo l’elezione, alla scelta di vivere in Santa Marta, papa Francesco ha voluto mostrarsi pastore vicino, capace di usare parole comprensibili e di porre al centro i poveri e i dimenticati. Questo ha ridato fiducia a molti, ma anche – come sappiamo – ha suscitato critiche da parte di chi temeva un’eccessiva ambiguità dottrinale.
Con l’elezione di Leone XIV, la Chiesa sembra proseguire lungo la via di una comunicazione diretta, mediterranea, fortemente radicata nella pastorale. Il nuovo pontefice appare o è ritenuto come un uomo del popolo, capace di usare un linguaggio immediato e gesti quotidiani che parlano a tutti.
La sua è un’immagine calda e comunicativa che entusiasma molti, ma che con il suo linguaggio e i suoi gesti evidenziati o enfatizzati dai media dal primo giorno della su elezione, può correre il rischio di accentuare le divisioni tra chi considera il suo un ritorno alle radici e chi teme invece un eccesso di personalizzazione, con cui facilmente viene identificata la comunità ecclesiale con il Papa del momento.
Da rammentare che il Papa non parla mai a titolo privato: la sua parola, quando esercita il magistero, è radicata in una funzione istituzionale che lo lega non solo alla Tradizione ma al collegio dei vescovi e la sua autorità non dipende dalla simpatia o dal carisma personale, ma dal ministero che gli è affidato.
Se i fedeli percepiscono che il magistero o i gesti del Papa nascono più dalla sua sensibilità individuale che dalla Tradizione condivisa, allora la fiducia nella struttura stessa cala. Non è più “il Papa come successore di Pietro” che parla, ma “quel Papa lì con le sue idee personali”.
Ciò produce polarizzazione: chi si riconosce in lui cioè si sente rafforzato, chi invece non si riconosce si sente libero di contestarlo apertamente.
Normalmente i gesti simbolici del Papa sono pensati per rafforzare la comunione ma se percepiti come frutto di una linea personale, diventano occasione di conflitto e di delegittimazione.
La vera sfida è custodire la percezione che il magistero del Papa, pur passando inevitabilmente attraverso il suo stile personale, rimanga espressione della continuità non solo a parole della Chiesa. Quando manca questa percezione, l’autorità si indebolisce e il rischio è che la Chiesa si divida in “partiti papali”.
In sintesi: la forza del Papa non sta solo nel suo carisma individuale, ma nella capacità di far percepire che la sua voce personale è trasparente alla voce della Chiesa intera. Se questo equilibrio si rompe, l’autorità istituzionale viene percepita come fragile e la comunione si incrina.
Per attenuare il rischio della personalizzazione servono trasparenza, collegialità, comunicazioni strategiche e un lavoro continuo sul confine tra ministero e persona. In altre parole: si spera che lo stile comunicativo di Papa Leone XIX possa collocarsi su quel “confine vivo” dove la testimonianza personale e la funzione istituzionale si possano sostenere a vicenda.



