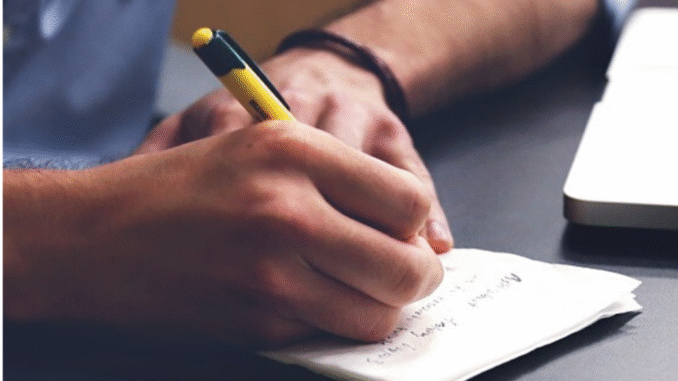
di Andrea Filloramo
Trasmetto e commento quanto contenuto in una email inviatami da un giovane lettore di IMG Press che non appartiene – come superficialmente qualcuno può dire – a una generazione perduta, ma una generazione che sta imparando a convivere con il dubbio; che non si accontenta delle vecchie certezze, ma cerca nuove forme di equilibrio, più autentiche, più umane. E in fondo, è proprio dall’incertezza che nasce il desiderio di costruire un futuro diverso.
Così, fra l’altro, egli mi ha scritto: “Sono stufo di leggere della Chiesa e dei Papi. C’ è qualche altro argomento che interessa di più un giovane come me (….). Fino a una certa età ho creduto a Dio e a quanto mi veniva insegnato durante le ore di religione della Scuola Elementare, della Media e del Liceo Classico in cui, però, mai gli insegnanti – preti e laici – hanno fatto, da quello che ricordo, riferimento alla Bibbia. Ciò fino a quando, durante il lockdown, un periodo buio per tutti, ho letto un libro, capitatomi per caso fra le mani, dal titolo “Il Dio alieno della Bibbia” di Mauro Bigino, nel quale si dice che nella Bibbia non si parla affatto di Dio, (…) E ’questa un’idea che tutt’ora non riesco ad abbandonare, a causa forse della mia ignoranza biblica, che poi forse è ignoranza di tanti. Quale è la sua opinione?”.
Capisco perfettamente il punto di vista e il disorientamento del lettore che ha seguito l’ora di religione fino al Liceo Classico e probabilmente dovrebbe avere una buona base culturale per sapere distinguere tra lettura storica, letterale e simbolica dei testi biblici. Talvolta, però, può non accadere. Nonostante, infatti, anni di insegnamento della religione cattolica a scuola (Elementari, Medie e Superiori) molti ex studenti hanno conoscenze religiose molto superficiali. Ciò perché spesso l’ora di religione è vista come poco impegnativa e gli studenti partecipano senza reale interesse.
L’insegnamento della religione cattolica, oltretutto, privilegia spesso riflessioni etiche o catechistiche, trascurando lo studio dei contenuti della storia in generale e tanto meno insegna come si fa l’esegesi biblica, che è sconosciuta anche da tanti preti. L’insegnamento della religione dovrebbe, perciò, diventare – come da tempo viene detto – una disciplina integrata con storia, arte, letteratura, filosofia e dovrebbe avere insegnanti preti o laici, preparati e capaci di rendere l’apprendimento più coinvolgente e completo.
Occorre, pertanto, sorpassare il problema dell’insegnamento della religione e andare – come richiesto – al problema sollevato dal lettore.
Diciamo subito che negli ultimi anni il nome di Mauro Biglino, autore di “Il Dio alieno della Bibbia”, titolo richiamato dal lettore, è diventato sinonimo di una lettura “eretica” della Sacra Scrittura.
Biglino sostiene che il testo sacro più letto al mondo non parli di Dio, ma di esseri molto più concreti: gli Elohim, cioè “una pluralità di entità fisiche e potenti, forse extraterrestri, che avrebbero avuto un ruolo nella creazione e nella storia dell’umanità”. E’ questa sicuramente una strana idea che affascina in quanto terreno fertile per le speculazioni, ma che nello stesso tempo divide. Da un lato milioni di lettori incuriositi da questa prospettiva chiamiamola pure “ufologica”, dall’altro biblisti, teologi e archeologi che bollano le sue tesi come fantascienza travestita da filologia.
Biglino parte da un presupposto semplice ma dirompente: occorre leggere la Bibbia “così com’è scritta”, senza interpretazioni teologiche. Nel testo ebraico – osserva – il termine Elohim è un plurale. Tradurlo come “Dio” al singolare, secondo lui, sarebbe un errore antico di secoli. Gli Elohim – afferma – erano esseri reali, forse provenienti da altri mondi, dotati di conoscenze e tecnologie che gli uomini del tempo non potevano comprendere.
In questa chiave, Yahweh – la divinità del popolo d’Israele – non sarebbe il Creatore universale, ma uno di questi esseri, un capo “locale” che si è scelto un popolo e ha imposto le proprie leggi.
I “miracoli” descritti nella Bibbia – come la colonna di fuoco, la nube che guida nel deserto o l’arca dell’alleanza ed altri miracoli – diventerebbero così descrizioni ingenue di fenomeni tecnologici.
Le reazioni del mondo accademico non si sono fatte attendere.
Linguisti ed esegeti, che analizzano criticamente i testi biblici per spiegarne il senso, ricorrendo a metodi scientifici e storici per chiarire il contesto di origine, le fonti e il messaggio, sottolineano che l’ebraico biblico è una lingua complessa, ricca di forme idiomatiche. Il termine Elohim – spiegano – è sì plurale nella forma, ma in molti contesti funziona come singolare e si riferisce chiaramente al Dio unico.
Lo stesso vale per i racconti miracolosi, che la maggior parte dei biblisti interpreta come narrazioni teologiche o simboliche, non come cronache di eventi fisici. Tuttavia, ci sono anche studiosi e tradizioni che insistono sulla letteralità dei miracoli biblici, sostenendo che finché il testo non indica chiaramente un’intenzione simbolica, va interpretato come evento storico.
Gli archeologi aggiungono che non esistono prove storiche di contatti extraterrestri nell’antichità, mentre gli studiosi di religioni vedono nei miti biblici un linguaggio comune a molte culture del Vicino Oriente. Il loro giudizio è netto: Biglino confonde mito, storia e tecnologia moderna, proiettando idee contemporanee su testi antichi.
Tra la teologia e le teorie ufologiche esiste una terza via, quella storico-critica laica, adottata da gran parte del mondo accademico.
Per gli studiosi di questo campo, la Bibbia è una raccolta di testi nati in contesti diversi, riscritti nel tempo per costruire l’identità religiosa e politica di Israele. Non è né un manuale scientifico né un diario di eventi, ma una testimonianza della storia, della cultura e della fede di un popolo.
In questa prospettiva, Elohim può essere inteso come un plurale di “divinità”, ma la progressiva affermazione del monoteismo trasforma Yahweh nel Dio unico. I racconti della creazione, del diluvio o dell’Esodo assumono valore simbolico e morale, più che fattuale. La Bibbia, insomma, è vista come un monumento della mente umana, non come un codice di verità soprannaturali o tecnologiche.
Per le fedi ebraico-cristiane – quindi anche per i cattolici – invece, la Bibbia resta la rivelazione di Dio. Per le due religioni, la lettura teologica accetta che i testi siano scritti in linguaggi antichi e culturali, ma ne riconosce un’unica ispirazione divina. I miracoli non sono scambi di fuoco o astronavi, ma segni della presenza di Dio; le genealogie e le leggi sono la storia di un popolo guidato verso la fede; e le immagini poetiche della Genesi non spiegano come nacque l’universo, ma perché esiste.
Mettendo a confronto le tre letture – quella materialista di Biglino, quella critica e storica degli accademici, e quella spirituale dei teologi – emerge un punto comune: il desiderio di capire chi siamo e da dove veniamo. Che si tratti di un Dio, di esseri venuti da altri mondi o di un’invenzione culturale, la Bibbia continua a essere il libro che più di ogni altro riflette la ricerca umana del mistero.
Concludiamo dicendo che le teorie di Biglino restano fuori dal perimetro della scienza e della teologia, ma forse hanno il merito di riaccendere la curiosità verso un testo troppo spesso dato per scontato. Forse la verità si nasconde nello spazio sottile che unisce fede, mito e immaginazione — lo stesso spazio in cui, da millenni, l’uomo cerca di dialogare con Dio.



