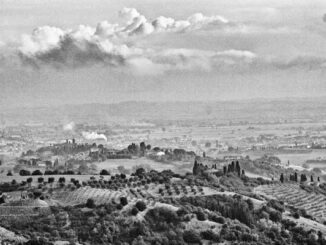CATANIA – «Le Ciminiere di Catania sono bruciate due volte: una nelle fiamme dell’11 novembre, l’altra negli occhi di chi, in quelle architetture, riconosceva un pezzo della propria identità». Così il presidente dell’Ordine degli Architetti di Catania Alessandro Amaro, commenta il vasto incendio che ha distrutto il teatro. «Per la comunità degli architetti, degli addetti ai lavori e di tutti coloro che alle Ciminiere hanno studiato, lavorato, vissuto eventi culturali, è un colpo profondo – continua Amaro – il centro fieristico e museale di viale Africa è, a pieno titolo, uno dei più importanti interventi di recupero e rifunzionalizzazione dell’archeologia industriale in Sicilia: nato sulle vestigia delle ex raffinerie di zolfo ottocentesche, trasformato in polo polifunzionale, spazio espositivo, sede di musei, luogo di memoria e di produzione culturale.
Al centro di questa storia c’è la figura dell’architetto Giacomo Leone, “padre” delle Ciminiere, che ha saputo fare di un relitto industriale una cattedrale laica del riscatto urbano: un ponte tra le zolfare dell’entroterra e una città che guardava al mare, allo sviluppo, al futuro. È lui ad aver immaginato un complesso aperto, permeabile: un sistema di spazi in cui il cittadino potesse camminare liberamente tra pietra lavica e mattoni, tra torri che svettano come segni verticali nel paesaggio e padiglioni che ospitano fiere, festival, mostre, musei. Il “cutilisci” – quel grande volume teatrale pensato come un sasso levigato dal mare, appoggiato con naturalezza nello skyline della città – era il cuore simbolico di questa visione: un luogo per lo spettacolo e l’aggregazione, dove architettura e ingegneria dialogano con la luce del Mediterraneo, con il vento, con il volo dei gabbiani. Da oggi quello stesso cuore è ferito, annerito, ma non muto.
Il dolore dell’architetto, oggi, è il dolore di una comunità intera. È la consapevolezza che è bruciato un pezzo di memoria condivisa: le Ciminiere come “dorsale della cultura”, come soglia tra città storica e città contemporanea. Ma la storia recente dell’architettura – da Notre Dame alla Fenice – ci insegna che gli incendi, per quanto devastanti, possono diventare soglie di trasformazione. Il rogo di Notre Dame, nel 2019, ha generato un intenso dibattito internazionale sulla ricostruzione, sulla responsabilità verso il patrimonio e sul rapporto tra conservazione, innovazione, sostenibilità. Da quella ferita è nato anche il concorso “Rethinking Notre Dame”, che ha invitato progettisti e studenti da tutto il mondo a immaginare scenari diversi. Perché conservare non significa semplicemente “rifare com’era e dov’era”, ma restituire senso ai valori spaziali e simbolici originari; sostenere significa usare tecnologie, materiali e strategie compatibili con le urgenze ambientali; installare significa aprire a nuovi usi, linguaggi, pratiche culturali che rendano vivo – e non solo “restaurato” – un luogo.
È a partire da queste tre parole – conservazione, sostenibilità, installazione – che oggi possiamo e dobbiamo ragionare su “Rethinking Le Ciminiere”. Non solo riparare il danno, ma trasformare questa emergenza in un’occasione collettiva per ripensare il ruolo del complesso nella vita urbana: la sua accessibilità, i suoi usi, la sua relazione con il sistema della mobilità pubblica, con il waterfront, con i poli culturali della città. In questa prospettiva si colloca l’iniziativa dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Catania che, su impulso del presidente Amaro, ha indetto una riunione aperta alla città per martedì 18 novembre, a partire dalle ore 16 (Largo Paisiello 5). Un momento di ascolto e confronto che vuole tenere insieme il dolore e il progetto: raccogliere il punto di vista dei professionisti e degli operatori culturali, ma anche quello dei cittadini, di chi alle Ciminiere ha legato momenti di vita personale, lavoro, studio, svago. L’idea è che la ricostruzione non possa essere solo un fatto tecnico o amministrativo, ma un processo pubblico, trasparente, partecipato. Come è accaduto per Notre Dame o per la Fenice, la forza di un simbolo architettonico sta nella sua capacità di generare appartenenza: un teatro, un complesso fieristico, un ex stabilimento industriale rigenerato sono “patrimonio” proprio perché raccontano, in forma costruita, la storia di una comunità e le sue aspirazioni future.