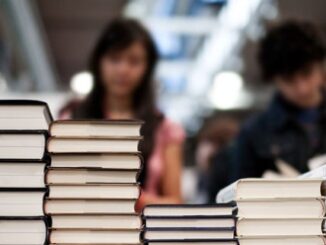“Credo nella forza delle persone e nella bellezza che resiste. La giustizia non si proclama: si esercita, ogni giorno, attraverso le scelte e la responsabilità di costruire un mondo più giusto e più umano”. La giustizia, come la democrazia, la libertà, la verità, l’informazione, sono parole semplici da pronunciare, ma complicate da spiegare. Ancora più complicata da spiegare è l’assenza di verità su certe tematiche. Noi ci proviamo raccontando la storia di una ragazza, una donna, una professionista: Margherita Serpi Balzano.
Margherita è una professionista impegnata nei percorsi di accoglienza e protezione delle persone rifugiate e richiedenti asilo. Coordinatrice di progetti SAI e programmi di accoglienza diffusa, gestisce équipe multidisciplinari e cura percorsi di autonomia, formazione e contrasto allo sfruttamento lavorativo. Continua a costruire ponti tra mondi e persone, promuovendo una cultura dell’accoglienza fondata su diritti, prossimità e responsabilità condivisa, in collaborazione con reti del Terzo Settore e organizzazioni nazionali.

Margherita, che ruolo hanno nella tua vita il coraggio, la temperanza, la sincerità e la giustizia? Come è nata questa missione per i diritti civili?
Il coraggio, per me, è scegliere ogni giorno di non voltarsi dall’altra parte. È la forza di restare in contatto con la complessità, anche quando spaventa o stanca. La temperanza è ciò che mi permette di non perdere equilibrio, di continuare a credere nel dialogo, nel lavoro lento e quotidiano che genera trasformazione reale. La sincerità è la base di ogni relazione autentica, con chi accogliamo, con i colleghi, con le istituzioni e soprattutto con noi stessi. È dire la verità, anche quando è scomoda. E la giustizia è la direzione: non un ideale astratto, ma un modo di stare al mondo. Il mio impegno nasce dal lavoro nei centri di accoglienza, dove ho incontrato volti, storie, mondi.. non numeri. In riferimento a quello di cui mi occupo, preferisco parlare di mobilità umana, non di “emergenza migratoria”: un fenomeno strutturale e globale che riguarda la nostra epoca, e che va affrontato con politiche di giustizia sociale e cooperazione, non con logiche di paura o controllo.
Credo che il vero coraggio oggi stia nel proporre visioni, non nel difendere confini.

C’è un popolo invisibile che vive tra di noi: persone italiane e migranti escluse dalla possibilità di iscrizione all’anagrafe. Cosa rispondi?
È una delle questioni più gravi ma meno discusse del nostro Paese: chi non può iscriversi all’anagrafe vive di fatto in una condizione di non-esistenza giuridica. Senza residenza non c’è medico, scuola, casa, accesso ai diritti fondamentali. Eppure, la legge italiana (nello specifico il regolamento anagrafico nazionale e il Testo Unico sull’immigrazione) stabilisce che chi risiede abitualmente in un territorio ha diritto all’iscrizione. Il problema è l’applicazione disomogenea, le prassi discriminatorie e una visione politica che tende a restringere, non ad ampliare. Dietro ogni persona “non iscritta” c’è una storia di esclusione amministrativa che diventa esclusione umana. Il terzo settore e le reti civiche locali svolgono un ruolo importantissimo nel colmare questi vuoti istituzionali: accompagnano, informano, costruiscono ponti dove lo Stato si ritrae. Ma non possono sostituirsi alle istituzioni. Servono norme chiare, volontà politica e una cultura dell’inclusione. Perché il riconoscimento anagrafico non è un favore, una concessione, ma un diritto: è il punto di partenza per esercitare la cittadinanza e per sentirsi parte di una comunità.
Perché chi governa teme gli immigrati? È un problema europeo o solo italiano?
La paura nasce da una narrazione distorta. Si continua a parlare di “crisi migratoria”, quando in realtà parliamo di mobilità umana: un fenomeno che riguarda milioni di persone e che l’Europa dovrebbe governare con strumenti di cooperazione, non di contenimento. Parlare di mobilità significa riconoscere competenze, persone, storie non categorie. Significa passare da una logica emergenziale a una visione di lungo periodo: spostare lo sguardo dal controllo alla cooperazione, dalla paura alla prospettiva. L’Italia, purtroppo, vive un paradosso: da un lato dipende dal lavoro delle persone in movimento, dall’altro continua a rappresentarle come una minaccia. L’Europa, invece, sta cercando, seppur con lentezza, di spostare il paradigma: le nuove strategie europee parlano di Skills Mobility, di Talent Partnerships, di percorsi circolari di crescita condivisa. Ma serve un cambio culturale prima ancora che politico: riconoscere che la mobilità umana è una risorsa, non un pericolo. È una chiave per ripensare il futuro dell’Europa come spazio di diritti, e non più di respingimenti.

Chissà quante storie e quante battaglie affrontate. Sono state più le gioie o le delusioni che hai dovuto metabolizzare?
Entrambe, e credo che servano tutte. Le gioie mi hanno insegnato che il cambiamento è possibile, che anche una sola persona che riesce a trovare casa, lavoro o semplicemente serenità dopo un percorso di accoglienza, è già un pezzo di mondo che si aggiusta. Le delusioni, invece, mi hanno costretto a crescere, a riconoscere i limiti del sistema e anche i miei. Ho imparato che non basta avere buone intenzioni: servono strutture giuste, reti solide, scelte politiche coraggiose. Lavorare nell’ambito della mobilità umana significa convivere con la frustrazione di vedere persone bloccate da burocrazie, leggi ingiuste o da una cultura che ancora diffida.
Ma significa anche essere testimoni quotidiani di resilienza e bellezza: ogni volta che qualcuno ricomincia, che trova una nuova lingua per raccontarsi o un posto in cui sentirsi a casa, capisco che ne vale la pena. Forse non è un lavoro che “salva il mondo”, ma è un modo per non smettere di crederci.
Una tematica molto sentita è sensibilizzare l’opinione pubblica sulla violenza contro minori e donne. Le donne in uscita da Centri antiviolenza e Case Rifugio vivono un percorso accidentato, fatto di ostacoli e difficoltà, che le espone a estrema vulnerabilità socioeconomica e al rischio di ricadere nella spirale della violenza. A che punto siamo? Cosa c’è ancora da fare per porre fine a queste tragedie? Qual è la paura maggiore delle persone al giorno d’oggi?

Siamo in un punto delicato: la consapevolezza sociale è cresciuta, ma la risposta strutturale è ancora troppo fragile. Le donne che escono da situazioni di violenza spesso si trovano di fronte a un deserto istituzionale — nessuna casa, nessun reddito, nessun lavoro, e a volte nessuna rete familiare o sociale. È qui che il rischio di tornare indietro diventa concreto. Per questo i percorsi di autonomia non possono essere considerati una fase accessoria dei programmi antiviolenza, ma la loro colonna portante: casa, reddito, formazione e accompagnamento psicologico devono camminare insieme. Serve un piano nazionale integrato, che metta in rete i Centri Antiviolenza, i Comuni, i Servizi sociali, il Terzo Settore e il mondo del lavoro. Non basta proteggere: bisogna ricostruire. La paura più grande oggi -nelle donne, nei minori, ma anche nella società- è quella della solitudine: la sensazione che, una volta usciti dal “sistema di protezione”, non ci sia nessuno ad accoglierti.
Porre fine alla violenza non significa solo fermare l’aggressione, ma restituire possibilità e dignità. E questo richiede politiche pubbliche lungimiranti, educazione alle relazioni e, soprattutto, una cultura che riconosca che la libertà di una donna è una questione di civiltà, non di fortuna.
Chiudiamo con una luce di speranza: tre cose che aiutano a far sorriderti, nonostante tutto e tutti?
Le persone che incontro nel mio lavoro, senza dubbio. Quelle che, nonostante la fatica, trovano ancora la forza di ripartire, di sognare, di scherzare, di giocare con me, di ringraziare anche solo per un gesto gentile. Sono incontri che lasciano il segno: mi nutro dei loro sorrisi, delle mani che si tendono, della dignità con cui affrontano la vita anche quando tutto sembra crollare. È in quei momenti che capisco che la speranza è contagiosa, che la luce si trasmette per prossimità. E poi il mare, senza dubbio. La sua grandezza mi ricorda che la vita è movimento: tutto scorre, cambia forma, e ciò che sembra perdita può diventare incontro. L’acqua insegna la fluidità, ma anche la profondità e il legame invisibile che unisce ogni cosa. Nell’acqua sento libertà, ma anche appartenenza: la certezza di essere parte di qualcosa di più grande, e questo pensiero mi consola sempre. Infine, la bellezza delle piccole cose, che piccole non sono affatto: un caffè condiviso, una risata sincera, la luce del sole.. È quella luce che mi restituisce energia e direzione, che mi ricorda che anche nei momenti più bui esiste sempre un punto da cui la vita torna a filtrare. Ho imparato che la felicità non è l’assenza di dolore, ma la capacità di continuare ad avere fiducia nella vita, negli altri, in noi stessi. Non come un atto di ingenuità, ma come una scelta consapevole. Perché possiamo sempre decidere da che parte stare: se restare chiusi o continuare ad aprirci al mondo.
Io scelgo la seconda. Sempre.