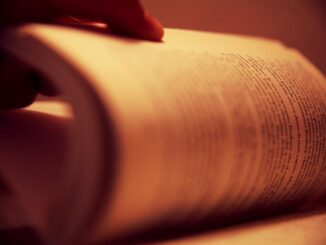Per capire lo spirito di Crociata non bisogna mai separare il “movimento” dall’”idea”. Non dobbiamo scindere tra storia del movimento e storia dell’idea. “L’idea sradicata dall’esperienza vissuta, diviene fatalmente un mito o utopia”, lo scrive il professore Roberto De Mattei (Il Domenicale, 9 luglio 2005, n. 28) E lo spirito di crociata che trasforma in esperienza vissuta. Sembra che l’abbiano capito gli studiosi anglosassoni che hanno colto la dimensione ideale e ideologica, forse meglio di alcuni storici di cultura latina. Allora perché le Crociate?
Intanto possiamo definire la crociata come una spedizione militare promossa e diretta dalla Chiesa, ma attuata da laici per difendere usque ad effusionem sanguinis, un bene di natura religiosa. Il primo elemento da prendere in considerazione è costituto dall’autoritas: solo la Chiesa interviene efficacemente nel reclutamento dell’armata attraverso la predicazione e lo strumento del “votum Crucem”, simboleggiato dalla croce imposta a tutti i fedeli e vi svolge un ruolo direttivo determinando fini e mezzi della spedizione. Il secondo elemento è costituito dal fine oggettivo della Crociata che non è di natura politica ma sempre di natura religiosa. L’intenzione religiosa rimane sempre anche se mutano gli interessi politici in campo. La Crociata si colloca nella categoria della “guerra giusta”, anche se qui bisogna distinguere dal fatto che la guerra giusta è generalmente condotta da un’autorità temporale per difendere un bene civile: per esempio, la libertà e l’indipendenza di un popolo.
Mentre la Crociata, pur attuata da laici, ha un fine religioso. La Chiesa considera l’esercito crociato come un esercito proprio, la cui suprema direzione appartiene al Papa che si fa rappresentare da un Legato, il quale accompagna le truppe. Il Legato Pontificio anche se non si deve mescolarsi personalmente alla guerra, per l’autorità ricevuta dal Papa, è il capo dell’esercito. Per De Mattei la Crociata è un’espressione storica di quel diritto della Chiesa a usare la forza materiale per conseguire il proprio fine soprannaturale. Nella Crociata la Chiesa è consapevole di esercitare la potestas gladii ecclesiastica. E’ un concetto perenne e non transitorio, destinato a costituire una dei pilastri dell’ordine giuridico cristiano.
Per il bene della Cristianità come ha sottolineato lo storico Hubert Jedin fu combattuta la battaglia di Lepanto. Anche se Papa Ghisleri non usa mai il termine Crociata. Ma la santissima expeditio da lui concepita e promossa nel 1570 corrisponde pienamente al concetto tradizionale di Crociata. Il fine dell’impresa non è politico, ma religioso, “El bien de la Cristianidad”, dice Papa S. Pio V all’ambasciatore spagnolo Zuniga. Nonostante a Lepanto il Papa non abbia inviato alcun Legato Papale alla flotta cristiana, egli, come sottolinea Jedin si è considerato il vero capo della Lega Santa, in quanto si sentiva ancora Capo della Cristianitas. La Lega, insiste Jedin, era concepita dal Papa come un’impresa di una crociata, un’idea di Crociata. Queste considerazioni secondo De Mattei si potrebbero estendere alla difesa di Vienna nel 1683 e alla riconquista di Buda promossa dal Beato Papa Innocenzo XI, successivamente nel 1686. Anche in questo caso, il fine attribuito all’impresa dall’autorità pontificia e gli effetti operativi che essa ebbe permettono di ricondurla alla categoria Meta-Giuridica della Crociata.
Un’ultima considerazione suggerisce il professore De Mattei, se la Crociata è stata considerata dalla Chiesa come una categoria permanente anche la risposta a questo appello può essere considerato una “permanente” categoria dello spirito”. “La Crociata è come il martirio – per De Mattei – una costante dell’animo cristiano. Nei crociati la prospettiva del martirio è insita nel signum super vestern, la croce sull’abito che attesta la loro disponibilità a versare il sangue in battaglia contro gl’infedeli”.
Pertanto, chiarisce il professore, “Se il martirio è l’atto con cui il cristiano è disposto a combattere fino a offrire la propria vita per il bene soprannaturale del prossimo”. Allo stesso tempo, si può sostenere che non è una categoria solo medievale, ma perenne. A fianco di questo studio, c’è una breva scheda di Marco Respinti sul pellegrinaggio, “storia e metafora allegorica”, che riprende l’affascinante e documentato libro di Franco Cardini, “Terrasanta. Pellegrini italiani tra Medioevo e prima età moderna (Il Mulino, Bologna; pp. 532; e 14,00) Il pellegrinaggio è un tratto identificante dell’antropologia del cosiddetto Medioevo. Un’altra scheda a margine, sempre di Marco Respinti riguarda i Cavalieri templari, poveri cavalieri di Cristo. Un tema che spesso ha subito abusi e menzogne. La ricerca storica ha acclarato l’infondatezza delle accuse di eresia che un tempo travolsero l’ordine. Per questo argomento Il Domenicale propone uno studio di Artura Iannaccone, “I Templari. Il martirio della memoria. Mitologia dei cavalieri del tempio” (Sugarco, Milano; pp.228 e. 18,00)
DOMENICO BONVEGNA
dbonvegna1@gmail.com