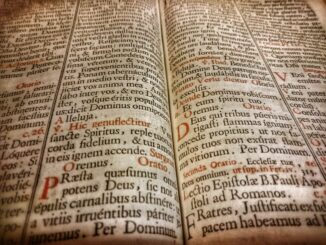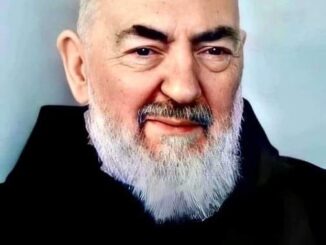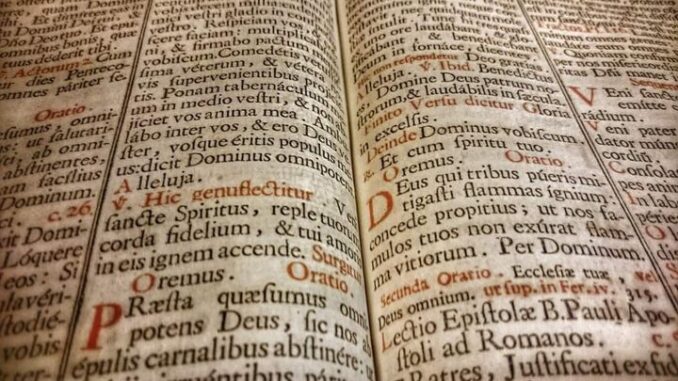
di Andrea Filloramo
Rispondo a un lettore di IMG Press, che mi scrive. “Premetto che sono stato in seminario negli anni della mia adolescenza dove ho toccato con mano che là e nella Chiesa in generale si respirava allora una pesante area, una cultura della segretezza e del silenzio che è difficile definire, della quale, però, molte cose si potrebbero dire. Pertanto, a suo parere, tale cultura è presente e si sente, ancor oggi, nella Chiesa, nelle diocesi, nelle parrocchie e nei seminari? A me pare proprio di si”.
Accolgo l’acuta richiesta del lettore di IMG Press e la trasformo in un’attenta riflessione, riconoscendo che il tema secolare della segretezza è ancora presente e domina nella Chiesa. C’è, cioè, ed è molto evidente una distanza percepita tra ciò che essa annuncia e ciò che pratica nelle sue strutture interne, che diventa riservatezza, silenzi, dinamiche di potere, linguaggi cifrati.
Questa “copertura” nasce da una cultura del segreto, ereditata dalla tradizione curiale, dove il “riservato” era sinonimo di prudenza, che oggi, però, appare come opacità; dal continuo timore dello scandalo, che porta a tacere o mascherare i problemi piuttosto che affrontarli alla luce del sole; dall’autoreferenzialità istituzionale, per cui le logiche interne e cioè: le carriere, gli equilibri, la fedeltà di gruppo prevalgono sempre sull’esigenza evangelica di verità e, infine, la spiritualità che viene anche talvolta deformata e che confonde la “discrezione pastorale” con la “segretezza difensiva”.
Gli ultimi Papi hanno cercato di scardinare questa mentalità, parlando di una Chiesa “trasparente come il Vangelo”. Ma la resistenza è stata e continua ad essere forte: la trasparenza tocca nervi scoperti, perché mette in crisi privilegi e sistemi consolidati.
Da evidenziare che la Chiesa vive del mistero di Dio, che è rivelazione e non è occultamento; è la soglia dell’incontro con il divino e non un velo posto per difendere l’istituzione. Eppure, nel linguaggio ecclesiale, il termine “mistero” viene deformato fino a coincidere con la “riservatezza” o la “discrezione”, diventando così giustificazione di una cultura della chiusura.
Dove il mistero è apertura al trascendente, la segretezza è chiusura difensiva: non protegge la verità, ma il controllo. Ne nasce un’abitudine spirituale che considera “giusto” non dire, non spiegare, non rendere conto.
Da ciò una certa mentalità che i preti apprendono già nei seminari, che sono, sì, luoghi del discernimento vocazionale, pensato come spazio di libertà interiore, che, però si trasforma e diviene un sistema di controllo delle coscienze. Il confine tra riserbo spirituale e la segretezza disciplinare in essi diventa labile e la formazione rischia di insegnare che la prudenza non è una virtù, ma un silenzio strategico.
Per tal motivo, la mancanza di trasparenza nella vita ecclesiale è spesso presentata come prudenza pastorale; quando, però, la prudenza serve a eludere il confronto, essa diventa autoimmunità morale. Si evita la correzione fraterna; si coprono gli errori “per non dare scandalo”; si alimenta la convinzione che i problemi vadano risolti “dentro”, “tra noi”.
In questo contesto, il silenzio non è più custodia della carità, ma forma di difesa. Il risultato è una comunità che si abitua a non dire, a non chiedere, a non rendere conto. Così la segretezza genera isolamento, e l’isolamento diventa terreno fertile per le logiche settarie e autoreferenziali. Chi, allora, appartiene al gruppo “sa”; chi è invece fuori deve soltanto “fidarsi”.
Ogni gruppo chiuso tende naturalmente a difendere se stesso. La dinamica è sempre la stessa e consiste nell’esclusione, che crea il “noi contro loro”; nel linguaggio interno, che distingue “chi capisce” da “chi non è dei nostri”; nella lealtà personale, che prevale sulla verità.
Nel clero, questi meccanismi possono manifestarsi sotto forma di piccole alleanze, rapporti di potere che si mascherano da fraternità.
Papa Francesco ha più volte insistito sul valore ecclesiale della trasparenza — non come esibizione, ma come forma di penitenza comunitaria. “La Chiesa — ha detto — deve imparare a farsi vedere per ciò che è, senza paura di mostrare le sue ferite: solo così il Vangelo può essere credibile”.
La trasparenza, in questa prospettiva, non è debolezza, ma atto di fede. È una Chiesa che non teme la verità, perché sa che il Vangelo non è un segreto da difendere ma una parola da donare. In questo senso, la trasparenza non è un atto amministrativo ma una conversione spirituale.
Essa comporta il passare dal “proteggere l’istituzione” al “testimoniare la verità”; dal superare la logica del “noi” contro “loro”; dal restituire ai laici spazi di corresponsabilità reale; da ripensare la formazione non come selezione, ma come crescita nella libertà.
Solo così la Chiesa potrà uscire dalle logiche settarie e tornare a essere ciò che è chiamata a essere: un corpo che vive nella luce di Cristo, dove nulla è da nascondere perché tutto è da offrire.
La Chiesa non è — e non deve mai diventare — una setta.
La differenza sta tutta nell’orizzonte che si pone: la setta si chiude per difendersi, la Chiesa si apre per annunciare. La prima costruisce muri identitari, la seconda ponti di comunione. Ogni volta che la comunità cristiana si ripiega su se stessa, cercando sicurezza invece di missione, tradisce la logica del Vangelo. Gesù non ha fondato un gruppo di eletti, ma una casa per tutti. ll clericalismo è la malattia di chi confonde il servizio con il potere.
Nasce quando il prete smette di essere pastore e diventa funzionario, quando la fede si riduce a gerarchia e il Vangelo a regolamento.
Superarlo non significa sminuire il ministero sacerdotale, ma restituirgli la sua verità evangelica: quella del servizio, non del privilegio.
Una Chiesa clericale parla di sé; una Chiesa evangelica parla di Dio e dell’uomo. Il clericalismo alimenta la distanza, il sospetto, l’immobilismo. La conversione passa invece per la prossimità, l’ascolto e la corresponsabilità dei laici. Solo così la Chiesa può tornare a essere ciò che veramente è: un popolo in cammino, non una casta in trono.
Essere Chiesa significa rimanere aperti, anche quando è scomodo, perché il Vangelo non si custodisce isolandosi, ma condividendolo. Quando la Chiesa dimentica questo, non perde solo la credibilità ma la sua stessa anima.