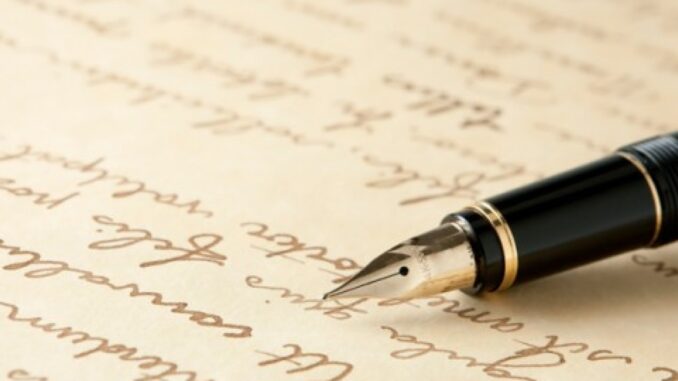
di Davide Romano
Settemila. Tanti sono, più o meno, i luterani d’Italia. Settemila in un paese di sessanta milioni di abitanti, sparsi da Trieste a Napoli come guardiani silenziosi di una tradizione che affonda le radici nel Cinquecento. Resistono, questi discendenti spirituali del frate tedesco che ebbe il coraggio di sfidare il Papa. E non solo resistono: prosperano, con quella dignità austera che è tipica di chi custodisce verità profonde.
La storia inizia, come tutte le storie che contano, con un gesto di ribellione. Era il 31 ottobre 1517 quando Martin Lutero, monaco agostiniano di Wittenberg, inchiodò alla porta della chiesa del castello le sue novantacinque tesi contro le indulgenze. “Quando la moneta nella cassetta risuona, l’anima dal purgatorio salta fuori”, scriveva sarcastico, prendendo in giro i mercanti di salvezza che facevano affari d’oro con la paura della dannazione. Il Papa Leone X non apprezzò l’ironia. Convocò il monaco, gli intimò di ritrattare. La risposta di Lutero passò alla storia: “Non posso né voglio ritrattare nulla, perché non è sicuro né onesto agire contro la coscienza. Dio mi aiuti. Amen”.
Bella risposta. Costò all’Europa tre secoli di guerre di religione, ma fu una bella risposta.
In Italia, naturalmente, i luterani arrivarono più tardi e con i piedi di piombo. Tra Inquisizione e Controriforma, professarsi protestanti da queste parti equivaleva a firmare la propria condanna a morte. Meglio aspettare tempi migliori. Che arrivarono con l’Unità d’Italia e le leggi liberali del nuovo Regno. Nel 1861, mentre Garibaldi conquistava il Sud, i primi pastori luterani attraversavano le Alpi con i loro libri di preghiere in tedesco e la ferma convinzione che “la fede sola salva”.
Oggi questi eredi del monaco ribelle si sono divisi in due correnti principali, ciascuna con la propria identità e missione. La Chiesa Evangelica Luterana in Italia, quella ufficiale riconosciuta dallo Stato nel 1961, rappresenta la componente maggioritaria: quattromila e cinquecento fedeli distribuiti in una rete che va da Trieste – dove già nell’Ottocento costruirono una chiesa neogotica che ricorda la Baviera – fino a Napoli, passando per Milano e Firenze. Proprio a Firenze, sul Lungarno Torrigiani, dal 1900 resiste una delle loro roccaforti più significative. La loro influenza si estende su Toscana, Emilia Romagna e Marche settentrionali: una repubblica spirituale nel cuore dell’Italia papale.
Ma è la Chiesa Luterana Confessionale d’Italia a rappresentare il cuore pulsante dell’ortodossia luterana nostrana. Questa comunità, piccola ma di straordinaria coerenza dottrinale, incarna alla perfezione lo spirito del monaco di Wittenberg. Fondata da luterani cechi che evidentemente trovavano l’Italia più ospitale della loro patria, la Confessionale non transige di una virgola sui principi della Riforma autentica.
I suoi pastori si muovono come missionari moderni attraverso la Penisola: da Padova a Piacenza, da Firenze a Roma fino a Salerno, portano con sé i testi sacri della tradizione e una fede granitica nel “Libro di Concordia” del 1580. Non possiedono cattedrali gotiche o campanili che svettano sui tetti delle città: si riuniscono in case private, salette parrocchiali, centri comunitari. Ma quando celebrano l’eucaristia, lo fanno secondo il rito che Lutero stesso aveva codificato, senza concessioni ai tempi moderni o alle mode teologiche.
“La Parola di Dio non può essere né legata né distrutta”, aveva proclamato il riformatore, e i confessionali italiani hanno fatto di questa frase il loro manifesto. Si sono assunti la missione di tradurre e diffondere in italiano i testi classici del luteranesimo: la Confessione di Augsburg del 1530, gli Articoli di Smalcalda, la Formula di Concordia. Per loro questi non sono documenti storici polverosi, ma guide viventi per la fede cristiana contemporanea. “Le Scritture sono chiare”, insegnava Lutero contro chi voleva interpretarle secondo le mode intellettuali. “Non hanno bisogno di essere illuminate dalla ragione umana, ma illuminano esse stesse la ragione”.
Organizzano convegni e seminari dove si approfondiscono ancora le sottili distinzioni teologiche che separavano Lutero da Zwingli sulla presenza reale nell’eucaristia. Questioni che ai più possono sembrare astratte, ma che per loro rappresentano il cuore stesso della fede cristiana. “Cristo ha detto: questo è il mio corpo”, ripetono citando il loro maestro. “Non ha detto: questo simboleggia il mio corpo”. È questa precisione dottrinale, questa fedeltà assoluta al testo originale, che distingue la Confessionale nel panorama protestante italiano.
Il pastore Idelmo Poggioli, figura di spicco del movimento, ha fondato comunità a Torre Annunziata, Torre del Greco e Santa Maria La Bruna. Nomi che suonano più napoletani che tedeschi, ma dove si predica la stessa dottrina che fece tremare i palazzi vaticani. Perché Lutero, oltre ad essere un teologo rivoluzionario, era anche un uomo di profondo buon senso. “Un cristiano è un uomo libero e padrone di tutto, e non è sottomesso a nessuno”, aveva scritto. “Un cristiano è un servo zelante di tutto, e sottomesso a tutti”. Paradosso apparente che nasconde una verità profonda: la vera libertà religiosa non è anarchia, ma responsabilità individuale davanti a Dio.
Sulla questione dei sacramenti, entrambe le correnti luterane italiane mantengono una posizione che è, in fondo, molto italiana: di equilibrio teologico. Cristo è presente realmente nel pane e nel vino dell’eucaristia, sostengono, distinguendosi sia dai cattolici (che parlano di transustanziazione) sia dai calvinisti (che considerano la comunione puramente simbolica). Una via media che Lutero aveva elaborato non per compiacere tutti, ma per restare fedele alle Scritture. “Cristo ha detto: questo è il mio corpo”, argomentava. “Non ha detto: questo rappresenta il mio corpo”.
La liturgia segue naturalmente le forme della Riforma. Niente santi, niente Madonna, niente Papa. Solo Cristo, le Scritture e la comunità dei fedeli. I pastori si sposano, predicano in italiano, amministrano battesimo e comunione secondo riti che risalgono al Cinquecento. Durante le celebrazioni risuonano ancora gli antichi corali tedeschi, “Ein feste Burg ist unser Gott” in testa: “Salda rocca è il nostro Dio”, l’inno che Lutero compose e che divenne l’inno della Riforma. Musica che evoca cattedrali gotiche e organi possenti, una fede austera ma non priva di gioia.
Perché Lutero, contrariamente a quello che si crede, non era un uomo cupo. “Il diavolo non sopporta la gioia”, diceva. E ancora: “Perché il diavolo, lo spirito della tristezza, non dovrebbe ridere quando riesce a rendere triste un cristiano?”. I suoi seguaci italiani hanno ereditato questo approccio: fede seria, ma non cupa. Dottrina rigorosa, ma non fanatismo. “La ragione è il più grande nemico della fede”, aveva sentenziato il monaco tedesco, ma intendeva la ragione superba, quella che pretende di spiegare i misteri divini. Non la ragione umile, quella che riconosce i propri limiti.
Il bello di questi luterani italiani è la loro sobrietà. In un paese dove tutti discutono di tutto, loro coltivano il silenzio fecondo della preghiera, celebrano con dignità antica, cantano i loro corali che profumano di Mitteleuropa ottocentesca. Predicano lo stesso messaggio che risuonava nelle chiese tedesche: la salvezza viene dalla grazia divina, non dalle opere umane. “Le opere buone non fanno l’uomo buono”, aveva scritto Lutero, “ma l’uomo buono compie opere buone”.
La Chiesa Confessionale, in particolare, rappresenta la coscienza critica del protestantesimo italiano. I suoi membri incarnano alla perfezione lo spirito del fondatore: custodi di un’ortodossia che non conosce compromessi, convinti che la verità sia un tesoro da preservare intatto attraverso i secoli. Partecipano al dialogo ecumenico, ma senza entusiasmi eccessivi. “Prima l’accordo sulla dottrina, poi la cooperazione pratica”, sembra essere il loro motto. Atteggiamento che può apparire rigido, ma che ha una sua logica profonda: non si può costruire l’unità cristiana su equivoci teologici. Lutero l’aveva capito bene quando rifiutò ogni compromesso: “La verità non si contratta”.
Il loro numero, settemila anime, può sembrare modesto nell’Italia di oggi. Ma Martin Lutero non si faceva illusioni sui grandi numeri. “Il mondo e la massa seguiranno sempre il diavolo”, diceva con realismo. “Tuttavia alcuni saranno salvati”. Questi alcuni, in Italia, continuano a trovarsi ogni domenica nelle loro chiese sparse dalla Venezia Giulia alla Campania, a leggere le Scritture in italiano e a ricordare che la fede, prima di essere questione di istituzioni, è questione di coscienza individuale.
“La fede è una cosa viva, audace”, aveva scritto il monaco di Wittenberg, “che muta l’uomo e lo fa rinascere”. Questi luterani italiani, nel loro piccolo, continuano a rinascere ogni domenica. Sono la prova vivente che in questo paese c’è ancora posto per chi la pensa diversamente in materia di fede. E che la Riforma non è mai finita: continua ogni volta che un cristiano decide di leggere la Bibbia con la propria testa, senza intermediari interessati.
Piccola comunità di fedeli coraggiosi, custodi di una tradizione che attraversa i secoli. Coraggiosi come il loro fondatore quando, davanti all’imperatore e ai principi tedeschi, rifiutò di ritrattare le proprie convinzioni. Persone che hanno preferito la verità alla convenienza, la coerenza al compromesso. In fondo, non è male come eredità spirituale. Anche se sono solo in settemila, più o meno.



