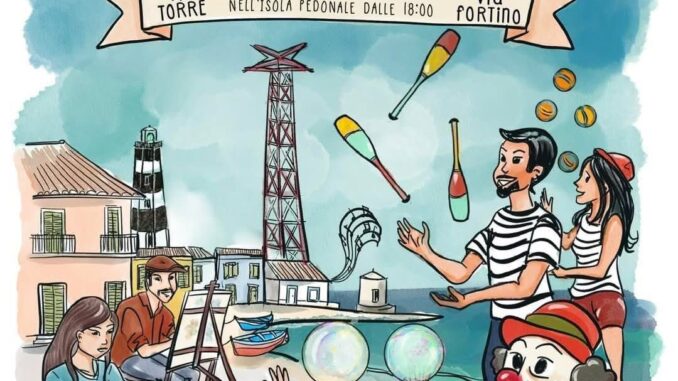
di Andrea Filloramo
La Sicilia è stata definita in molti modi: isola di luce, granaio d’Italia, scrigno d’arte. Ma una definizione, forse più cruda e realistica, accompagna da secoli la sua storia: terra di conquista.
Non esiste, infatti, regione italiana che abbia conosciuto un simile avvicendarsi di popoli e dominazioni. Greci, Cartaginesi, Romani, Bizantini, Arabi, Normanni, Svevi, Aragonesi, Spagnoli, Borboni, fino all’ingresso nel Regno d’Italia attraverso i Mille, capeggiati da Garibaldi, comandante autoritario e talvolta crudele, la cui leggenda romantica convive con episodi di violenza civile, repressione militare e responsabilità di massacri e il cui mito eroico è mitigato dalla memoria delle sofferenze e delle uccisioni, inferte ai siciliani. Tutti hanno lasciato il segno, politico e culturale, spesso anche traumatico. Per secoli l’isola è stata vista come bottino da controllare, terra fertile da sfruttare, posizione strategica da presidiare.

Oggi “terra di conquista” assume un senso nuovo. Non più eserciti, ma investitori e multinazionali che cercano di appropriarsi e di sfruttare le sue risorse, che non sanno o non vogliono sapere che il futuro della Sicilia dipenda dalla sua capacità di trasformare l’eredità di “terra di conquista” in orgoglio di identità plurale. Non più periferia da dominare, ma centro culturale e politico del Mediterraneo. Perché, come scrisse Goethe nel suo viaggio nell’isola, «L’Italia senza la Sicilia non lascia alcuna immagine nello spirito: qui è la chiave di tutto».

La storia insegna che ogni promessa di salvezza dall’esterno ha finito per lasciare all’isola più ombre che luci. Una cosa oggi deve essere certa: la Sicilia non ha bisogno di un nuovo Garibaldi, che l’introduca nella modernità, deturpando un territorio e che, in nome e per conto della grande imprenditoria internazionale e in combutta con quella del Nord, prometta di unire la Sicilia con la penisola, attraverso il Ponte sullo Stretto, un’opera immaginifica colossale, che viene presentata come svolta epocale, ma che è l’ennesimo simbolo di una politica che guarda al Sud come a una terra da conquistare, non da ascoltare.
È Salvini, il nuovo Garibaldi, leghista, del Nord, fino a qualche tempo fa nemico e ostile nei confronti del Sud, a intestarsi (è questo il paradosso) un progetto risalente ad anni addietro, come se la Sicilia non abbia altre priorità se non un collegamento spettacolare con la Calabria.

Da decenni si parla di questo fantasioso Ponte come di un’opera “faraonica”, simbolo di modernità e ambizione. Ma dietro l’eco dei cantieri, che invaderanno una buona parte dell’isola, rendendola per molto tempo invivibile e dei numeri da capogiro, resta una domanda fondamentale: il Ponte aiuterà davvero la Sicilia?
Sappiamo soltanto che costi astronomici, rischi sismici e impatti ambientali enormi trasformeranno questo progetto in una vetrina di cemento più che in un volano concreto per l’economia locale, un monumento alla grandezza senza concretezza, lasciando la Sicilia esposta ai problemi di sempre, anzi aumentando – e non di poco – la precarietà.

E’ indubbio che la vera sfida non è quella di costruire il ponte più lungo d’Europa, ma di garantire che l’isola non resti isolata nella vita reale.
Secondo stime di esperti economisti, il ponte costerebbe decine di miliardi di euro, che vanno al di là di quanto fino a oggi preventivato, una cifra enorme che, se fosse destinata a infrastrutture locali più funzionali, potrebbe avere un impatto immediato e tangibile sulla vita quotidiana degli isolani: strade più sicure, collegamenti ferroviari efficienti, porti competitivi, servizi digitali all’avanguardia e forse anche collegamenti più veloci fra le due sponde. Senza queste basi, il ponte, fino ad oggi irrealizzato e forse anche irrealizzabile, è da ritenere un’opera solo spettacolare ma inefficace.
Ciò non deve meravigliare. Oggi è consuetudine dire che ‘tutto è spettacolo’: la politica è spettacolo, la giustizia è spettacolo, la vita privata è spettacolo, anche quindi il ponte diventa spettacolo. Ciò che accade oggi Guy Debord l’aveva previsto già 40 anni fa, tanto che la sua fama è dovuta principalmente proprio a un suo libro intitolato: “La società dello spettacolo”.

Da aggiungere che il progetto prevede l’apertura del Ponte entro il 2032, con costi di manutenzione ordinaria stimati intorno agli 80 milioni di euro all’anno, suddivisi tra manutenzione, personale e altri costi operativi, che non si sa dove si andrà a prenderli.
La Sicilia, come non aveva nell’Ottocento bisogno di Garibaldi per definirsi, oggi non ha bisogno di Salvini e del suo Ponte per salvarsi. La vera infrastruttura che l’isola reclama è quella delle coscienze e delle istituzioni, capaci di costruire il futuro non con architetture faraoniche, ma con giustizia sociale, lavoro e fiducia.
Per concludere si riporta quanto nel 2024 alcuni sindacalisti della Sunia hanno affermato: “Il Ponte sullo Stretto è un’opera inutile e dannosa, difficilmente realizzabile. Se fosse realizzato non sarebbe sicuro e neanche conveniente, né dal punto di vista economico né riguardo i tempi di percorrenza. È un progetto che già produce danni perché sottrae, alla Sicilia e alla Calabria, risorse che dovrebbero essere utilizzate per infrastrutture fondamentali alla mobilità delle due regioni. Ma anche perché sta già procurando danni a proprietari, inquilini e prevediamo possa procurare gravi disagi alla cittadinanza delle due sponde dello Stretto”.



