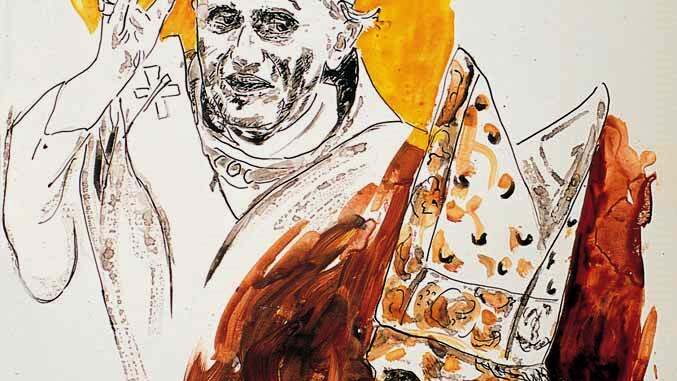
di Andrea Filloramo
Rispondo a un lettore di IMGPress, che, leggendomi là dove ribadisco la necessità che nella Chiesa ci sia più sinodalità come voluta da Papa Francesco e, in questi ultimi giorni, come invocata da Papa Leone XIV, guardando quel che avviene nella sua parrocchia, mi scrive con amarezza e con un certo pessimismo: “Anche i preti coltivano il loro orticello”.
………………………………………………………………………………………………
Il lettore ripete un detto popolare che, con la semplicità tagliente della saggezza contadina, fotografa una verità scomoda: “Anche i preti coltivano il loro orticello.”
In un’epoca in cui la Chiesa cerca faticosamente di parlare al mondo con una sola espressione, il detto rivela una realtà molto diversa e cioè: la frammentazione, l’individualismo e, quindi, la fatica di camminare insieme.
Dietro quel proverbio c’è, più di una battuta: c’è una critica: l’orticello è l’immagine di un confine difeso, di uno spazio privato che si gestisce in proprio. Applicato al mondo ecclesiale, diventa il simbolo di un atteggiamento che molti fedeli riconoscono: preti e parroci gelosi della propria autonomia, diocesi che comunicano a fatica, associazioni religiose che marcano le distanze. Insomma, nella Chiesa che si professa “una, santa, cattolica”, ciascuno coltiva o tende a coltivare il proprio pezzo di terreno, spesso disinteressandosi del campo comune.
Nel concreto, tutto parte – a parere non solo del lettore – dal livello più locale, cioè dalla la parrocchia, dove ogni parroco, secondo il diritto canonico, è “pastore proprio” della comunità che guida. Questo significa ampia libertà gestionale: liturgia, catechesi, bilancio, iniziative sociali, secondo le “direttive del vescovo”, cioè le indicazioni, le istruzioni e gli orientamenti che astrattamente il vescovo fornisce per guidare la vita ecclesiale locale e promuovere la fede e la crescita spirituale.
La libertà dovrebbe essere al servizio della comunità, ma talvolta o spesso diventa isolamento, autoreferenzialità, resistenza alla collaborazione.
Ci sono, infatti, parroci – e non sono pochi – che gestiscono la parrocchia e, quindi, quella che loro a parole chiamano la “comunità parrocchiale”, come un piccolo feudo: decidono tutto da soli, ostacolano l’ingresso di nuove figure, e guardano con sospetto le attività delle parrocchie vicine.
La sinodalità – tanto invocata da Papa Francesco e in questi ultimi giorni invocata da Papa Leone XIV – resta, quindi, per loro soltanto sulla carta, rimane una semplice formalità, non rappresenta uno stile di vita e di missione che coinvolge in un cammino di ascolto, discernimento e presa di decisione insieme.
Anche a livello superiore, le cose non cambiano. La Chiesa è strutturata in diocesi, ognuna retta da un vescovo con ampia autonomia. Le Conferenze episcopali, come la CEI, svolgono un ruolo di coordinamento solo parziale: non hanno potere esecutivo diretto sulle singole diocesi, salvo rare eccezioni approvate da Roma.
Il risultato è una Chiesa a macchia di leopardo, dove ogni territorio sviluppa pratiche, linguaggi e priorità diverse. Non per pluralismo, ma per mancanza di una vera cultura dell’unità e del coordinamento, e tale mancanza ovviamente si riflette in una prassi pastorale che risulta frammentata e autoreferenziale.
Tra le cause meno confessate della di tale frammentazione ecclesiale possono esserci anche la gelosia e l’invidia tra i preti. Quando un’iniziativa pastorale, infatti, riesce, non sempre genera entusiasmo tra i confratelli, ma scatena rivalità sotterranee. Il successo dell’uno può essere vissuto come una minaccia per l’altro.
Questa dinamica, che sarebbe naturale in qualsiasi altro ambiente competitivo, nella Chiesa assume un tono paradossale: proprio dove si predica la comunione, si può agire o si agisce in ordine sparso.
Ma il problema non nasce solo dai caratteri individuali: è il sistema formativo stesso dei seminari che prepara i preti, che non educa al coordinamento, alla corresponsabilità, alla condivisione di intenti. Il risultato, perciò, è un corpo ecclesiale dove ogni membro lavora per sé, e non per un progetto comune.
Così facendo, si perde il senso di comunione ecclesiale, le iniziative restano scollegate, i progetti duplicati, le forze disperse e, sul campo a pagarne il prezzo, sono spesso i fedeli, confusi da una Chiesa che predica l’unità ma pratica spesso la frammentazione.
Come se non bastasse, sullo sfondo c’è la crisi delle risorse: vocazioni in forte calo, fedeli in fuga: in questo clima di scarsità, l’orticello diventa anche una questione di sopravvivenza.
I preti si trovano a competere per lo stesso “mercato spirituale”. E, così, lo spirito evangelico cede il passo a logiche da azienda in trincea: ognuno difende i propri numeri, la propria agenda, i propri volontari.
Questo alimenta una forma di darwinismo ecclesiale: si premiano, perciò, le realtà più visibili, non sempre le più evangeliche, quelle che riescono a “ farsi largo”; i vescovi diventano solo dei datori di lavoro, che, in un sistema di “ cassa integrazione”, distribuiscono, come possono, parrocchie, benefici, “monsignorati”, anacronistiche mitre canonicali e, nella contesa, magari, “pro bono pacis”, si rendono disponibili ad accettare il comodo principio del “totos caballeros”, e premiano, genericamente chiunque, senza distinzione di merito o di qualità.
Si moltiplicano, perciò, i preti, che amano pavoneggiarsi mettendo sul capo la berretta, detta anche tricorno, che per molto tempo era scomparsa, che può essere con fiocco nero o con fiocco rosso, secondo la cosiddetta “ dignità” loro concessa o captata, le mozzette oppure le talari filettate di rosso, che occupano molte pagine dei social.
Ma l’orticello, in fondo, è anche una difesa psicologica. Il mondo cambia velocemente, la secolarizzazione avanza, le certezze crollano. Per molti sacerdoti, restare chiusi nella propria parrocchia – con la messa, i battesimi, i funerali, le feste patronali – è una forma di rifugio. È ciò che essi conoscono, che possono controllare, che dà un senso al loro ministero. Aprirsi al cambiamento costa. Mettersi in discussione ancora di più.
Eppure, è proprio questo che oggi serve. Perché il rischio più grande non è solo l’egoismo, ma l’irrilevanza. Una Chiesa frammentata, chiusa nei suoi piccoli orti, perde la forza profetica del Vangelo.
Il detto popolare non mente: sì, anche i preti coltivano il loro orticello, ma non per cattiveria. Più spesso, per abitudine, per stanchezza, per mancanza di alternative o di aggiornamento. Cambiare questa mentalità richiede coraggio, ma soprattutto visione: la capacità di immaginare una Chiesa meno frammentata, meno difensiva, più aperta e più vera. Un campo da coltivare insieme, finalmente, senza recinti.



