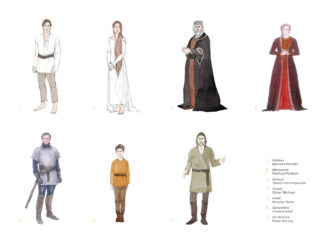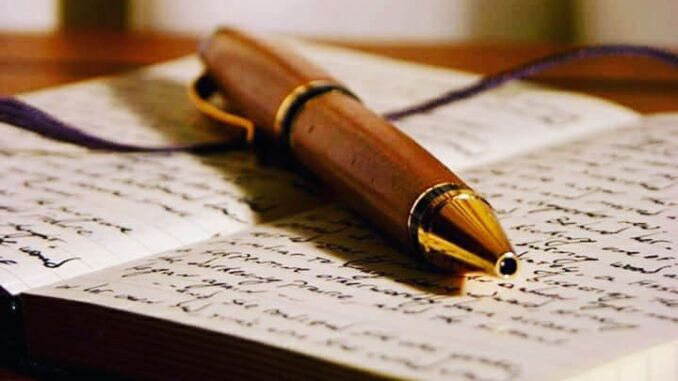
C’è un curioso paradosso che aleggia sulle nuove edizioni tolstojane curate da Davide Romano per Ex Libris: più passano gli anni, più Tolstoj ringiovanisce. Non nella barba, che resta quella da patriarca biblico, ma nelle idee, che sembrano concepite ieri pomeriggio tra un dibattito sul climate change e una spesa al supermercato bio.
Prendete Riflessioni di un vegetariano (che per decenni tutti conobbero come Il primo gradino). È del 1892, ma ha l’odore delle cose scritte con il fiato corto dell’urgenza. Non del pamphlet improvvisato, ma della convinzione maturata quando un uomo scopre che il mondo non gli basta più, e che tocca a lui ricominciare da capo. Tolstoj era in quel periodo nella sua fase “ascetico-militante”: la guerra interiore l’aveva già iniziata da un pezzo, e ora gli servivano regole, scalinate, “gradini”, appunto, per tirare fuori un po’ d’ordine dal caos morale che gli ribolliva dentro.
Romano lo presenta con la cura di uno che la polvere la soffia via, non la spazza sotto il tappeto. E infatti restituisce al lettore non la curiosità di un gigante stravagante, ma un pensatore che vedeva più lontano dei suoi contemporanei, e forse anche dei nostri. Tolstoj parla di vegetarianesimo come di una faccenda etica, religiosa, antropologica: parole grosse, direbbe il buon senso. Eppure lui le affronta con la serenità del profeta che non ha nulla da perdere. L’uomo che ha scritto Guerra e pace era abituato alle catastrofi; la bistecca era solo l’ultimo fronte da liberare.
Quando parla di animali, sembra uno di quei ragazzi che oggi riempiono le piazze delle città europee con i cartelli contro gli allevamenti intensivi; ma lo fa con la gravità di uno che ha visto l’ancien régime sbriciolarsi sotto le dita. Il risultato? Un messaggio che oggi chiameremmo “attualissimo”; per Tolstoj era solo una qualunque mattina a Jàsnaja Poljàna.
Dal vegetarianesimo al Vangelo (senza passare dal via)
C’è poi Vita di Gesù e altri scritti, altra cura romanesca, altra riscoperta di un Tolstoj che legge i Vangeli come si legge un manuale di sopravvivenza. Questa raccolta – che torna sulla scena editoriale dopo un secolo di invisibilità – è figlia della grande crisi spirituale che prese Tolstoj negli anni Settanta dell’Ottocento. Una crisi seria, mica di quelle da weekend lungo.
L’uomo che aveva raccontato i fasti di Pietroburgo e Mosca, le campagne napoleoniche e le miserie dell’aristocrazia russa, a un certo punto decide che tutto ciò non serve più. Non vuole distruggere nulla: vuole capire. E per capire prende i quattro Vangeli, li smonta, li confronta, li “unifica”, come diremmo oggi in un lessico da programmatore software. Dal suo laboratorio morale esce un Cristo umano, fin troppo umano, lontano dalle raffinatezze teologiche che infestano i manuali scolastici.
Romano, nella prefazione, lo dice senza veli: il cuore dell’operazione tolstojana è il Discorso della montagna. Le beatitudini: otto righe, più o meno, capaci di far saltare un impero. Tolstoj le prende sul serio, cosa rarissima anche tra i devoti di professione. Ci costruisce attorno il suo Vangelo personale, che ha la semplicità di un bicchiere d’acqua e la durezza del cristallo.
Il Gesù tolstojano non fa miracoli per stupire e non parla per fare carriera: indica una strada, come quei contadini che dicono “di là” e non aggiungono altro. E proprio per questo funziona. Il secondo scritto incluso nel volume, La felicità, è quasi un manifesto politico: non di quelli urlati nelle piazze, ma di quelli che gli uomini si ripetono sottovoce per provare a diventare decenti.
Il merito del curatore
Davide Romano non interviene per riscrivere Tolstoj: gli rimbocca le coperte, gli pulisce gli occhiali, e soprattutto gli riapre la porta della contemporaneità. Che è il destino dei curatori bravi: fare da ponte senza mettersi di traverso. E Romano, che ha la delicatezza del giornalista che conosce la materia e il pudore dell’uomo che non vuole rubare la scena, accompagna il lettore in queste pagine come un cameriere d’altri tempi: invisibile, ma indispensabile.
Tolstoj, dal canto suo, fa quello che ha sempre fatto: mette in difficoltà. Chi legge queste due opere non può cavarsela con un’alzata di spalle. O si prende sul serio la sua idea di umanità – fragile, complicata, sempre in bilico tra peccato e disciplina – oppure richiude il libro con la vaga sensazione di essersi perso un’occasione.
Conclusione (provvisoria, come piacciono ai russi)
Nel rimettere in circolo questi scritti, Romano ci ricorda che Tolstoj è ancora lì, sulla soglia, con la sua barba da profeta e le sue idee che pesano come macigni. Ci chiede, con la voce calma dei vecchi che hanno visto tutto:
Avete finito di correre? Avete finalmente tempo per pensare?
Non è detto che ci piaccia la risposta. Ma è certo che, dopo aver letto questi due libri, non potremo più far finta di non averla sentita.