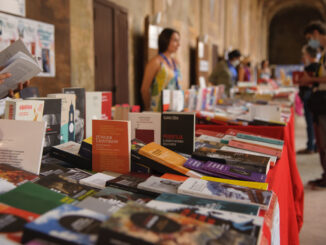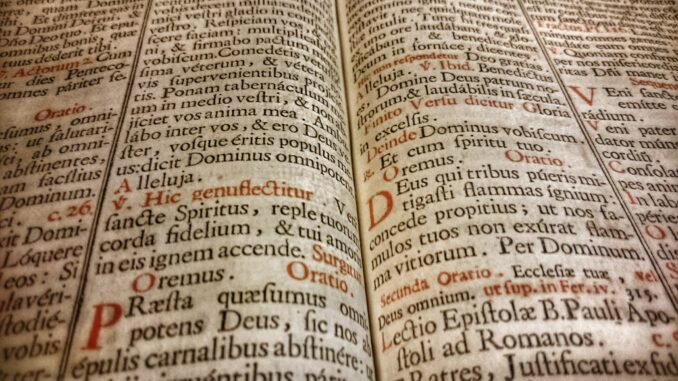
di Andrea Filloramo
La Curia Romana, cuore amministrativo e pastorale della Chiesa cattolica, è sempre stata oggetto di attenzione e discernimento da parte dei papi. Ogni pontefice, negli ultimi decenni, ha offerto un proprio giudizio sul ruolo, le virtù e i limiti di questo organismo complesso e spesso discusso.
Il lungo pontificato di Giovanni Paolo II ha visto la Curia come strumento indispensabile di unità e continuità. “La Curia è chiamata ad essere segno di comunione e strumento di missione“, affermava il Papa polacco in un discorso del 1988.
Le sue parole, perlopiù misurate e istituzionali, richiamavano alla lealtà, alla discrezione e a una collaborazione fedele al Papa. La Curia era vista come un corpo al servizio della missione universale, senza accentuare toni polemici o critici.
La nota critica che da più parti allora è stata fatta al Papa era solo quella di aver “polonizzato” la Curia, cioè di aver favorito l’ingresso o la promozione di vescovi, cardinali e alti funzionari di origine polacca all’interno della Curia romana e in posizioni chiave della Chiesa.
Alcuni storici contestano, però, il termine, sottolineando che le nomine erano motivate da competenza, esperienza pastorale e lealtà personale, più che dall’ origine nazionale.
In ogni caso il fenomeno è stato percepito soprattutto come un cambiamento culturale nella Curia, piuttosto che come una trasformazione strutturale.
Con Benedetto XVI lo sguardo sulla Curia si fece più severo.
Il Papa teologo, infatti, non esitò nell’ omelia durante la Via Crucis al Colosseo del Venerdì Santo, il 25 marzo 2005, pochi giorni prima della morte di Giovanni Paolo II a denunciare la “sporcizia” presente nella Chiesa, riferendosi a scandali e infedeltà che toccavano gli ambienti curiali, quando con tono molto forte, disse: «Quanta sporcizia c’è nella Chiesa, e proprio anche tra coloro che, nel sacerdozio, dovrebbero appartenere completamente a lui! Quanta superbia, quanta autosufficienza!».
Nel discorso alla Curia del 2010, inoltre, affermò: “La più grande persecuzione della Chiesa non viene dai nemici esterni, ma nasce dal peccato che è dentro di essa”.
Preoccupato per il carrierismo e per la burocratizzazione, invitava a riscoprire lo spirito evangelico al di là delle logiche di potere.
Un tema interessante che aiuta a comprendere le dinamiche degli interventi papali che esprimono l’esigenza dei cambiamenti che si sono avuti e ancora si spera che avvengano all’interno della Curia sono le dimissioni di Benedetto XVI (11 febbraio 2013), che hanno avuto un impatto molto forte anche sulla percezione della crisi della stessa Chiesa Cattolica, sulle quali riteniamo opportuno dilungarci.
L’11 febbraio 2013, Papa Benedetto XVI annunciò la sua rinuncia al ministero petrino. Una decisione storica, che non accadeva da secoli, e che mise in luce anche il difficile rapporto tra il Pontefice e la Curia Romana. Considerato un grande teologo e un uomo di studio, Benedetto XVI non aveva lo stesso peso nella gestione organizzativa della Curia.
Benedetto XVI motivò ufficialmente la sua scelta con l’età avanzata e la mancanza di forze per governare la Chiesa universale. “Dopo aver ripetutamente esaminato la mia coscienza davanti a Dio — dichiarò in latino — sono giunto alla certezza che le mie forze, per l’età avanzata, non sono più adatte a esercitare in modo adeguato il ministero petrino”.
Tuttavia, lo scenario in cui maturò la rinuncia era segnato da profonde tensioni curiali: scandali finanziari, rivalità tra dicasteri, fughe di documenti riservati culminate nel caso Vatileaks (2012), che è è uno degli scandali più noti della Santa Sede nel XXI secolo. Lo scandalo riguardava la fuga di documenti riservati del Vaticano, di segreti su conti bancari vaticani e investimenti discutibili, di denunce, conflitti di interesse, nepotismo e malversazioni all’interno della Curia e ancora di lettere e appunti di Papa Benedetto XVI, da cui emergevano tensioni interne strategie politiche della Santa Sede, malversazioni e lotte di potere.Inizio moduloFine modulo
Le sue dimissioni furono lette da molti come un atto di umiltà, ma anche come segno implicito della fatica nel governare una macchina complessa e talvolta resistente al cambiamento.
L’annuncio colse di sorpresa persino i cardinali più vicini e gli stessi curiali. Il cardinale Angelo Sodano parlò di “un fulmine a ciel sereno”; altri, come il cardinale Bertone, sottolinearono la grandezza di un gesto compiuto “per il bene della Chiesa”. In alcuni ambienti prevalse lo smarrimento, in altri la percezione che si fosse giunti a una situazione di stallo.
La rinuncia di Benedetto aprì una fase di riflessione sul ruolo della Curia, sulla sua efficienza e sul rapporto con il ministero petrino.
Le dimissioni di Benedetto XVI hanno inciso non solo sull’idea di papato, ma anche sull’immagine della Curia Romana. Hanno mostrato come le difficoltà interne possano pesare sul ministero del Papa stesso.
La rinuncia di Benedetto XVI resta un atto di coraggio e di verità. Ha segnato uno spartiacque che ha posto la Curia Romana di fronte alla necessità di rinnovarsi, affinché la sua funzione non diventi peso, ma sostegno autentico al ministero del Papa.
Il conclave del 2013 elesse Francesco, che nel celebre discorso natalizio del 2014 parlò delle “malattie spirituali” della Curia: mondanità, rigidità, narcisismo, chiacchiericcio. “Una Curia che non si autocritica, che non si aggiorna, che non cerca di migliorarsi, è un corpo malato” disse con franchezza.
Da allora Papa Bergoglio fece della riforma della Curia una delle sue priorità, fino alla costituzione apostolica “Praedicate Evangelium” (2022), con cui la Curia è stata trasformata in chiave missionaria, favorendo internazionalizzazione e maggiore presenza femminile.
Molti osservatori videro in quella riforma la prosecuzione indiretta di un’urgenza emersa proprio negli anni finali del pontificato di Benedetto.
Con Leone XIV, eletto nel 2025, il tono sta cambiato nuovamente. “I Papi passano, la Curia rimane“, ha detto il nuovo Papa incontrando i dipendenti vaticani, sottolineando il ruolo della Curia come custode della memoria viva della Chiesa.
Il Pontefice non ha scelto la via delle accuse, ma quella della fiducia: invita a costruire comunione, superare incomprensioni e pregiudizi, valorizzare il servizio nascosto degli officiali. “L’esperienza della missione fa parte della mia vita“, ha ricordato parlando ai capi dicastero, chiedendo che anche il lavoro d’ufficio sia vissuto in spirito missionario.
Oggi, Papa Leone XIV insiste su unità, comunione e missione, quasi in risposta alle fratture che ci sono state: la Curia non come ostacolo, ma come comunità di fede al servizio della Chiesa universale.
Concludendo: Dalla disciplina alla denuncia, dalla riforma all’incoraggiamento: lo sguardo dei papi sulla Curia riflette la varietà dei loro pontificati.
Con Leone XIV emerge una visione paterna e comunitaria, che sceglie la strada dell’unità e della missione, ponendo la Curia non solo come macchina amministrativa, ma come comunità di fede a servizio della Chiesa universale.
Fin qui quasi una cronistoria del processo di innovazione della Curia Romana, quindi di un insieme di strutture (Dicasteri) politico – amministrative che, essendo, però, centrale per il governo ecclesiale, il suo funzionamento spesso appare ed è distante ai fedeli e, quindi, scarsamente attrattivo, perché percepito più come burocrazia che come servizio pastorale.
Da osservare, che il suo rinnovamento, però, non riguarda solo l’organo centrale della Chiesa, ma ha riflessi importanti anche sulle curie diocesane.
Le diocesi sono invitate, infatti, a rinnovarsi, non per imitazione formale con la Curia Romana, che è ben diversa dalle curie diocesane, che sono gli uffici amministrativi di supporto ai vescovi nelle singole diocesi, ma per adattare le proprie strutture e pratiche a criteri di maggiore efficienza, trasparenza e partecipazione.
Le indicazioni provenienti dal Vaticano – dalle norme amministrative agli orientamenti pastorali – diventano, perciò, stimolo per una cultura di corresponsabilità e sinodalità, spingendo le curie locali a favorire la collaborazione. In questo senso, il rinnovamento centrale si traduce in un invito al discernimento e alla modernizzazione anche a livello diocesano.
Se guardiamo, infatti, già la Costituzione apostolica Praedicate evangelium del 2022 notiamo che introdusse significative innovazioni anche nel processo di nomina dei vescovi, però, nonostante sia stato pensato per garantire oggettività e discernimento, in realtà è rimasto opaco e fortemente condizionato da “cordate amicali” dei candidati all’episcopato, fatte da Reti di influenza personale, da logiche di appartenenza, mancanza di trasparenza e affermazioni, carrierismo. Conseguentemente soltanto i sacerdoti che coltivano relazioni “giuste” possono entrare nelle cordate vincenti.
E’ questo un tema cha va trattato con molto equilibrio: è, infatti, un argomento delicato perché tocca sia la responsabilità personale sia le dinamiche istituzionali della Chiesa.
Se guardiamo a questo modello di selezione e non alla mancanza di impegno dei presbiteri, possiamo spiegare, però, il fallimento pastorale che è evidente in qualche diocesi, che – come è ovvio – non può dipendere da un solo fattore ma è quasi sempre l’intreccio tra scelte sbagliate, rigidità, mancanza di coraggio e assenza di trasparenza, tuttavia spesso si potrebbe evitare ascoltando di più il popolo di Dio e mettendo al centro la missione evangelica, non la gestione di potere.
Quando la pastorale manca, la Chiesa si ripiega su sé stessa. È proprio allora che, all’interno delle diocesi, possono nascere delle “cricche” cioè dei gruppi di sacerdoti che si sostengono a vicenda, scambiandosi incarichi e protezioni.
E’ questo un fenomeno noto da tempo e forse sempre esistito ma oggi diventa sempre più evidente, con comunità svuotate e fedeli sfiduciati.
Il sistema delle nomine, in teoria, dovrebbe puntare su figure capaci di guidare con ascolto e servizio. Nella pratica, troppo spesso prevalgono, invece, logiche di appartenenza e cordate. Così il ruolo di vescovo o del parroco diventa frutto di giochi di potere, non di discernimento spirituale.
Le conseguenze sono pesanti: i fedeli percepiscono decisioni prese dall’alto, senza trasparenza; i giovani non trovano testimoni credibili e si allontanano; preti che non appartengono a una cordata restano ai margini, anche se hanno carismi autentici e la Chiesa perde credibilità proprio sul terreno che dovrebbe esserle più caro che è l’annuncio del Vangelo.
Il futuro della Chiesa non può dipendere da logiche di potere interne. O si torna al servizio delle comunità, oppure il distacco tra istituzione e fedeli continuerà a crescere.
Da evidenziare che il settarismo, quando penetra in una determinata società e quindi anche nella Chiesa universale o particolare, divide la comunità e le istituzioni in fazioni contrapposte. Questo fenomeno genera polarizzazione, sospetti, e conflitti che logorano. Il rischio maggiore è che prevalgano identità chiuse e difensive, incapaci di dialogo e collaborazione. Una società e anche una Chiesa segnata dal settarismo non cresce – ne siamo certi – ma si indebolisce, trasformando le differenze in barriere.
Affrontarle le “cricche” da parte del vescovo richiede trasparenza, una leadership vescovile forte e percorsi di corresponsabilità che coinvolgano anche i laici con cui combattere – e non è facile – il clericalismo, la logica del favore personale, i legami personali, le affiliazioni, i silenzi.