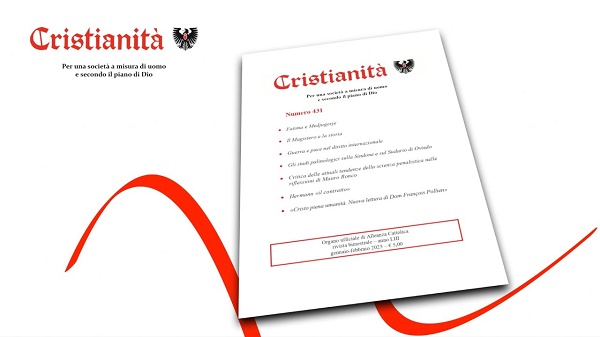
Ama lo studio della Storia, quindi non potevo tralasciare la sintesi su “Il Magistero e la storia” che ha proposto Oscar Sanguinetti nella rivista Cristianità, organo ufficiale di Alleanza Cattolica, (N. 431; gennaio-febbraio 2025).
Sanguinetti dopo aver chiarito che le Sacre Scritture (Antico e Nuovo Testamento) sono testi di storia a tutti gli effetti, che narrano fatti ordinari e straordinari, lo studioso cita Giovanni Paolo II che in un Messaggio al Presidente del Pontifico Comitato di Scienze Storiche scrive: [le] “Sacre Scritture dell’Antica e della Nuova Alleanza [sono] una chiave ulteriore di lettura per una conoscenza adeguata dell’uomo e del mondo. È nel messaggio biblico, infatti, che si conosce la vicenda umana nei suoi risvolti più nascosti: la creazione, la tragedia del peccato, la redenzione”. La dimensione della storia è fondamentale per inquadrare e comprendere l’annuncio della Buona Novella. Annuncio cristiano fatto da duemila anni dalla Chiesa, organismo voluto dal Signore. Pertanto, la Chiesa, la sacra gerarchia con i suoi ministeri, i singoli cristiani e i popoli, è un soggetto storico a pieno titolo. Così della Chiesa, “come per le società umane, se ne possono narrare le lotte, le vittorie e le sconfitte, le luci e le ombre, […] i momenti di fulgore e i periodi di appannamento e di oscuramento, i trionfi e le persecuzioni subite”.
Il breve saggio di Sanguinetti viene distinto in periodi storici, si comincia con l’antichità, con riferimento al grande Agostino d’Ippona (354-430) con la dottrina delle “due città”, quella di Dio e del demonio, una che eleva e salva, l’altra che abbassa e danna, storia esposta nei ventidue libri della Città di Dio. Una Storia ecclesiastica è quella di Eusebio di Cesarea (260-339) una risposta della dottrina della fede al pullulare delle eresie in tutti i territori dove il Vangelo si diffonde. Per le storie dei popoli nuovi e vecchi, Sanguinetti segnala, Paolo Diacono (720 ca.-799) nella Storia dei Longobardi. Per la storia ecclesiastica in Età Moderna, grazie alla scoperta della stampa, c’è uno sviluppo degli studi storici anche se “il movente principale sarà la pesante offensiva che la Chiesa cattolica subisce da parte del protestantesimo”. La nuova visione ecclesiale che vede un allontanamento della Chiesa medievale da quella “primitiva” sarà portata avanti dai cosiddetti Centuriatori di Magdeburgo, che diffondono la “leggenda nera” sulle origini e sulla vita dell’organismo ecclesiale nei secoli, dall’VIII al XV: il periodo quando la Chiesa era stata l’anima della cristianità occidentale e della cristianità orientale. E’ una leggenda diffamatoria che si è irrobustita nel corso dei secoli fino ad arrivare nei manuali scolastici del Novecento. “La disciplina storica ecclesiastica – scrive Oscar Sanguinetti – nasce dunque come esigenza apologetica, come risposta a un’offensiva diffamatrice […]”. Ma anche per rinforzare per rinforzare i presupposti teologici della Chiesa. Dopo il Concilio di Trento (1545-1563) grazie al venerabile cardinale Cesare Baronio C.O: (1538-1607) e ai suoi Annales ecclesiastici, la storiografia della Chiesa in prospettiva cristiana si intensificherà con l’apporto dei Bollandisti e dei Maurini, entrambi collezionatori di documenti e di fonti antiche. Poi successivamente le vicende temporali, spirituali e dottrinali della Chiesa, del Papato, degli episcopati, delle congregazioni saranno sviluppate dai Santi come Alfonso Maria de’ Liguori (1696-1787).
La Storia ecclesiastica raggiungerà uno status compiuto anche sotto il profilo scientifico solo nell’Ottocento con Johan Adam Mohler (1796-1838) sacerdote e docente a Tubinga e a Monaco di Baviera. A lui faranno seguito grandi storici europei per lo più ecclesiastici, come Renè Francois Rohrbacher (1796-1856) fino a Jacques Augustine Marie Cretineau-Joly (1803-1840).
Sarà Leone XIII (1878-1903) a rilanciare energicamente gli studi storici ecclesiali e ne definirà lo statuto scientifico, non limitandolo alla pura apologetica, anche se non veniva negata, perché i nemici della Chiesa erano sempre presenti. Il Papa permetterà per la prima volta nella storia, l’accesso alle raccolte dell’Archivio Segreto Vaticano. Dopo la Lettera di Leone XIII, Saepenumero considerantes, gli studi storici si moltiplicheranno, Sanguinetti cita i più importanti: Ludwig von Pastor (1854-1928), Louis Marie Oliver Duchensne (1843-1922), Joseph Adam Lortz (1887-1975), Hubert Jedin, Jean Dumont, Henri-Irenee Marrou, Giacomo Martina, Giuseppe Ricciotti, mi permetto di aggiungere Daniel Rops (1901-1965) senza dimenticare il poliedrico Joseph Ratzinger.
Sia Giovanni Paolo II che Benedetto XVI hanno sviluppato lo studio delle Scienze Storiche. Uomini e gruppi senza storia sono inconsistenti per san Giovanni Paolo II, “l’ignoranza del proprio passato conduce fatalmente alla crisi e alla perdita di identità dei singoli e delle comunità”. Poi dirà papa Ratzinger, “la perdita della memoria provoca nell’individuo la perdita dell’identità […]”. La Chiesa, ribadisce ancora Papa Benedetto XVI,“ha a cuore una cultura storica autentica, un effettivo progresso delle scienze storiche. La ricerca storica ad alto livello rientra infatti anche in senso più stretto nello specifico interesse della Chiesa”. Sul tema della Storia ha parlato anche Papa Francesco in una lettera “sul rinnovamento dello studio della storia della Chiesa”, pubblicata il 21 novembre 2024 e indirizzata principalmente allo studio della storia della Chiesa nei seminari. In essa papa Francesco faceva eco e aggiorna le preoccupazioni di san Giovanni Paolo II. Francesco intendeva offrire la lettera ai seminaristi affinchè aiutasse meglio a interpretare la realtà sociale. C’è una attenzione al senso della storia in Papa Francesco, vale per i singoli, ma anche per i gruppi sociali. Oggi c’è un dilagare di memorie, spesso false, artificiali e anche menzognere. Per quanto riguarda la comunità cristiana, “la storia della chiesa ci aiuta a guardare la Chiesa reale per poter amare quella che esiste veramente e che ha imparato e continua ad imparare dai suoi errori e dalle sue cadute”. Educare i candidati al sacerdozio alla sensibilità storica è una necessità per Papa Francesco, in particolare nel nostro tempo. Si avverte la penetrazione culturale di una sorta di “decostruzionismo”, per cui si pretende di costruire tutto a partire da zero. Ignorare la storia significa vuotarsi di una dimensione essenziale della propria identità e nello stesso tempo ad essere insidiati dalle ideologie. La storia della Chiesa nella sua dimensione temporale deve perseguire la verità intera della memoria. Scriveva lo storico dell’Ottocento francese Jacques Cretineau-Joly: “la verità è l’unica carità permessa alla storia”. Il Papa chiudeva il documento per i seminaristi con alcune annotazioni di metodo. Infatti, si risponde a Come studiare la storia della Chiesa. Tra i tanti accorgimenti del Pontefice mi colpisce la sua raccomandazione ad andare alle fonti originali e meno alla manualistica. Lo storico cristiano deve vedere il proprio studio come una missione che coinvolge la Chiesa. Importante che non ometta di studiare gli “ultimi”, i “senza voce”, gli sconfitti. A questo punto Sanguinetti ne approfitta per ricordare i tanti eroi che abbiamo conosciuto e studiato nell’ambiente di Alleanza Cattolica, a cominciare dagli Insorgenti italiani massacrati a migliaia dagli eserciti napoleonici. I Cristeros messicani traditi e decimati, fino ai cosiddetti “briganti” del Mezzogiorno d’Italia, le cui teste erano esibite come trofei dai bersaglieri sabaudi, ai milioni di vittime ignote della macchina genocida del nazionalsocialismo e della sconfinata violenza classicida del comunismo internazionale, per la cui tragica morte nessuno ha mai pagato nemmeno un giorno di galera. “Non so se il papa avesse in mente costoro, – scrive Sanguinetti – ma l’identikit di ‘coloro che non hanno potuto far sentire la loro voce nel corso dei secoli’, degli ‘ultimi’ che egli ne traccia, calza loro a pennello”. In conclusione, lo studioso rileva che Papa Francesco, spesso poco conosciuto per quello che ha scritto, con questa lettera ha dimostrato che occorre chinarsi sul passato della Chiesa e sul passato della civiltà che da lei ha preso forma e si è dilatata nel mondo. Un documento che dimostra l’interesse del Magistero per la storia. Sanguinetti conclude il suo saggio ricordando alcune figure che hanno fatto della teologia della storia classica il loro alimento, studiando ininterrottamente la vita della Chiesa, anche in chiave apologetica, figure storiche tanto care alla comunità di Alleanza Cattolica, che hanno aderito al perenne Magistero della Chiesa, come Gonzague de Reynold (1880-1970), Pierre Gaxotte (1895-1982), Regine Pernoud (1909-1998), Marta Sordi (1925-2009), Alberto Caturelli (1927-2016), Giovanni Cantoni (1938-2020), Marco Tangheroni (1946-2004).
DOMENICO BONVEGNA
dbonvegna1@gmail.com



