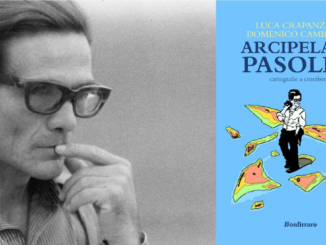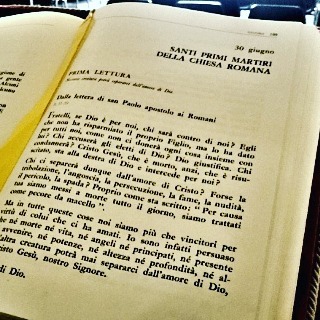
di Andrea Filloramo
E’ indubbio che l’elezione di Robert Francis Prevost al soglio pontificio abbia sorpreso molti. Papa Leone XIV è il primo papa statunitense della storia, un evento di grande portata per la Chiesa cattolica, per gli Stati Uniti e per il mondo. La sua elezione, pertanto, rappresenta un cambiamento simbolico e geopolitico molto significativo e indica una crescente apertura verso un papato più rappresentativo della globalizzazione della fede cattolica.
Da osservare che tra le pieghe della sua biografia emerge un dettaglio che getta luce su alcuni tratti interessanti del suo pontificato, consistente nel fatto che il nonno del nuovo Pontefice, Salvatore Riggitano, nato nel 1876 in Sicilia, precisamente a Milazzo (ME ), in giovane età, ai primi anni del Novecento, è emigrato – come accadeva allora a tanti siciliani – negli Stati Uniti.
Fin dai suoi primi discorsi, il Papa ha fatto riferimento alla propria storia familiare di emigrazione, non come rivendicazione identitaria, ma come consapevolezza. L’origine di Papa Leone XIV non è una nota di colore, ma è una chiave interpretativa, che non basta per spiegare tutte le sue scelte, ma aiuta a comprenderne il tono umano e il suo realismo pastorale.
Quello di Leone XIV sarà – ne siamo certi – un pontificato che parlerà con accento familiare e, pertanto, egli non sarà solo il Papa venuto da Chicago dove è nato o dal Perù dove è stato Missionario; sarà anche un Papa venuto dal Meridione d’Italia, dalla Sicilia, nella quale sono state rintracciate e documentate le sue radici familiari. “Sono nipote di un emigrante e servo di un Vangelo che non appartiene a nessuna élite”, ha detto con disarmante franchezza nella sua omelia d’inizio pontificato.
Anche il modo di intendere la religione da parte del Papa, trasmessa direttamente dal padre – come lui stesso disse in un’intervista – attinge pienamente dalla sicilianità. La religione, infatti, è da lui vista principalmente come esperienza comunitaria e affettiva, vissuta fin dall’infanzia nella parrocchia, legata alle processioni, alle liturgie e ai rituali tramandati da generazioni.
La sua è una religiosità più devozionale che dottrinale, più orientata al gesto che alla teologia, com’è quella di tanti siciliani, per i quali i Santi hanno un ruolo centrale nella pratica religiosa, la Madonna è oggetto di intensa venerazione e le celebrazioni religiose sono spesso eventi collettivi con forte partecipazione popolare.
Per finire torniamo all’emigrazione, verso la quale il Papa, per le sue origini familiari, mostra di avere una grande capacità di comprensione e di condivisione dei sentimenti e delle esperienze degli emigrati. Sappiamo che il rapporto dei siciliani con gli immigrati è complesso, ma si distingue rispetto ad altre regioni italiane per una maggiore accoglienza spontanea, una memoria viva della propria emigrazione passata e una cultura dell’ospitalità radicata. Ciò accade come sappiamo, in quanto la Sicilia ha una lunga storia di emigrazione verso l’estero e dentro questa storia è collocabile la famiglia del Papa. E’ certo che questa memoria genera in Papa Prevost un’empatia particolare verso chi emigra.
In questa dimensione mediterranea, oltretutto, si può cogliere un indiscutibile riflesso nella visione di Papa Leone XIV: la sua Chiesa non può non essere una Chiesa ospitale, mobile, meno centralista, che abbraccia le periferie del mondo. E’ da questa coscienza che nasce la sua ferma attenzione per gli “scartati”, come li chiamava Papa Francesco e per le Chiese del Sud globale. E’ questo un tratto che non si può non collegare proprio alla sua eredità familiare siculo-americana.