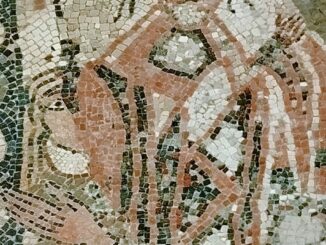di Davide Romano
C’è un’America che ancora conserva cattedrali, pulpiti, paramenti liturgici, vescovi eleganti e cori perfetti. Eppure, quella stessa America non si ferma più a contemplare la Chiesa. La The Episcopal Church, la storica espressione dell’anglicanesimo statunitense, si presenta oggi come un gigante dall’armatura impeccabile, ma con gli ingranaggi che cigolano alla prima accensione. Il problema non è che manchi la fede: è che manca l’audience.
Fondata dopo la rivoluzione degli Stati Uniti d’America, quando il collante con la Corona britannica si ruppe non solo politicamente ma anche ecclesialmente, la Chiesa Episcopale scelse un’identità duplice: “protestante e cattolica”. Protestante, perché rivendicava la libertà nella lettura delle Scritture e un episcopato nazionale; cattolica, perché mantenne vescovi, altari, sacramenti come la tradizione anglicana imponeva. Era il cristianesimo della rispettabilità: studiosi, avvocati, senatori, giudici frequentavano i suoi pulpiti. Oggi quell’aura sembra un richiamo vintage.
I numeri, che non sopportano indulgenze, raccontano la storia con implacabile chiarezza. Alla fine del 2023, la Chiesa contava un milione e cinquecentoquarantamila membri battezzati attivi circa, poco meno di un milione e quattrocentomila solo negli Stati Uniti. Le congregazioni aperte – parrocchie e missioni – erano poco più di seimila settecento. La partecipazione media domenicale, ossia coloro che fisicamente siedono nei banchi della domenica, si aggirava attorno alle quattrocentomila presenze: un numero che per la Chiesa Episcopale è «ripresa» — rispetto al minimo pandemico — ma che rimane ben lontano dalla sua vigoria storica. Questo non è un calo improvviso: è un lento sgonfiarsi della presenza, una perdita di platea che si consuma più in silenzio di quanto i grandi titoli desiderino.
E le vocazioni? Se un tempo i seminari statunitensi erano pieni e la Chiesa in grado di ordinare oltre trecento sacerdoti all’anno, ora quel numero è sceso a circa duecentoventicinque nuovi ordinati nel 2022. Parrocchie vacanti, pastori in condivisione fra due o tre comunità, diocesi che valutano la fusione o il ridimensionamento: non è un cantiere di ordinari amministratori, ma di parroci e vescovi che devono rinnovarsi mentre stringono i denti.
Sul piano finanziario la situazione appare più stabile, quasi sorprendentemente: entrate complessive dell’ordine del miliardo e trecento milioni di dollari l’anno – non bruscolini, per intenderci. Eppure la stabilità ha un costo: edifici imponenti, manutenzioni storiche, costi crescenti (energia, personale, restauro). In alcune diocesi rurali del Midwest, la spesa supera le entrate e le comunità contano fedeli sempre più anziani. In buona sostanza: la struttura regge, ma per quanto ancora?
È curioso che una Chiesa che un tempo dettava i codici della rispettabilità religiosa americana oggi si ritrovi a misurarsi con un paradigma diverso: quello dell’essere minoranza attiva invece che maggioranza silenziosa. Una volta si era “la Chiesa degli uomini potenti”; oggi si è “la comunità dei pochi che resistono”. Paradosso elegante: meno fedeli, ma forse più convinti. Ma è un lusso che può permettersi un’élite culturale, non una struttura che aspira a numeri.
Il rapporto con il governo federale è un altro frontespizio interessante. Nel maggio del 2025, la Chiesa Episcopale annunciò che avrebbe interrotto la collaborazione con un programma federale di reinsediamento rifugiati, in particolare a seguito della richiesta di Washington di accogliere un gruppo di rifugiati sudafricani bianchi (Afrikaner) che la Chiesa riteneva non rispondenti ai criteri etici della propria missione. È un gesto forte: non mera retorica, ma scelta politica e morale. Tuttavia, qualcuno potrebbe osservare che in un’epoca in cui la Chiesa ha perso peso pubblico, questo tipo di posizionamento è più simbolico che influente. È tipico: quando si è piccoli, l’eco si affievolisce.
E veniamo alla dimensione globale: la Chiesa Episcopale fa parte della Anglican Communion, la rete mondiale delle chiese anglicane. Ma l’appartenenza è diventata faticosa. Le decisioni su ordinazioni di donne e vescovi aperti all’omosessualità, i matrimoni tra persone dello stesso sesso che in certi Stati americani trovano il riconoscimento, hanno prodotto reazioni forti. Province africane e asiatiche hanno interrotto la piena comunione o si sono dissociate da certi processi decisi a Canterbury. La Chiesa Americana, insomma, è diventata un laboratorio di teologia progressista che cammina da sola – o meglio, accompagnata meno di prima. Non è più quella di una volta, la “Chiesa guida” dell’anglicanesimo mondiale; è un attore fra altri, talvolta contestato, ma non ignorabile.
Con quel piglio che sarebbe piaciuto a Montanelli (chi avrebbe osato dire che un tempo la Chiesa Episcopale fosse “l’élite del culto” e oggi un patrimonio in discussione?), potremmo osservare: la Chiesa non è al capolinea — e non lo dico con ironia banale — ma sta attraversando un cambio di pelle. Alcuni dicono che la trasformazione è dolorosa; altri che è necessaria. Non è un declino totale se non come idea di potere sociale. È una ridefinizione.
Qualcuno potrebbe obiettare che contare i fedeli, i sacerdoti, i dollari è mescolare l’essenziale — la fede — con il contingente. Ma la questione è proprio questa: una Chiesa che vuole essere “di fede” ma pretende anche di essere “di influenza” non può ignorare i numeri. E la Chiesa Episcopale ha scelto di non mascherarli.
Il vero snodo, forse, è nella domanda: vuole continuare a essere la Chiesa dell’élite americana oppure trasformarsi in una comunità missionaria che vive fuori dai riflettori? Perché i modelli sono due e incompatibili: eleganza e minoranza; presenza e riduzione. Finora ha oscillato fra i due poli.
E qui ci concediamo una battuta alla Montanelli: «È rimasta con le candele accese mentre il mondo fuori ha sostituito il cero pasquale con la luce al neon». Ma non è una sfida persa. Una Chiesa che guarda al futuro non si chiede solo quanti entrano la domenica. Si chiede se quando vengono entrano perché devono o perché vogliono. E se la risposta è “perché vogliono”, allora forse ha una speranza.
La Chiesa Episcopale Americana vive oggi una fase di grazia apparente: meno numeri, più intenzione; meno visibilità, più autenticità. Ma per durare in modo rilevante deve scegliere: rimanere com’era — e perdere ciò che resta — oppure reinventarsi — e rischiare di perdere l’omaggio nostalgico degli ex “invitti”. In entrambi i casi, la posta è alta: non solo la sopravvivenza, ma il senso dell’essere Chiesa nel XXI secolo. E se la Chiesa ha smesso di essere presidente, forse può ancora essere profeta.
Fonti principali:
The Episcopal Church Annual Report 2024; Office of General Convention Data; Pew Research Center Religious Landscape Study (aggiornamento 2024); National Council of Churches Yearbook of American and Canadian Churches 2024; interviste e articoli d’analisi su Church Times, Episcopal News Service, Christian Today.