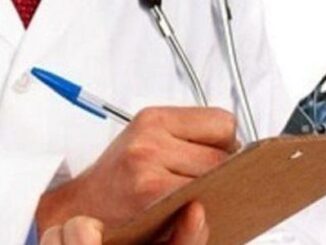Per fare politica bisogna conoscere la Storia, la “scuola” di Alleanza Cattolica è stata sempre sensibile allo studio e alla conoscenza della Storia. Il fondatore dell’associazione Giovanni Cantoni amava sempre sostenere: “chi sbaglia storia sbaglia politica”. Paolo Martinucci e Marco Invernizzi, due autorevoli esponenti di Alleanza Cattolica hanno collaborato per la stesura di un libro di vera Storia, pubblicato qualche anno fa dalla casa editrice D’Ettoris di Crotone: “Per Dio e per la Patria. Profili di contro-rivoluzionari italiani fra Settecento e Ottocento”, D’Ettoris Editori (2019; pag.344; e.23,90).
Il testo offre al lettore un corposo saggio di Marco Invernizzi (L’Italia fra Rivoluzione e Contro-Rivoluzione. 1794-1848), dieci biografie di contro-rivoluzionari italiani, li presento in ordine cronologico: Adeodato Turchi, Fabrizio Ruffo, Gian Francesco Galeani Napione, Giovanni Marchetti, Pio Bruno Lanteri, Cesare Taparelli D’Azeglio, Antonio Capece Minutolo, principe di Canosa, Monaldo Leopardi, Giacomo Mellerio, Giuseppe Baraldi. Nella premessa Martinucci, chiarisce che ha dovuto fare una scelta, ma potevano essere molti di più i contro-rivoluzionari che hanno combattuto la “buona battaglia” per Dio e per la Patria. I personaggi scelti dal professore Martinucci sono quasi tutti sconosciuti, tranne qualcuno perché ha subito la diffamazione dai cosiddetti professionisti della Storia ufficiale. Questi dieci uomini si sono opposti ai regimi instaurati in Italia dalla Francia rivoluzionaria con la complicità dei “giacobini” locali. Siamo tra le metà del Settecento e i primi decenni dell’Ottocento.
Ognuno secondo le proprie forze, attraverso fogli, riviste, articoli, libri, ma anche con le armi vere e proprie, hanno combattuto la “battaglia delle idee”, resistendo contro l’invasione francese, pagando di persona spesso con la prigione. Lo studio poteva ampliare di molto il campo d’indagine e presentare altre biografie, soprattutto di quegli animatori o guide che hanno condotto la resistenza militare, come il maggiore dell’esercito imperiale Branda de’ Lucioni, comandante della Massa Cristiana operante tra la Lombardia e il Piemonte, il generale milanese, Giuseppe Lahoz Ortiz, i barbets piemontesi, i “Lazzari” napoletani, i “sanfedisti” calabresi e tanti altri. Marco Invernizzi esordisce scrivendo che esiste un equivoco storico nello scontro politico tra le forze rivoluzionarie nate dalla Rivoluzione francese e quelle governative in Europa alla fine del Settecento.
Le prime che si rifanno all’Illuminismo e quindi ai principi dell’89, hanno l’obiettivo principale di illuminare i popoli europei, liberandoli dall’”oscurantismo cattolico” per riprendere il cammino verso un futuro radioso. Tutto questo viene fatto attraverso le baionette degli eserciti di Napoleone Bonaparte. I governi che si opposero a Napoleone scrive Invernizzi erano paradossalmente anche loro influenzati dalla corrente culturale illuministica. Basta guardare il nemico storico dei patrioti italiani fautori del Risorgimento, l’impero austrico, per lunghi periodi il suo governo è influenzato dal cosiddetto “dispotismo illuminato”, cioè di quel tentativo di “imporre” la rivoluzione dei Lumi dall’alto, attraverso il potere politico. Addirittura, nella seconda metà del Settecento, Vienna cercherà di imporre una “riforma” della Chiesa di Roma, patrocinata dall’imperatore stesso Giuseppe II, il cosiddetto “giuseppinismo”. Dove si mira ad accentrare nello Stato il controllo del clero nazionale, allontanandolo dall’obbedienza al pontefice romano.
Purtroppo, è un equivoco che persiste ancora oggi a livello storiografico. Il conte De Maistre aveva ben presente la complessità della situazione storica di allora, ecco perché era consapevole che le monarchie assolute, che avevano abolito le antiche forme di libertà godute dai corpi intermedi della società, e per tanto tempo erano state in conflitto con la Chiesa, erano incapaci di affrontare l’aggressione rivoluzionaria. Pertanto, le forze rivoluzionarie assumono i connotati del “nuovo” e del progresso contro il conservatorismo, ritenuto ottuso dei governi, “mentre in realtà i conservatori – scrive Invernizzi – o i contro-rivoluzionari, ma il termine non è corrente, almeno in Italia – auspicano non il ripristino dell’antico regime, ma il ritorno all’origine, cioè agli elementi fondamentali della vita sociale che le rivoluzioni hanno messo in discussione”. Invernizzi ripercorre i passaggi più importanti del periodo storico affrontato: Le “novità” delle ideologie moderne, che mirano a formare l’”uomo nuovo”. La nascita dei partiti. La nascita dello Stato moderno, che elimina i corpi intermedi e che concede i diritti. La Guerra delle Alpi e l’arrivo di Napoleone in Italia. Un personaggio abbastanza ambiguo che assomiglia più a Mussolini che a Stalin.
Le forze politiche che si scontrano durante il Triennio rivoluzionario. La reazione alla Rivoluzione della Chiesa, della società, ma soprattutto del popolo. La spontanea Insorgenza delle popolazioni italiane contro gli eserciti napoleonici. Una Insorgenza molto simile a quella Vandeana anche qui fallisce per gli stessi motivi di quella francese. Caduto Napoleone arriva la finta restaurazione dell’ancien regime. Una restaurazione che ha lasciato le “conquiste” napoleoniche, Metternich pur combattendo la rivoluzione, non era un vero controrivoluzionario, sostanzialmente condivideva le premesse illuministiche. Non possedeva quella prospettiva religiosa e culturale per risalire alle “cause originarie del processo rivoluzionario e quindi di cogliere la responsabilità dell’Illuminismo – specialmente del dispotismo illuminato – nella genesi di quella Rivoluzione che combatterà per tutta la vita”. Certo a Vienna nasce la Santa Alleanza, nel nome della religione cristiana, che impegna in una comune finalità e azione i tre principali Stati che hanno combattuto contro Napoleone, come in tutte le cose umane, ci sono anche interessi concreti da difendere.
Tuttavia, per Invernizzi, nonostante le finalità di questa alleanza, la Rivoluzione è sempre viva, opera attraverso le società segrete come la massoneria e la carboneria. Il saggio di Invernizzi si conclude con alcuni cenni storici di storia contro-rivoluzionaria in Italia, si focalizza quella pagina storica, sconosciuta ai più, del confronto culturale e politico, ma talora anche militare, tra le forze rivoluzionarie e la Contro-Rivoluzione. E qui Invernizzi fa i nomi dei maggiori interpreti di questa interessante e affascinante storia a partire dalle insorgenze, le Amicizie del Lanteri, le iniziative culturali del padre teatino siciliano Gioacchino ventura di Raulica a Napoli. A Torino Cesare Taparelli d’Azeglio. Monsignor Baraldi, Monaldo Leopardi, il Principe di Canosa e tanti altri. Tutti uniti nel difendere il “trono e l’altare”. Ma la questione ci tiene a precisare Invernizzi non è tanto “la conservazione dei territori – Roma, il Lazio, le Legazioni – a sovranità pontificia, ma, soprattutto, sia in corso un grande scontro culturale e politico inteso a strappare l’Italia, e in prospettiva l’Europa, dalle sue radici cristiane, riducendo il cristianesimo a un fatto privato”. Diversamente non si possono spiegare le misure prese dai governi contrari a ogni influenza della Chiesa sull’educazione e sulla beneficenza, fino all’espulsione delle congregazioni di vita contemplativa e dei gesuiti, cominciata prima dell’unificazione e cresciuta anche dopo il 1870. Pertanto, oggi, scrive Invernizzi, “è possibile riconoscere che la posta in gioco non è allora un territorio e neppure la conquista della capitale, ma l’egemonia dello Stato e della cultura liberale sulla società, sulle intelligenze dei giovani, i futuri cittadini della nazione”. Ecco perché poi bisognava “fare gl’italiani”. Per quanto riguarda il comportamento dei cattolici di allora che sono la maggioranza del Paese, Invernizzi chiarisce che l’Italia “profonda”, quella dell’Insorgenza, “era ostile allo straniero, non perché “diverso”, ma perché portatore di una visione del mondo contraria ai propri ideali, religiosi e civili. Essa, tuttavia, non troverà allora una classe dirigente, né politica, né militare, e neppure la troveranno nei decenni seguenti quanti, nel mondo cattolico, cercheranno una soluzione alla ‘questione italiana’: solo i cattolici avranno i titoli per ‘indossare’ la reazione popolare, quella del ‘Paese reale’ contro il ‘Paese legale’”.
Sarebbe interessante presentare tutte e dieci le figure contro-rivoluzionarie, ma poi la mia recensione diventa un saggio, come dice qualche amico e quindi illeggibile. Mi limito a qualche breve accenno, la prima biografia è di un grande educatore predicatore frate cappuccino emiliano, poi diventato vescovo di Parma, Adeodato Turchi. Segue il grande principe Cardinale Fabrizio Ruffo, sicuramente il personaggio più noto per via della sua grande impresa dell’esercito della Santa Fede e la riconquista del Regno di Napoli. Martinucci si avvale della proficua bibliografia sul personaggio e ci presenta un ricco panorama di episodi che non conoscevo del cardinale peraltro tanto osteggiato dagli storici di regime. Descritto come un capo ambizioso e machiavellico a capo di una banda di briganti. Basta leggere la ricostruzione farsa di Cuoco. Subito dopo c’è la figura di Gan Francesco Galeani Napione, discendente di un casato antico e nobile al servizio della monarchia sabauda. Merita essere ricordato non solo per gli studi linguistici, ma soprattutto per quanto ha lasciato nel campo delle teorie politiche federative o confederative, la cui adozione avrebbe forse salvato l’Italia dai gravami politico-economici post-unitari, che ancora oggi non hanno trovato adeguata soluzione. Napione ha proposto una soluzione confederativa non ideologica, che sarebbe stata agevolata dall’unità del credo religioso delle sue popolazioni e dalla presenza del Papato. Giovanni Marchetti, toscano di Empoli con la vocazione religiosa in polemica con i giansenisti e i gallicani. Nominato da Papa Pio VII, arcivescovo di Ancira e vicario apostolico. Un ecclesiastico “scomodo”, inviso al mondo politico di indirizzo regalistico e giurisdizionalistico al clero giansenista. Punto di riferimento di coloro che hanno contrastato la Rivoluzione con le idee.
Pio Bruno Lanteri, un sacerdote forse un poco conosciuto, soprattutto negli ambienti torinesi, ha fondato una associazione semisegreta Amicizia Cristiana e poi chiamata Amicizia Cattolica. Segreta perché c’era la polizia napoleonica che non scherzava. Amava fare apostolato diffondendo “buoni” libri di apologetica cattolica e di critica alla scuola giansenistica. Le caratteristiche dell’associazione erano una assoluta fedeltà al Papa, obbedienza ai vescovi, pratica della carità tra i confratelli. Si tratta di un sodalizio di persone seriamente impegnate nel miglioramento di se stessi, nella correzione dei propri difetti, nell’acquisizione delle virtù cristiane. Lanteri collaborò con un altro religioso che ha segnato la Chiesa di quel tempo, lo svizzero Nicolas Albert Diessbach S. J. Entrambi hanno colto il carattere epocale della Rivoluzione, “intuendo di aver di fronte un fenomeno di lunga durata, che incide nella cultura e nei costumi dei popoli, perché corrosivo dell’anima delle persone, operante, quindi, in interiore homine”. Lanteri è conosciuto per aver fondato anche la Congregazione degli Oblati di Maria Vergine. Il religioso ha dato inizio a quel “rosario di santità” che sono i cosiddetti “santi sociali” torinesi a cominciare da Giovanni Bosco e per finire al Cottolengo. Cesare Taparelli d’Azeglio, più conosciuto il figlio Massimo. Tuttavia, anche Cesare appartenne all’Amicizia Cristiana di Pio Bruno Lanteri. Ha promosso la rivista L’Ape in Toscana e poi creato il periodico L’Amico d’Italia. Molti l’hanno visto come l’iniziatore del giornalismo cattolico. Fedele collaboratore di casa Savoia, ha seguito il re in esilio Carlo Emanuele IV, quando le truppe francesi del generale Joubert invadono il Regno subalpino.
Antonio Capece Minutolo, Principe di Canosa. Anche lui piuttosto conosciuto, ma sempre come una figura abietta, dalla cultura progressista. Discendente da una famiglia nobiliare che annovera tredici Vicerè, due cardinali e uno stuolo di guerrieri famosi. Il Canosa ha avuto una vita politica abbastanza travagliata, sia con i nemici, che con i presunti amici. Canosa ha animato l’insurrezione a Napoli dei lazzari dal 20 al 30 gennaio del 1799 che tengono in scacco le armate del generale francese Championnet e i collaborazionisti, i giacobini locali. Poi con la vittoria dei francesi viene condannato a morte ma salvato dall’arrivo in città delle truppe del cardinale Ruffo. Martinucci chiarisce nella biografia perché è nata la “leggenda nera” sul Principe di Canosa. Dovuta alla pubblicazione di Antoine Saliceti, ministro della polizia di Joseph Bonaparte e poi di Pietro Colletta. Il principe non accettava l’indirizzo politico di restaurazione del cancelliere austriaco Klemens von Metternich. E ben presto si trovò in disaccordo con il capo del governo napoletano Luigi dè Medici che ha ripristinato le istituzioni esistenti prima della Rivoluzione francese. Tuttavia, Canosa tra esilii e incarichi di governo che poi deve lasciare per incomprensioni, termina la sua vita nello studio e nella propaganda contro-rivoluzionaria. Interessante il suo ultimo incarico di consigliere di Stato presso la Corte di Francesco IV di Modena. Anche qui si è distinto come un grande combattente contro-rivoluzionario, creando un Corpo militare denominato i Centurioni. Tutto sommato senza voler dare una lettura ideologica del principe, pur se sconfitto dagli eventi storici del suo tempo, possiamo scrivere che, “egli, indomito, ha combattuto la Rivoluzione con una tenacia e una perseveranza, che si possono definire eroiche, incalzando i rivoluzionari sia sul versante della battaglia delle idee, sia sul piano militare, difendendo la religione quale fondamento del vivere nel consorzio umano e perseguendo l’obiettivo politico – una restaurazione in pristinum – perché tale società potesse poi conservarsi nel tempo”.
Le ultime figure prese in considerazione da Martinucci sono Monaldo Leopardi, Giacomo Mellerio e Giuseppe Baraldi, ma mi devo fermare anche per una breve presentazione per evitare che il mio intervento diventi troppo lungo.
DOMENICO BONVEGNA
dbonvegna1@gmail.com