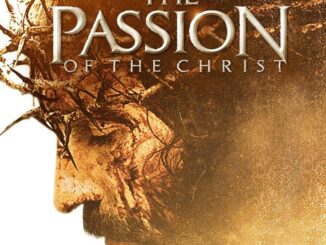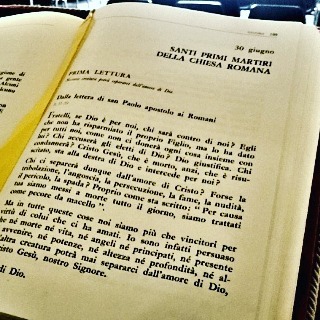
di Andrea Filloramo
La Chiesa vive in un tempo segnato da fermento, inquietudine e speranza. Papa Francesco ha aperto con forza la stagione della “Chiesa in uscita”, della sinodalità e della misericordia. Il nuovo pontefice Leone XIV, pur con tratti differenti, sembra voler proseguire su questa strada, spingendo anch’gli verso una Chiesa che si riforma per essere più evangelica, più umana e più credibile.
Per comprendere la dinamica della trasformazione ecclesiale in atto, è necessario liberare la parola “tradizione” da alcune semplificazioni. Nella teologia cattolica, la Tradizione è ben più di un insieme di consuetudini o norme tramandate: è il flusso vivo della fede e la memoria della Chiesa che fa presente il Vangelo nel tempo. Essa non è mai statica, ma, come ha insegnato il Concilio Vaticano II (cf. Dei Verbum 8), “progredisce nella Chiesa” e si esprime attraverso la Scrittura, il Magistero, ma anche attraverso l’esperienza del popolo di Dio. Se, però, la tradizione diventa ideologia difensiva, si trasforma in un fardello che imprigiona invece di liberare, fa confondere la fedeltà con l’immobilismo e la memoria con il rimpianto.
Dall’altra parte, anche il termine “innovazione” contiene in sé degli equivoci. Innovare, infatti, non significa rompere né cedere allo “spirito del mondo” o al relativismo, ma cercare forme nuove per un contenuto che resta sempre lo stesso: il Vangelo.
È interessante notare che i momenti più fecondi della storia ecclesiale sono stati spesso anche quelli più creativi: il monachesimo, le riforme medievali, le grandi figure profetiche, i Concili. Ogni vero rinnovamento nasce dall’ascolto della Parola e dai segni dei tempi.
Il processo sinodale in corso – rilanciato con decisione da Papa Francesco – che è il luogo simbolico e reale della tensione fra tradizione e innovazione, si manifesterà – ne siamo certi – con maggiore chiarezza durante il pontificato di Papa Leone XIV. Si tratta di un cammino non certo facile, che non punterà a una “nuova Chiesa” in senso disgregante ma a una Chiesa rinnovata nello stile e nello spirito. Sinodalità non significa semplicemente democrazia ecclesiale; significa riconoscere che lo Spirito parla anche attraverso il “sensus fidei” del popolo di Dio e che il Papa non può prescindere dall’ascolto. Questo implica un cambiamento culturale profondo nel modo di pensare la ministerialità e la comunione.
Alcuni temi oggi in discussione — come il celibato sacerdotale, il diaconato femminile e perché no? il presbiterato femminile, il ruolo delle persone omosessuali nella Chiesa o la riforma della Curia, sono segni di un travaglio ecclesiale che non può più essere rimosso. Ignorarli per paura di rompere l’unità, rischia di minare la credibilità della Chiesa stessa.
Ogni transizione comporta dei rischi. Il primo è quello della rottura ideologica, quando l’innovazione si trasforma in rottamazione, quando il nuovo viene esaltato acriticamente e il passato ridicolizzato. Questo crea divisioni, polarizzazioni, e spesso reazioni ugualmente ideologiche.
Il secondo rischio è quello della restaurazione difensiva, che idealizza e mitizza il passato, resiste a ogni cambiamento, confonde la devozione con il devozionismo, il miracolo con il miracolismo, la verità con l’abitudine. Queste posizioni tradiscono il Vangelo, riducendolo a un insieme di dottrine intoccabili da custodire anziché a una vita da testimoniare.
Un altro rischio, forse il più sottile ma profondamente radicato perché secolare, è quello del clericalismo. Papa Francesco ha più volte denunciato questa “perversione spirituale”, che trasforma il ministero in potere, il servizio in privilegio, il sacerdozio in una casta. Il clericalismo soffoca la corresponsabilità ecclesiale, marginalizza i laici, infantilizza i fedeli e ostacola qualunque processo autentico di riforma. È un ostacolo sia alla tradizione viva (perché la riduce a gerarchia rigida), sia all’innovazione (che viene vista come minaccia all’autorità costituita). Un’autentica riforma ecclesiale non potrà mai attuarsi senza una conversione del cuore che liberi la Chiesa da questa logica autoritaria e restituisca ai ministeri ordinati il loro vero volto: quello del servo, non del dominus.
La Chiesa, a partire dal Concilio Vaticano II – è bene ribadirlo – non può essere più quella definita dal Codice di Diritto Canonico in vigore fino al 1983, che considerava la Chiesa come appartenente al clero e dedicava un unico canone, generale e positivo, ai laici, in cui si leggeva: «È diritto dei laici ricevere dal clero i beni spirituali, gli aiuti necessari alla salvezza» (can. 682).
In tale canone i laici godevano solo dei diritti di cittadini stranieri, residenti e protetti; i chierici invece godevano della piena cittadinanza. Questo Canone, che magari oggi non si conosce ma che viene ancora sempre o spesso applicato, ignora il popolo di Dio nella sua unità e considera i laici subordinati in tutto ai sacerdoti.
Questo Codice è il fedele riflesso dell’ecclesiologia del tempo passato. San Pio X, Papa dal 9 agosto 1903 al 20 agosto 1914, i n un’enciclica rivolta alla Chiesa di Francia, infatti, scriveva : «La Chiesa è per sua natura una società ineguale, cioè una società formata da due categorie di persone: i pastori e il gregge (…) Queste categorie sono così nettamente distinte fra loro, che solo nel corpo pastorale risiedono il diritto e l’autorità necessari per promuovere e indirizzare tutti i membri della società; quanto alla moltitudine non ha altro diritto che di lasciarsi guidare e seguire, come un docile gregge, i suoi pastori».
Questa distinzione tra governanti e governati si riscontra ancora con altrettanta rigidità tra celebranti e assistenti, docenti e discenti. Essa era largamente accettata al momento della convocazione del concilio Vaticano II, come testimonia un editoriale della rivista ufficiale dell’Azione cattolica operaia francese: «Sul piano della fede, il vescovo è dottore. Il dialogo tra il vescovo e i laici cristiani è certamente possibile, ma il laico non può che apprendere, ricevere. È preso in carico dalla gerarchia. È un segno di comportamento adulto accettare la propria condizione».
L’unica via ecclesiale da seguire oggi è quella del discernimento: vigilare, cioè, su ciò che nasce dallo Spirito, e lasciar cadere ciò che viene solo dall’abitudine, dall’ideologia o dalla paura.
Concludendo: La vera sfida non è scegliere tra tradizione o innovazione, ma nel ritrovare una sintesi spirituale ed ecclesiale che tenga insieme i due poli. È possibile, anzi, urgente, pensare a una Chiesa che: mantenga viva la memoria apostolica senza rinunciare alla creatività pastorale; ascolti le sofferenze e le domande del mondo senza perdere l’annuncio profetico; riformi le sue strutture; si apra a tutti senza perdere l’identità evangelica.
Come ha detto il teologo francese Christoph Theobald, “il Vangelo si rinnova solo nella misura in cui viene nuovamente ricevuto”. Questo richiede un’umiltà profonda e un coraggio spirituale, non solo nel Papa, nei vescovi, nei pesbiteri, in ogni credente.