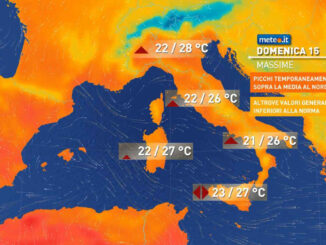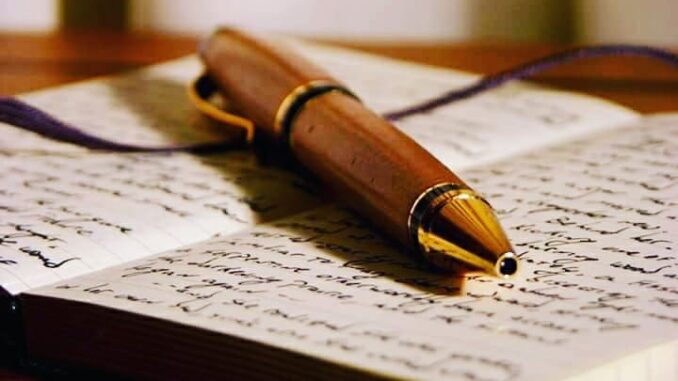
di Andrea Filloramo
Ci chiediamo: “Dopo il pontificato di Papa Francesco, in molti ambienti interni al mondo ecclesiale si respira ancora una forte tensione fra il desiderio di cambiamento e il volere ricominciare da zero. Riuscirà Papa Leone XIV a interpretare questo equilibrio?”
Negli ultimi anni, nella Chiesa, la parola “riforma” è diventata un campo di battaglia semantico, dove ciascuno proietta le proprie attese e le proprie paure, che – a dire il vero – oggi sono tante ma sempre reali, come quelle che nascono dalla crisi di credibilità, dagli scandali, dal calo delle vocazioni, dalle difficoltà a comunicare con la cultura contemporanea e, non ultime, da quelle dovute alle divisioni interne tra correnti e sensibilità teologiche.
È proprio dentro queste crepe che si inserisce la riforma della Chiesa che sta avvenendo durante gli ultimi pontificati, che non consiste in un cambio di immagine, ma in un lento processo di purificazione, che parte dalle coscienze prima che dalle istituzioni. In poche parole.
La Chiesa sta imparando – a caro prezzo – che non si riforma solo cambiando norme o strutture, ma rinnovando lo stile con cui annuncia il messaggio evangelico.
La trasparenza, il cammino sinodale, l’attenzione ai poveri e agli esclusi, il linguaggio più sobrio e misericordioso, sono questi i segni di un processo in cui la riforma non si misura con la rottura, come avveniva in un ormai lontano passato, ma con la fedeltà. È la conversione quotidiana di una Chiesa che vuole somigliare di più al Vangelo che proclama, una Chiesa che non ha paura di guardarsi dentro, né di riconoscere i propri errori.
La vera riforma come ci sta insegnando anche Papa Leone XIV, che continua e si spera continui ancora, anche se con stile diverso, sulla scia del suo predecessore, non nasce, quindi, dalla rottura per ciò che la Chiesa è stata o ha fatto, bensì dalla fiducia e dalla certezza che si continui a lavorare anche dove l’occhio umano vede solo macerie.
Chi invoca la riforma e dimentica la continuità, la trasforma in ideologia; chi la rifiuta per paura di cambiare, la svuota di vita, in quanto la “forma” originaria della Chiesa non è un modello istituzionale, ma una persona, cioè Cristo, che è la pietra angolare su cui tutto poggia, anche quando le pareti sembrano crollare.
Da rammentare che la metafora della “pietra angolare” richiama passi come Efesini 2:20 e Matteo 21:42, dove Gesù è descritto come il caposaldo su cui tutto il resto trova sostegno; l’immagine del “crollo delle pareti” aggiunge una dimensione realistica e umana: pur nelle fragilità e nelle tensioni della Chiesa, il fondamento rimane saldo. In altre parole, la stabilità non dipende dalla perfezione dei membri o dalle strutture istituzionali, ma dalla presenza viva di Cristo.
Come ricordava il teologo Yves Congar, “la vera riforma nella Chiesa è quella che si lascia giudicare dal Vangelo”.
E come il Concilio Vaticano II ha riconosciuto, la Chiesa “è sempre bisognosa di purificazione” (Lumen Gentium, 8). Non è una struttura perfetta da difendere, ma una realtà viva che si lascia rinnovare.
San Francesco d’Assisi resta l’immagine più luminosa di questa logica evangelica. Il suo gesto, apparentemente ingenuo, fu invece profetico: riformò la Chiesa, semplicemente facendo parlare il cuore. È questa la forza della rigenerazione interiore che diventa contagiosa.
Come scriveva Romano Guardini, “la Chiesa è santa perché santificante, non perché priva di peccato”. In questa frase è racchiuso il senso più vero della riforma: non la pretesa di una purezza impossibile, ma la perseveranza di un popolo che, nonostante tutto, continua a lasciarsi purificare dal Vangelo. È questa la riforma che conta, quella che non distrugge ma genera vita nuova.
È questa la linea che sembra delinearsi con sempre maggiore chiarezza nel cammino ecclesiale contemporaneo: non più la logica del “nuovo contro il vecchio”, ma quella del discernimento, della continuità e della purificazione. Una riforma, quindi, che non distrugge, ma rigenera; che non separa, ma ricompone.
In questa prospettiva si collocano anche le recenti scelte di Papa Leone XIV, interprete di un cambiamento che non teme la tradizione, ma la assume come radice viva del futuro.
Riedificare significa anche ricostruire legami. Il linguaggio della sinodalità — “camminare insieme”, non è, perciò, una parola alla moda, ma un modo di essere Chiesa: meno verticalità e più ascolto, meno dominio e più servizio. Papa Leone XIV, in una delle sue prime omelie, lo ha espresso così: “La Chiesa non è un cantiere di pietre isolate, ma un edificio di relazioni. Si riedifica insieme, mai da soli.”
In definitiva, la riforma sperata e prospettata da Papa Leone XIV non sarà fatta di gesti eclatanti o di rotture clamorose, ma di segni concreti e silenziosi che parlano alla vita quotidiana della Chiesa e dei fedeli. Sarà una riforma che guarderà alla sostanza più che all’apparenza, al radicamento spirituale più che alle strutture amministrative, e che affermerà con chiarezza che il futuro della Chiesa non si costruirà tagliando col passato, ma accogliendolo come fonte di forza e di identità.
In questo senso, il rinnovamento diventerà testimonianza: la continuità della fede diventerà anche capacità di leggere i tempi nuovi con occhi attenti e cuore aperto.