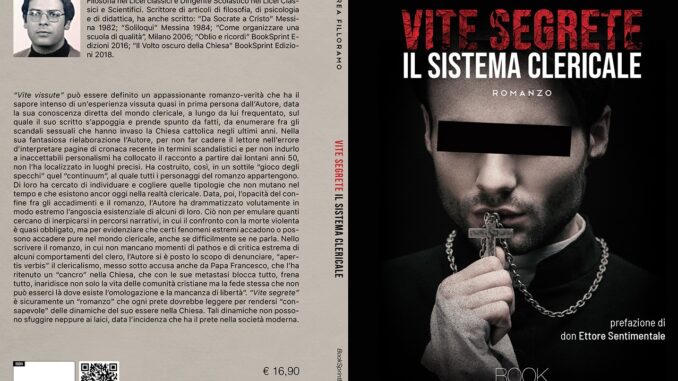
di Andrea Filloramo
Rispondo al quesito di una lettrice di IMG Press che chiede se la legge del celibato ecclesiastico sia la causa degli scandali sessuali di cui i preti sono protagonisti e faccio riferimento a uno studio condotto dal John Jay College of Criminal Justice (USA), in cui si afferma che «non è possibile identificare una sola causa» per gli abusi sessuali da parte di sacerdoti e che fattori invarianti nel tempo – come il celibato – non spiegano l’andamento di quella che lo studio definisce come epidemia.
A mio parere, la prima causa degli abusi da parte dei preti è la totale assenza di educazione affettiva e sessuale, che si riscontava nei seminari prima del Concilio Vaticano II, dai quali sono usciti molti preti attualmente impegnati nel ministero (circa il 65% degli ordinati) e costatabile ancor oggi – da quel che risulta da alcune testimonianze – in molti seminari.
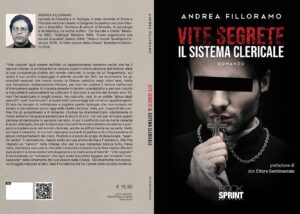
Da considerare, quindi, che la storia di quei seminari non appartiene soltanto al passato: essa rimane una lente privilegiata attraverso cui leggere le tensioni e le fragilità di una Chiesa ai nostri giorni impegnata nella formazione dei propri ministri.
E’ necessario, quindi, comprendere quali siano i problemi che, per la mancanza di un’educazione sessuale, i preti devono tutt’oggi affrontare per rimanere fedeli per quanto è possibile all’impegno celibatario.
Andiamo, quindi, indietro negli anni quando nei grandi edifici dei seminari fino agli anni 70 e in alcuni anche negli anni successivi, il silenzio non era solo una regola, ma un modo di vivere una vita totalmente isolata. Allora ragazzi di undici, dodici, tredici anni vi entravano lasciando alle spalle la famiglia, la scuola, gli amici. Il mondo “di fuori” diventava lontano, quasi sospetto. Dentro, tutto aveva un ordine: preghiera, studio, pasti, ricreazione.
Dietro quell’ordine si nascondeva, però, un’altra vita, più segreta e più difficile: quella della preadolescenza e dell’adolescenza, quando il corpo cambiava, ma nessuno ne parlava e quando il pudore diventava censura e la curiosità -naturale e innocente – si trasformava in colpa.
I confessori ammonivano a “custodire i sensi”, a non “cedere alle tentazioni della carne”. Che cosa fosse, però, davvero quella carne, e perché dovesse essere temuta, non lo spiegavano. La sessualità non esisteva come tema educativo: era solo un nemico da tenere sotto controllo, non una parte da integrare.
La sessualità era solo l’oggetto di sorveglianza. «Non se ne parlava mai apertamente», ricorda lo storico Alberto Melloni, che ha raccolto numerose testimonianze in Il Concilio e la formazione del clero in Italia (Il Mulino, 2002).
I confessori interrogavano i ragazzi su eventuali “tentazioni” o “pensieri impuri”, ma senza alcun linguaggio affettivo o psicologico. Era quello il tempo in cui la teologia morale manualistica riduceva la sessualità al rischio del peccato contro la castità.
«La carne era il nemico da domare – scrive lo storico Lucetta Scaraffia in Corpo e anima (Laterza, 2015) – , non una componente positiva della persona.»
«Molti ragazzi vivevano le prime pulsioni in solitudine e paura -spiega lo psicologo e teologo A. Boccanegra – La formazione era tutta centrata sul controllo, non sulla comprensione.»
Nei regolamenti dei seminari, spesso si leggeva il divieto delle amicizie particolari. Legami troppo stretti tra due seminaristi erano considerati rischiosi per la “purezza”. Chi mostrava, pertanto, eccessiva vicinanza con un compagno poteva essere rimproverato o spostato in refettorio o persino in cappella. Ogni emozione forte – un’amicizia, una simpatia, un pensiero rivolto a qualcuno – veniva così sorvegliato, corretto, spento.
«Ci insegnavano a non affezionarci troppo a nessuno — racconta un ex seminarista in un’inchiesta di Luigi Accattoli (1995) —. L’amicizia stessa era vista come una tentazione.»
L’educazione alla castità si traduceva così in un distacco emotivo generalizzato, che impediva la maturazione affettiva. Si imparava soltanto a obbedire e a reprimere, più che a conoscere se stessi. Chi provava turbamenti o curiosità si sentiva sporco, diverso, indegno.
Si confessava con vergogna, ripromettendosi di “non cadere più”. Alcuni reagivano con rigida disciplina, altri con malinconia o senso di colpa. Così, mentre fuori il mondo rapidamente cambiava, dentro il seminario la crescita affettiva restava sospesa.
Eppure, dietro quella rigidità, non c’era malizia. I formatori di allora erano convinti di aiutare quei giovani a custodire la purezza e la vocazione. Mancavano, però, le parole e mancava la conoscenza.
La psicologia era vista con diffidenza, e la cultura cattolica del tempo identificava facilmente la sessualità con la tentazione. Così, senza volerlo, si formarono generazioni di sacerdoti sinceri, ma spesso fragili dentro, segnati da una maturazione affettiva incompleta. Tutti, però, crescevano con la sensazione che il proprio corpo fosse un ostacolo da superare per diventare uomini di Dio
Molti sacerdoti formati in quell’epoca, guardando indietro, riconoscono una fragilità di fondo. «Ero sacerdote, ma dentro restavo un ragazzo — confessa un prete laicizzato in un’intervista raccolta da Andrea Riccardi in La Chiesa del Novecento (Laterza, 2000). — Non avevo mai amato, mai scelto liberamente. Avevo solo obbedito.»
Con il tempo, quella formazione rigida mostrò i suoi limiti.
Quando, infatti, negli anni Sessanta e Settanta, la società divenne più libera e la Chiesa iniziò a confrontarsi con nuove idee sulla persona, molti sacerdoti vissero crisi profonde. Alcuni, anzi tanti, abbandonarono il ministero; altri riscoprirono, con sofferenza, un mondo emotivo rimasto troppo a lungo represso.
Molti di loro, ordinati preti a ventiquattro anni, che avevano pregato, studiato, sofferto, si rendevano conto che non avevano mai amato davvero, mai scelto da uomini adulti.
Oggi quella stagione appare lontana, ma non del tutto superata. Alcuni meccanismi di silenzio e di paura riaffiorano ancora, segno che la Chiesa porta dentro di sé una lunga storia di pudori e di ferite. Tuttavia, riconoscere ciò che un tempo non si poteva nominare è già una forma di guarigione. Perché il corpo – quel corpo che si volle controllare e tacere – è parte della vocazione umana e spirituale di ogni persona. Anche di chi, come quei ragazzi di allora, aveva scelto di donarlo interamente a Dio.
Oggi, la Chiesa riconosce apertamente la necessità di una maturazione affettiva equilibrata nei futuri sacerdoti. Ma molti storici ritengono che le conseguenze del modello preconciliare siano ancora visibili.
«Il clericalismo, l’incapacità di relazione, la paura del corpo sono residui di quella cultura — osserva il teologo moralista Piero Coda —. Il Concilio ha aperto la strada, ma il cammino di integrazione non è ancora concluso.»



