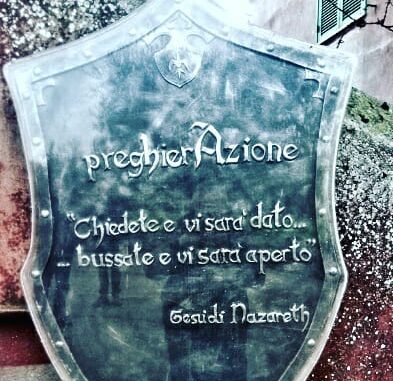
di Andrea Filloramo
“Solo il Signore, che scruta e conosce ciascuno di noi, sa comprendere i misteri più impenetrabili dell’animo umano”. Don Franco Giudice, vicario del vescovo per il clero della diocesi di Novara, ha commentato così la morte di don Matteo Balzano, 35 anni, Vice Parroco di Cannobio, nel Verbano-Cusio-Ossola.
Don Matteo è stato trovato morto nel suo appartamento annesso all’oratorio. Non si era presentato alla messa mattutina e, non rispondendo al telefono, si è temuto subito il peggio. La diocesi di Novara e il sindaco hanno confermato che non vi erano stati segnali evidenti di disagio.
La notizia del suicidio di don Matteo Balzano ha colpito come uno squarcio nel velo di discrezione che avvolge la vita di molti sacerdoti.
Giovane, attivo, stimato, impegnato nella pastorale giovanile: nulla lasciava presagire un gesto estremo. Eppure, dietro l’immagine del prete instancabile, si celava una frattura interiore profonda, resa invisibile anche ai più vicini.
Certamente quello del suicidio di don Matteo Bolzano non è il primo caso di suicidio di preti, di cui la Chiesa preferisce non parlare. Per essa, infatti, la reticenza a discuterne rappresenta la difficoltà ad avvicinarsi alla loro sofferenza che è sempre discreta, di cui probabilmente si sente in qualche modo responsabile e, per questo, nessuno se ne deve occupare.
Risulta che del suicidio dei preti si siano occupati per primi i vescovi francesi, che dal 2015 al 2020, hanno assistito ad una serie di suicidi. Erano preti ancora giovani di 38, 46, 47 anni. In Brasile nel 2018 si sono tolti la vita 17 presbiteri e altri 10 nel 2021,
In Italia – dove la Conferenza Episcopale nulla sa, nulla vede, nulla dice della vita reale dei preti – negli ultimi tre lustri sarebbero stati, da quel che si sa, almeno in 16 i preti che si sarebbero dati volontariamente la morte, ma pochi ne hanno parlato e scritto.
Anche se dei suicidi dei preti non se ne parla, sulla Rete, però, sono rintracciabili – se bene osserviamo – diversi studi e segnalazioni, che evidenziano i fenomeni di burnout, cioè della sindrome da esaurimento lavorativo, i sovraccarichi di impegni, la solitudine e la mancanza di supporto comunitario nella vita quotidiana dei sacerdoti e, quindi, i loro disagi crescenti, che potrebbero indurre o hanno indotto alcuni preti al suicidio.
Il rapporto Censis 2019 rileva, inoltre, che circa l’80% dei sacerdoti manifesta sintomi di affaticamento emotivo e il 20% soffre di forme clinicamente rilevanti di depressione.
Non sono da trascurare, infine, le varie dipendenze. che non coinvolgono necessariamente l’uso di sostanze, di cui parecchi preti non sono esenti.
Fra le dipendenze c’è quella dell’alcool, i cui effetti come sappiamo sono: l’ansia, la depressione, gli sbalzi d’umore, la difficoltà di concentrazione, l’isolamento sociale e la perdita di interesse per il lavoro svolto, che rendono pesante o addirittura impossibile l’esercizio del ministero. Sappiamo che in Francia l’8 % dei sacerdoti intervistati risulta al limite di tale dipendenza; di essi, poi, il 9 % presenta una sindrome depressiva. In Italia nulla si vuol far sapere, ma sappiamo che anche da noi come in Francia, ci sono dei preti poco rispettosi dei limiti imposti dalla morigeratezza e dalla sobrietà.
Non a caso la Civiltà Cattolica propone alcune misure già sperimentate o suggerite per i sacerdoti e, cioè, una vita comunitaria più intensa, una formazione permanente, assistenza spirituale, periodi di pausa o “stacco protetto” durante i momenti critici, supporto psicologico e attenzione alla salute mentale, che comprende anche il benessere emotivo e sociale.
Da aggiungere una nota non marginale: il celibato imposto e molto discusso anche fra i preti, può indubbiamente rappresentare un potenziale fattore di pressione psicologica se non adeguatamente integrato nella vita affettiva e relazionale. La solitudine affettiva e la mancanza di legami intimi autentici, infatti, possono acuirsi laddove non esistano reti di sostegno e condivisione. Papa Francesco ha affermato che il celibato “può diventare un peso se non è vissuto con maturità affettiva”, difficile, però, a raggiungere pienamente.
L’esperienza della fragilità e della sofferenza dei preti impegnati nel ministero, lungi dall’essere negata o nascosta, può diventare un luogo teologico fecondo. La teologia cristiana, specie nella tradizione patristica e agostiniana, ha sempre riconosciuto il limite umano come spazio di grazia e di conversione.
Per il prete accogliere questa prospettiva significa riconoscere il bisogno di sostegno e la legittimità del dolore come parte del cammino ministeriale.
Concludendo: il dramma del suicidio di un giovane sacerdote è un monito doloroso che invita la Chiesa a interrogarsi sulla propria responsabilità verso chi è chiamato a servire gli altri. L’ecclesiologia della cura, basata sulla comunione e sulla fraternità, può diventare un paradigma pastorale per un ministero sostenibile e umano.
L’interrogativo di Bonhoeffer, «Chi consola i consolatori?», può diventare ancor oggi un appello a costruire una cultura della cura capace di non lasciare soli i ministri del Vangelo, riconoscendo che la loro vulnerabilità non è un limite da occultare e di cui essi devono aver vergogna, ma un luogo di grazia da abitare con coraggio e speranza.



