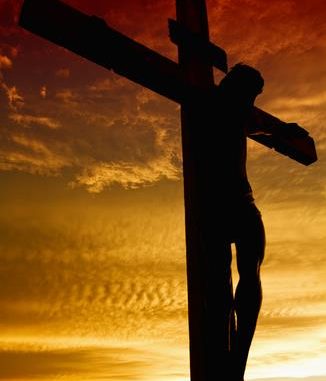
Mc 4,26-34
Diceva: "Così è il regno di Dio: come un uomo che getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga; e quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura".Diceva: "A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape che, quando viene seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno; ma, quando viene seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante dell’orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielopossono fare il nido alla sua ombra". Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la Parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro ma, in privato, ai suoi discepoli spiegava ogni cosa.
di Ettore Sentimentale
Alla ripresa della lettura continua del vangelo secondo Marco (dopo varie solennità), ci imbattiamo con una pagina estrapolata da un intero capitolo dedicato al “discorso in parabole” di cui leggiamo la parte finale. Devo brevemente ribadire che la “parabola” è un genere letterario alquanto complesso. Essa presuppone un codice comune di comprensione, fra chi parla e gli uditori. Per esempio, agli ascoltatori di Gesù risultava facile cogliere la metafora del “seme”, attorno a cui Marco articola il cap. 4. Loro conoscevano il Sal 126,5 (la semina fra le lacrime e la mietitura nel giubilo), oppure la storia di Isacco che “seminò in quella terra e raccolse il centuplo quell’anno” (Gen 26,12), oppure l’iniziativa di Dio che “ha seminato gli Israeliti tra i popoli” (Zc 10,9).
Anche la parabola del seme, sulla quale mi soffermo un attimo, ha un ritmo tripartito: c’è un primo fatto (seminare), un secondo evento (germogliare) e infine la spiegazione (crescita “spontanea”, lett. “automatica”, preludio alla mietitura).
Proprio questo ultimo punto diventa la chiave di lettura di tutta la breve narrazione. Se noi uomini del XXI sec., ammalati di efficientismo come frutto di lavoro programmatico rimaniamo quasi spiazzati dal questa “crescita spontanea” del seme che si identifica con il Regno di Dio, figurarsi gli ascoltatori di Gesù e soprattutto gli scribi e farisei i quali predicavano che solo con l’osservanza dei precetti si poteva far parte del popolo di Dio.
La novità del messaggio di Gesù attraverso questa parabola consiste proprio nel provocare in noi il desiderio di una fecondità che Dio spontaneamente ha messo dentro di noi attraverso il dono dello Spirito. Questa è la cosa più importante da fare e non tanto il compiere sforzi disumani per raggiungere chissà quali mète spirituali.
Allora, fuori metafora, comprendiamo che potremmo sciupare tutta la vita in un’esistenza imperniata solo sullo sforzo della semina (cioè il lavoro), dimenticando che il seme cresce spontaneamente, senza che il contadino possa dargli alcuna forza per germogliare.
Chiarisco ulteriormente questo passaggio. È importante per i contadini “seminare”, ma nel seme vi è qualcosa che loro non vi hanno messo. È l’energia vitale che non dipende dai loro sforzi.
In una battuta: il Signore ci invita ad accogliere la sua presenza vivificante e a farla germinare. Ciò presuppone che per noi, come scrive George Bernanos alla fine del romanzo Diario di un curato di campagna, “tout est grâce” (tutto è grazia). La vita è un dono e, parafrasando la parabola, dovremmo chiedere al Signore di essere tanti piccoli semi che là dove si trovano rendano più bella la società. Abbiamo davanti una sfida significativa in quest’anno in cui ci stiamo preparando al Convegno di Firenze: proviamo ad essere seminatori di umanità.
