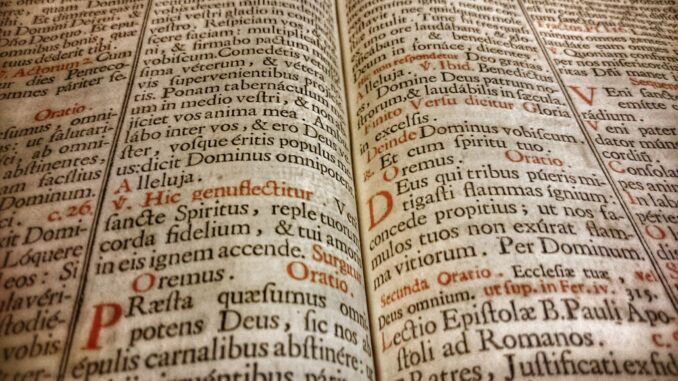
di Andrea Filloramo
La nomina di una donna, Sarah Mullally, al vertice della Chiesa Anglicana è da considerare un punto di svolta, un manifesto di cambiamento, che mette in gioco non solo le Chiese anglicane, ma la stessa Chiesa Cattolica obbligata a ripensare, almeno nella prassi e nella pastorale, le proprie scelte su ministeri, autorità e inclusione delle donne, superando così per quanto è possibile, le contraddizioni implicite nella sua dottrina.
Nella storia della Chiesa, le contraddizioni non sono mancate mai, né mancano adesso. Molte contraddizioni derivano dalla sfida di conciliare la dottrina millenaria, l’autorità gerarchica, i valori spirituali universali con le realtà culturali moderne senza perdere la propria identità. In pratica, la Chiesa Cattolica vive in un equilibrio continuo tra ideale e pragmatismo, fede e potere, tradizione e innovazione, aspirazioni spirituali e necessità concrete.
Alcune di queste contraddizioni, grazie al discernimento comunitario o al magistero, vengono superate in fretta, altre restano aperte anche per generazioni, perché toccano nodi profondi della fede, della cultura o della storia. Eppure, se si guarda con sguardo di fede, si vede che le fratture non sono solo segni di divisione o debolezza ma anche spazi che portano la comunità cristiana a comprendere più in profondità quanto annuncia.
Cerchiamo, quindi, di dare uno sguardo d’assieme ed individuiamo alcune di queste – chiamiamole pure anche se impropriamente – “aporie”, iniziando dalla schiavitù, spesso intesa anche come sinonimo di non libertà, che – se bene osserviamo – è una questione più economica, gestionale e politica che teologica, un dato sociale molto complesso, in quanto ha coinvolto tensioni tra principi morali universali, interessi politici ed economici, e l’evoluzione del pensiero teologico nel tempo.
Il fenomeno della schiavitù nella Chiesa ha avuto una posizione contradittoria in quanto, pur affermando il valore dell’anima e della persona, la Chiesa ha tollerato per molto tempo la privazione di libertà. Col tempo, però, è passata dalla tolleranza e dalla regolamentazione a una condanna morale totale.
Solo, infatti, nel XX secolo, ha condannato chiaramente qualsiasi forma di schiavitù o tratta di persone. Con la “Dichiarazione dei Diritti Umani” e con i documenti del Concilio Vaticano II (1962-1965) ha ribadito la dignità inviolabile di ogni persona.
Papa Giovanni Paolo II e Papa Francesco hanno, poi, denunciato in più occasioni la schiavitù moderna, come traffico di esseri umani, lavoro forzato e sfruttamento sessuale.
Un altro esempio delle contraddizioni ella Chiesa è la libertà religiosa, considerata prima del Vaticano II, da Gregorio XVI (Mirari vos, 1832) e da Pio IX (Sillabo, 1864), un errore moderno, perché, a loro parere, metteva sullo stesso piano la verità rivelata e l’errore religioso; negava, cioè, il diritto della Chiesa di guidare la società verso la verità; favoriva l’indifferentismo, cioè l’idea che tutte le religioni si equivalgano. In sintesi: la libertà di religione, prima del Concilio, era vista come libertà dell’errore, incompatibile con la verità di Cristo.
Il Concilio Vaticano II, con la Dignitatis humanae (1965), capovolse questa visione. Non negò, infatti, che la verità fosse una sola, ma cambiò prospettiva in quanto affermò in modo chiaro che il diritto alla libertà religiosa non nasce dall’essere “nella verità”, bensì dalla dignità della persona umana; nessuno, quindi, deve essere costretto ad agire contro coscienza, né deve essere impedito di seguire la propria ricerca del vero; la fede autentica, quindi, richiede libertà interiore e esteriore.
Contradittorio è il rapporto tra la Chiesa cattolica e il popolo ebraico, che è da considerare uno dei percorsi più complessi e più significativi della storia cristiana, segnato da secoli di tensioni, pregiudizi e persecuzioni dei “cattivi” ebrei, considerati deicidi, ma anche, a partire dal XX secolo, da un profondo cammino di riconciliazione e rinnovamento teologico.
Anche in questo caso la vera svolta avvenne con il Concilio Vaticano II, che con la dichiarazione “Nostra Aetate” , ha affermato: «La Chiesa […] riconosce che gli inizi della sua fede e della sua elezione si trovano già, secondo il mistero divino della salvezza, nei patriarchi, in Mosè e nei profeti»; «Gli ebrei non devono essere presentati come rigettati o maledetti da Dio, come se ciò scaturisse dalle Sacre Scritture».
È stato questo sicuramente un cambio epocale, con cui la Chiesa ha ripudiato ogni forma di antisemitismo, e ha riconosciuto l’alleanza di Dio con Israele come permanente e irrevocabile.
Oggi, una delle più visibili contraddizioni, è quella che riguarda le donne e l’Ordine Sacro, che è da considerare una ferita che attraversa la Chiesa non solo come questione disciplinare, ma come domanda teologica: può la grazia di Dio avere sesso?
Cerchiamo, quindi, di ragionare, con la mente priva di pregiudizi e di tabù, cioè di quei costrutti sociali e psicologici che spesso influenzano profondamente la vita individuale e collettiva, generando effetti negativi su vari livelli, che non dovrebbero esserci anche nella Chiesa.
Come la Chiesa insegna, l’Ordine sacro è uno dei sette sacramenti, segno dell’amore di Dio che si fa servizio, ma viene conferito solo agli uomini. E’ questa una restrizione ed una scelta che non è da ritenere affatto arbitraria, in quanto è fedele a quella di Gesù, che chiamò solo uomini tra i Dodici apostoli.
In questa logica, il sacerdote agisce nella persona di Cristo che è capo e sposo della Chiesa e la mascolinità sarebbe parte del segno stesso del sacramento.
Questa spiegazione – non è difficile comprenderlo – si scontra con un altro fondamento della fede: l’universalità della grazia. Il battesimo, infatti, non conosce distinzione di sesso e la dignità battesimale è la stessa per ogni credente. Come ricordava Paolo: “Non c’è più né uomo né donna, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù” (Gal 3,28).
Ecco la contraddizione: una Chiesa, che proclama l’uguaglianza in Cristo, limita a un solo sesso – quello maschile – il sacramento che rappresenta il suo amore servizievole e giustifica il fatto con la metafora dello sposo necessariamente maschio e la Chiesa.
E’ questa una tensione che non tiene conto che ogni sacramento parla attraverso un “segno”, che, per restare vivo, deve poter essere riconosciuto come vero e trasparente. Quando il mondo cambia, anche il linguaggio dei segni deve essere riletto, perché la rivelazione non è una formula pietrificata, ma un dialogo che attraversa la storia.
Il segno sacramentale parla solo se è ancora capace di rimandare all’Origine senza chiudersi in se stesso. Il compito della teologia è quello di discernere quando un segno diventa opaco, quando cioè non rivela più, ma nasconde e restituirgli la trasparenza che lo riconnette al Mistero.
L’immagine del sacerdote come “Cristo sposo” e della Chiesa come “sposa” aveva un valore forte in un contesto patriarcale, in cui il maschile era associato all’iniziativa, all’autorità, alla generazione e al dominio, mentre il femminile era connotato come recettivo, obbediente, generativo ma subordinato.
Questa metafora sponsale, sviluppatasi a partire da san Paolo (Ef 5,25-32) e poi assunta nella tradizione patristica e medievale, serviva a esprimere l’amore di Cristo per la Chiesa, ma nel tempo è stata anche utilizzata per giustificare l’esclusività maschile del ministero sacerdotale: solo un uomo, si diceva, può rappresentare “Cristo sposo” di fronte alla “Chiesa sposa”.
Oggi, però, questa è un’immagine stereotipata, obsoleta, inadatta, incongrua, che riduce la ricchezza dell’amore di Dio a un modello di coppia che non dice più tutto il mistero. Dio non è né maschio né femmina. È comunione, dono, relazione. Ciò che il sacramento deve mostrare non è il corpo maschile di Cristo, ma la sua umanità redenta, la sua capacità di amare fino alla fine.
Non mancano i teologi che insistono su questo punto: la mascolinità di Cristo non è teologicamente costitutiva della salvezza, per cui l’insistenza su una presunta “necessità maschile” per la redenzione rischia di ridurre la portata universale del messaggio cristiano.
Cristo, quindi, pur essendo maschio nella storia, trascende i confini di genere come modello e salvatore: ciò che conta è la sua umanità pienamente vissuta e la sua relazione con Dio, non è l’identità sessuale.
In sintesi, la mascolinità di Cristo ha valore storico, ma non fonda né condiziona la logica della salvezza ed è semplicemente il modo storico in cui Dio si è reso visibile in un determinato tempo e in una determinata cultura.
La redenzione, pertanto, resta accessibile a ogni persona umana, indipendentemente dal genere, confermando l’universalità della grazia divina.
Da ciò la convinzione che il sacerdozio non debba essere negato al sesso femminile e si auspica che la riflessione teologica e il discernimento ecclesiale possano aprire vie nuove perché anche le donne, pienamente parte del Popolo di Dio e partecipi del sacerdozio comune dei fedeli, possano essere chiamate, in futuro, al ministero ordinato, nel rispetto della Tradizione ma anche in ascolto dei segni dei tempi.
Per il raggiungimento di queta meta, non si parte, in realtà, da zero. Nelle prime comunità cristiane, infatti, esistevano diaconesse, come testimoniano la Lettera ai Romani (16,1) — dove Paolo saluta Febe, “diaconessa della Chiesa di Cencre” — e diversi documenti dei primi secoli. Il Concilio di Calcedonia (451) riconosceva ufficialmente il ministero delle diaconesse, pur con funzioni limitate.
Questa memoria storica è tornata viva negli ultimi anni. Papa Francesco ha istituito due commissioni di studio sul diaconato femminile, nel 2016 e nel 2020. Il solo fatto che la questione sia oggetto di ricerca ufficiale mostra che la Chiesa non considera chiuso il discorso.
Forse il primo passo del futuro non sarà il sacerdozio femminile – il cammino si prospetta lungo a causa dell’insipienza o della eccessiva prudenza clericale – ma un riconoscimento pieno dei ministeri diaconali e della corresponsabilità delle donne nei ruoli di guida e discernimento.
Il cristianesimo non è la religione della coerenza perfetta, ma della fedeltà nel cambiamento.
La verità di Dio non si impone tutta in una volta; si lascia scoprire, spesso a caro prezzo, dentro i limiti della storia.
L’Ordine sacro, così come oggi è vissuto, custodisce una tensione che non si può più ignorare. Chiamarla “contraddizione” non significa condannarla, ma riconoscere che la Chiesa, come ogni corpo vivo, cresce anche attraverso le sue ferite.



