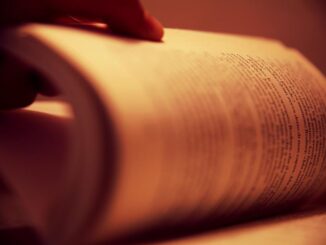La rigenerazione urbana delle città parte da una nuova attenzione a livello globale verso ecologia e sostenibilità. I recenti cambiamenti sociali, il crescente numero di eventi climatici estremi, la ricerca di sistemi eco-sostenibili e di indipendenza energetica, insieme al perseguimento degli obiettivi dell’Agenda 2030, hanno portato le città a essere uno dei soggetti principali della transizione sostenibile.
Le città al centro di nuove politiche eco-sostenibili
Attualmente, oltre la metà della popolazione mondiale risiede in aree urbane, e si prevede che questa quota possa raggiungere il 70% entro il 2050. Le città costituiscono il fulcro della crescita economica a livello locale e nazionale, generando oltre l’80% dell’attività economica globale. Tuttavia, insieme alle opportunità, emergono anche sfide significative. Nonostante coprano solo il 3% della superficie terrestre, i centri urbani consumano il 75% delle risorse mondiali e sono responsabili di tre quarti delle emissioni di gas serra, lasciando un’impronta ecologica considerevole. L’obiettivo 11 dell’Agenda 2030 mira a ridurre l’inquinamento pro capite prodotto dalle città, in particolare per quanto concerne la qualità dell’aria e la gestione dei rifiuti. Lo sviluppo urbano dovrà essere più inclusivo e sostenibile, anche grazie a una pianificazione degli insediamenti partecipativa, integrata e sostenibile.
L’Italia ha avviato a macchia di leopardo, pratiche virtuose di rigenerazione urbana basate sul modello delle Smart Cities
Secondo gli ultimi Rapporti ASvIS, l’Italia ha avviato, seppur a macchia di leopardo, pratiche virtuose basate sul modello delle Smart Cities, così come complessivamente ha fatto registrare progressi nella raccolta differenziata, nel trasporto urbano e nella qualità dell’aria nelle città. Tra gli obiettivi con forti criticità ci sono la riduzione del 20% dell’energia consumata e l’azzeramento del consumo di suolo, per i quali in circa due terzi dei territori la situazione è in peggioramento, e nessuna Regione o Provincia autonoma sembra poterli raggiungere entro il 2030. In questi ultimi anni, soprattutto a causa della mancanza di una regolamentazione nazionale e per effetto della devolution di poteri centrali alle Autonomie locali, numerose Regioni si sono dotate di una normativa per la rigenerazione urbana, spesso collegata alla legge urbanistica regionale.
La rigenerazione urbana attraverso la spinta del PNRR
L’obiettivo principale del PNRR è quello di colmare i divari strutturali e territoriali ed è quindi centrale il ruolo degli Enti locali, ed in particolare dei Comuni, nel perseguire questo obiettivo. Le misure che riguardano più direttamente la trasformazione delle città si possono includere in tre grandi macro-gruppi: la rigenerazione urbana; il settore dei trasporti e le Zone economiche speciali (ZES); l’edilizia e i servizi pubblici.
Un rilevante investimento, quello dei Piani Urbani Integrati (PUI), è gestito dal Ministero dell’Interno e destinato alle città metropolitane, con lo scopo di migliorarne le periferie creando nuovi servizi per i cittadini e riqualificando le infrastrutture. Con il Dl 152/2021 il Governo ha ripartito le risorse del PNRR originario fra le 14 città metropolitane in base al peso della popolazione residente e all’Indice di vulnerabilità sociale e materiale. L’obiettivo è trasformare territori vulnerabili in città “intelligenti” e sostenibili. Alla Città metropolitana di Napoli sono assegnati 351 milioni per sei PUI, tra cui la rigenerazione di due grandi quartieri di edilizia residenziale pubblica, Scampia e Taverna del Ferro. A Roma vanno 330 milioni per 5 PUI principalmente negli àmbiti della solidarietà sociale, cultura, sport e mobilità. Segue Milano con 277 milioni per 4 PUI volti principalmente all’inclusione sociale e alla mobilità smart. In molti casi, le città metropolitane hanno cofinanziato il PUI con risorse proprie aggiuntive, come nei casi di Firenze e Venezia.
La Regione i cui progetti hanno complessivamente il valore economico più alto è il Lazio, seguono la Lombardia e la Campania
Ad oggi è difficile fare una ricognizione esatta dello stato di avanzamento dei progetti, anche in vista di una rimodulazione delle risorse che è in corso di discussione. Tenendo conto di queste criticità, possiamo però osservare che la Regione i cui progetti hanno complessivamente il valore economico più alto è il Lazio (1,1 miliardi per 214 progetti); seguono la Lombardia (596 milioni per 287 progetti) e la Campania (535,8 milioni per 233 progetti). Se però si considerano solo i finanziamenti del PNRR, esclusi quindi altri finanziamenti nazionali, al primo si insedia la Campania (499,8 milioni) seguita da Lombardia (439,8 milioni) e Sicilia (420,7 milioni).
Accanto ai finanziamenti del PNRR esistono dei programmi di rigenerazione assegnati ai singoli Ministeri
Accanto ai finanziamenti del PNRR esistono dei programmi assegnati ai singoli Ministeri, con le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari – PNC (Dl 59/2021), destinati ad integrare le iniziative del PNRR stesso: 30,6 miliardi di euro per la realizzazione di 30 interventi, di cui 24 finanziati in via esclusiva e dunque a carico del bilancio dello Stato e 6 cofinanziati con il PNRR. Tra questi occorre menzionare quelli gestiti dal MIBACT che ammontano a 1,4 mld e che finanziano 13 distinti interventi. Altra misura nazionale che ha stimolato le Amministrazioni locali ad intraprendere percorsi di rigenerazione urbana è stato il Fondo Innovazione Sociale (FIS). Promosso nel 2018 dal Dipartimento della Funzione Pubblica e gestito dal Formez, il suo obiettivo principale è stato quello di potenziare la capacità amministrativa delle Pubbliche amministrazioni nel campo dell’innovazione sociale. Anche il Ministero dell’Interno, per accompagnare gli interventi del PNRR diretti ai piccoli Comuni, ha messo a disposizione dei contributi per investimenti di rigenerazione urbana a favore dei Comuni con popolazione inferiore a 15mila abitanti, con una dotazione complessiva per il 2022 pari a 300 milioni di euro.
La Strategia Nazionale Arre Interne contro declino demografico e spopolamento
La Strategia Nazionale Italiana per le Aree Interne (SNAI) è stata lanciata nel 2014 con l’obiettivo di arrestare il declino demografico e migliorare il potenziale di sviluppo endogeno dei territori in risposta a dinamiche di spopolamento e lento degrado delle aree interne. Nella nuova programmazione 2021-2027 vengono confermate 67 delle 72 aree interne individuate nel ciclo 2014-2020 e sono state previste ulteriori nuove 56 aree interne per un totale di 124 Aree di progetto che coinvolgono 1.904 Comuni, in cui vivono 4.570.731 abitanti. Di queste nuove aree interne, 43 sono state assegnatarie di risorse per un importo complessivo di 172 milioni, pari a 4 milioni per ciascuna area. Per accompagnare la SNAI nel 2021 è stato ripartito il “Fondo di sostegno ai Comuni marginali” per gli anni 2021-2023 (180 mln, Legge di bilancio 2021) di cui sono stati beneficiari 1.187 Comuni e nel 2022 il “Fondo per la progettazione territoriale” (161,5 mln) finalizzato a rilanciare e accelerare la progettazione nei piccoli Comuni, le Province e le Città metropolitane delle regioni del Sud, Marche e Umbria, nonché nei centri delle aree interne, di cui sono risultati beneficiari 7 Città metropolitane, 38 Province e circa 4.800 Comuni fino a 30.000 abitanti.
I Contratti Istituzionali di Sviluppo per l’accelerazione della realizzazione di grandi infrastrutture ritenute strategiche e di rilevanza nazionale
I “Contratti Istituzionali di Sviluppo” (CIS), vengono stipulati tramite accordi tra Ministeri, Regioni e soggetti attuatori per l’accelerazione della realizzazione di grandi infrastrutture ritenute strategiche e di rilevanza nazionale. Possono riguardare direttamente infrastrutture ferroviarie e stradali, o la valorizzazione di specifici territori. Esistono poi dei CIS dedicati alla rigenerazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale dei centri storici di alcune città del Sud Italia: Palermo, Napoli, Cosenza, Taranto.
I piccoli Comuni e le Isole minori tra sviluppo, patrimonio storico e rischio idrogeologico
Vengono definiti “piccoli Comuni” tutti quei i Comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti. Dal 2017 è stato istituito un Fondo a loro destinato indirizzato alla tutela dell’ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla riqualificazione dei centri storici, alle infrastrutture stradali, agli istituti scolastici e alla promozione dello sviluppo economico e delle nuove attività produttive. Similmente per le “Isole minori” marine, è stata adottata una linea di finanziamento specifica per i permanenti svantaggi naturali cui sono soggette e a cui si sommano obiettive difficoltà di accessibilità fisica al verificarsi di eventi calamitosi. Dal 2022, inoltre, le 26 Isole minori abitate che coinvolgono 35 Comuni italiani sono state inserite come 73esima Area Interna Ultraperiferica della SNAI e sostenuto attraverso il “Progetto speciale Isole Minori”.
Gli interventi per le periferie urbane
Nel 2024 è stato pubblicato il bando “Sport e periferie” gestito dal Ministero per lo Sport e i Giovani, con una dotazione di 65 milioni e destinato ai Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti. Gli interventi finanziati hanno previsto il recupero degli impianti sportivi esistenti nelle zone degradate delle città. Molti gli interventi finanziati dalle Fondazioni e diretti per lo più al privato sociale e agli Enti del Terzo Settore (ETS), sono concentrati in particolare sugli aspetti inclusivi della rigenerazione urbana. Le Fondazioni finanziano, ad esempio, molte iniziative di social housing, o di trasformazione di edifici storici o industriali abbandonati in poli di aggregazione sociale e culturale, oppure iniziative di recupero delle periferie. Nel campo dell’housing la Fondazione Cariplo e la Fondazione Housing sociale hanno sperimentato progetti innovativi in Lombardia. In queste sinergie tra Fondazioni ed ETS è centrale il ruolo dell’Ente locale che spesso assume il ruolo di facilitatore, valorizzando l’opera del privato sociale.
Una strategia unitaria di lungo termine per la rigenerazione urbana
In attesa di una legge organica sulla rigenerazione urbana diverse disposizioni sono intervenute sul tema delle politiche urbane, volte a favorire la rigenerazione urbana, la riqualificazione del patrimonio edilizio e delle aree urbane degradate, la riduzione del consumo di suolo, lo sviluppo dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili e il miglioramento e l’adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente. Le recenti normative europee, collegate agli impegni presi per l’Agenda 2030 e gli investimenti recenti in materia di rigenerazione urbane ‒ primi fra tutti quelli del PNRR ‒ impongono la definizione di un nuovo schema regolativo che includa la governance delle politiche urbane ed una strategia unitaria di lungo termine. Entrambe divenute di centrale importanza per gli ambiziosi obiettivi di sostenibilità che le sfide del nuovo millennio ci impongono.
La troppa eterogeneità dei processi decisionali rallenta la rigenerazione urbana
Nel 2024 un Testo unico per una legge sulla rigenerazione urbana, che accorpa le diverse proposte intervenute durante le ultime due Legislature, ha proseguito il suo iter parlamentare: esso spazia dal dissesto idrogeologico, alle isole di calore, con spazio all’efficienza energetica, alla sicurezza sismica, al consumo di suolo ed alla qualità urbana. Altri segnali positivi possono essere visti negli impegni presi per un “Piano di ripristino della natura” entro il 2026, o il fatto che 9 città italiane partecipano alla Missione europea Carbon neutral entro il 2030 e stiano predisponendo i loro piani di mitigazione. Tuttavia, pesa ancora il fatto che il “Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici” del Governo, presentato a fine 2023, sia rimasto inattuato. Per la gestione di politiche così complesse e trasversali servirebbe un organo istituzionale con ampi poteri, alla stregua di un “ministero delle Città”. A fronte di ingenti risorse introdotte per attuare obiettivi di rigenerazione urbana, serve un’azione politica in grado di accompagnare e promuovere tali politiche. I punti di debolezza rimangono: la mancanza di una struttura organica di livello nazionale e di risorse permanenti indirizzate alla rigenerazione urbana, anche in vista dell’esaurimento dei fondi del PNRR, insieme alla troppa eterogeneità dei processi decisionali.
Marco Marucci, ricercatore Eurispes e CNR-Ircres