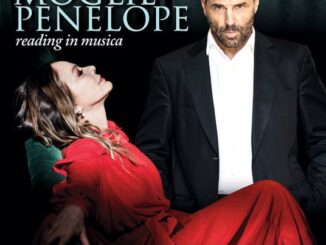di Andrea Filloramo
Lo Stretto di Messina è da sempre una frontiera. È un luogo che non si attraversa senza conseguenze: ogni passaggio lascia un segno, ogni approdo cambia il destino. Qui i mari si incontrano e si respingono; qui il mito collocò Scilla e Cariddi, simboli del rischio e del passaggio obbligato.
Oggi quel varco viene consegnato al sogno, che, però, non è di tutti, di avere il ponte più lungo del mondo, di unire ciò che la natura ha diviso, di congiungere la Sicilia e il continente in un unico corpo.
Dietro la retorica del progresso, che si radica in una fede della crescita che ignora la possibilità de declino o del regresso, resta sospesa una domanda: con il Ponte quale sarà il futuro di Messina, la città fondata dai Greci, che nella sua antichissima storia fu più volte Capitale del Regno di Sicilia? la città porterà di quell’opera il peso più grande?
È evidente che la costruzione del Ponte stravolgerà completamente il suo assetto generale e che, pertanto, prima di far porre la prima pietra, è necessaria un’attenta valutazione pianificatoria e, quindi, un totale coinvolgimento dei cittadini messinesi e dei paesi limitrofi che non possono essere esclusi, lasciando solo alla politica il loro destino.
Il rischio evidente di un ipotetico e – come deliberato – fattibile Ponte sarà che Messina si ridurrà a passaggio, a una porta che non accoglierà, ma lascerà transitare. Con il Ponte, infatti, i flussi di merci e di persone attraverseranno la città senza fermarsi, generando soltanto traffico, rumore e inquinamento. La modernità, così celebrata, rischierà di lasciare dietro di sé soltanto il frastuono del movimento e la sensazione amara di un’occasione mancata.
Messina conosce bene la violenza delle trasformazioni. Il terremoto del 1908 distrusse non solo edifici, ma la memoria, l’identità, la continuità. I bombardamenti degli aerei alleati nel ’43 la fecero divenire, poi, una “città fantasma”. La ricostruzione successiva, infine, consegnò alla città un volto incompiuto, molto frammentato. Ora il ponte, con i suoi svincoli, le sue linee ferroviarie, i suoi cantieri, minaccerà di infliggere un nuovo trauma: ridisegnerà, cioè, lo spazio urbano con la logica dell’ingegneria, non con quella della vita.
L’argomento più convincente per la costruzione del Ponte rimane quello occupazionale. I cantieri – si promette – daranno lavoro. Certamente questo potrà avvenire, ma il lavoro sarà solo precario perché legata alla costruzione del Ponte; dopo, però, si assisterà ad una situazione di elevata disoccupazione con implicazioni sociali ed economiche immaginabili.
La vera sfida, quindi, non è quella di costruire il Ponte, ma di costruire, attorno al ponte, un’economia stabile, cioè: logistica, portualità, turismo culturale, ricerca. Senza questo, l’opera sarà un grande spettacolo effimero, destinato a lasciare un territorio più debole di prima.
Non mancano quelli che immaginano il Ponte come nascita di una metropoli dello Stretto, che unisce Messina e Reggio Calabria. È questa senz’altro un’idea suggestiva, ma non si pensa che una metropoli non può essere decretata ma richiede politiche comuni, governance condivisa, capacità di integrare servizi e comunità. Senza questa visione, si rischia di sommare fragilità anziché generare forza.
Per una città, che vive da oltre un secolo nell’ombra delle proprie macerie, il Ponte potrebbe essere simbolo di rinascita. Ma i simboli sono ambigui: possono riscattare, ma anche cancellare.
Messina rischia di diventare, la città del ponte senza più essere città di se stessa, ridotta a sfondo di un’opera che la sovrasta.
Il destino di Messina non dipenderà dal Ponte in sé, ma – se il Ponte si farà – da ciò che saprà costruire intorno ad esso. Un ponte può unire due sponde, ma può anche cancellare un luogo. Può aprire all’Europa, ma al tempo stesso escludere la comunità che lo ospita.
Lo Stretto ha sempre imposto una scelta: attraversare o fermarsi. Così anche il futuro di Messina sarà una scelta, tra il diventare soglia del Mediterraneo o il ridursi a pedaggio di un progresso che guarda lontano ma dimentica ciò che ha sotto i piedi.