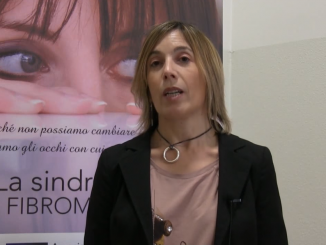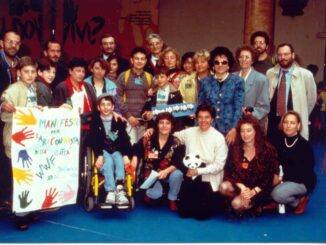Ogni anno il 20 maggio si celebra la Giornata della Memoria in ricordo dei quasi 2 milioni di morti ad opera dei Khmer Rossi di Pol Pot. Quest’anno ricorre il cinquantesimo anniversario. Il 20 maggio 1975 l’Angkar imponeva l’obbligo di vita collettiva, e distruggeva la famiglia. Dal 1975 al 1979 un ristretto gruppo di rivoluzionari comunisti compirono un vero e proprio genocidio della popolazione cambogiana con deportazioni di massa e assassinii sistematici di chi era considerato nemico del popolo. L’intera popolazione fu deportata dalle città in campagna.
I “liberatori” avevano le idee chiare: una società pura, la vera uguaglianza, non il socialismo ma il comunismo. Nacque la Repubblica Democratica di Kampuchea. Al di sopra di tutti c’era l’Angkar, che non era una persona, non c’era un leader carismatico, non cesarismo, non culto della personalità. Angkar era un’entità collettiva, una Commissione, si può tradurre con “l’Organizzazione”. Sì, c’era Kieu Sampam ma non era lui al vertice, era Pol Pot, il quale neppure compariva in pubblico. Verso l’Angkar era dovuta devozione. C’è una sintesi completa dell’esperimento comunista cambogiano su La Nuovabussola di oggi (Walter Lazzari, Comunismo. Così Pol Pot abolì la famiglia, imparando la lezione della Rivoluzione Francese, 20.5.25, lanuovabq.it)
L’assassinio come metodo di governo scrive nel Libro Nero del Comunismo, Jean-Louis Margolin. “Basta un milione di buoni rivoluzionari per il paese che vogliamo costruire. Non abbiamo bisogno del resto. Preferiamo uccidere dieci amici piuttosto che lasciar vivere un nemico”: questo dichiaravano i Khmer rossi nelle loro riunioni di cooperativa”. E questa logica genocida è stata messa in pratica. Per qualsiasi futile motivo si rischiava di essere assassinati sotto Pol Pot. “L’Angkar uccide, ma non dà mai spiegazioni”, era uno slogan che risuonava tra la gente. C’è tutta una lista dettagliata per i tanti motivi per cui si veniva uccisi. Il furto di cibo è sicuramente il primo della lista. Nella Kampuchea democratica in teoria il carcere non esiste, Pol Pot se ne vantava. Esistevano i centri di rieducazione. Tuttavia, era tutta la Cambogia un carcere a cielo aperto. Il Libro Nero ha cercato di spiegare quali erano le ragioni della follia rossa cambogiana. Certo era una unicità, l’esperienza politica dei Khmer rossi. Pol Pot e compagni erano convinti che stavano compiendo il più grande avvenimento rivoluzionario della storia. Il passato doveva essere sepolto, si stava creando un mondo nuovo, non c’era più bisogno di mandare i bambini a scuola. La nostra scuola è la campagna; la terra è la nostra carta; l’aratro la nostra penna; scriveremo arando; i certificati e gli esami sono inutili. I comunisti cambogiani iniziarono da zero, cancellando il passato. Nella società c’era posto per due sole grandi classi: I contadini (collettivizzati) sono il Popolo antico o Popolo semplice quello delle campagne o, meglio, dei territori “liberati” negli anni e mesi precedenti il 17 aprile 1975. Essi dovevano odiare tutti gli abitanti delle città. E lo insegnarono bene ai ragazzini che costituivano il loro esercito (i bambini – soldato non sono stati inventati in Africa). Poi c’era il Popolo Nuovo o Popolo del 17 aprile perché era stato “liberato” dopo il 17 aprile. E costoro erano tutti dei potenziali nemici, in quanto corrotti dagli stili di vita occidentali. Essi erano una minaccia: le persone istruite, professionisti, insegnanti, dottori, avvocati, chi parla una lingua straniera, chi porta gli occhiali, deboli e disabili, monaci, suore e, insomma, ogni abitante delle città.
Essi dovevano essere rieducati: per questo furono tutti espulsi dalle città. Nelle campagne, in fattorie collettive, vietato qualsiasi abito colorato, quindi dovevano tingerli di nero, tutti vestiti di nero. Proibita la religione, ripudiare origini e credenze religiose. Proibito il commercio, proibita l’istruzione, il denaro e la proprietà privata aboliti. Divise le famiglie e deportate le persone in differenti parti del Paese: uomini con uomini, donne con donne; con le mamme solo i bambini sotto i 6 anni. Risultato? Più di 3 milioni di cambogiani uccisi da cambogiani stessi, un quarto della popolazione: come se 15 milioni di italiani fossero uccisi da altri italiani. Come è potuto accadere tutto questo? È una domanda che si son posti in tanti. Lazzari fa parlare Suong Sikoeun che è stato uno di quei dirigenti del regime comunista. Ha pubblicato in Francia le sue poderose memorie (Itinéraire d’un intellectuel khmer rouge ed. Cerf). Tutti hanno studiato a Parigi, santuario degli studenti cambogiani, dove una serie di insegnanti universitari li introducono ai concetti della Rivoluzione del 1789 coniugati all’esperienza comunista. Confessa Suong: «Il mio è stato un lento processo che risale agli anni ’50, quando frequentavo le superiori: mi infatuai della Rivoluzione francese. Feci miei gli ideali di libertà, uguaglianza e fraternità. E ancor di più quando giunsi in Francia per l’università. Nel corso degli anni mi gettai a peso morto nelle attività e nei dibattiti politici, via via fino alla convinzione che solo una rivoluzione violenta, condotta da un manipolo di militanti devoti e risoluti, intimamente legati alle masse, sotto la direzione del Partito marxista-leninista, potesse mettere un termine ai mali di cui soffriva il mio Paese e il mio popolo: dominazione straniera, oppressione feudale e ingiustizia sociale. (…) Leggevo con avidità tutto quello che riguardava la Rivoluzione francese, con preferenza per i giacobini e il suo capo, Robespierre, che era il mio eroe, il mio idolo. E mi determinai all’idea di una trasformazione della società con il metodo rivoluzionario e della necessità di una dittatura proletaria». Insomma, questi giovani comunisti cambogiani furono istruiti dalla cultura francese del Novecento che per certi versi ha la responsabilità di aver “armato la pistola” del genocidio cambogiano, come ha detto il cardinale Jean-Marie Lustiger. Per capire la Cambogia di Pol Pot, bisogna cominciare da lontano, scrive Lazzari, almeno dalla redenzione da parte di Dio è sostituita dall’idea di autoredenzione da parte dell’uomo. E poi ancora bisogna fare riferimento alla storia antica e medievale che è attraversata dalla presenza di sette che professano eresie manichee e gnostiche: i catari (secc. XI-XIII), i Fratelli del Libero Spirito (XII-XIV) (Adamiti, Begardi, Hussiti, Taboriti, …), i Fratelli apostolici (XIII-XIV), fra Dolcino: l’avvento di un radicale rinnovamento del genere umano e l’instaurazione di uno stato definitivo di perfezione. Poi, nell’ambito della rivolta protestante, troviamo capi che si autoinvestono profeti come Giovanni di Leida: A questo proposito c’è un bellissimo libro “Il Re degli Anabattisti” di Friedrich Reck-Malleczewen. Il testo racconta l’esperienza della città tedesca di Munster, definita, la “Nuova Gerusalemme”, dove tutti erano uguali, che tutte le cose fossero comuni a tutti gli uomini, che ciascuno ricevesse secondo i suoi bisogni, ma se c’è qualcuno che ostacola il progetto, allora non ha diritto di vivere e c’è la spada che lo stermina. A Műnster: lì per la prima volta viene applicato il terrore sistematico come mezzo per realizzare il sogno messianico di “rifare la creazione”. È noto l’entusiasmo di F. Engels e della storiografia marxista per questo “profeta del comunismo”, Giovanni di Leida, perché il suo spirito egualitario si univa all’azione rivoluzionaria. Le costanti di questi fenomeni rivoluzionari sono: che la creazione di un mondo nuovo e perfetto sia possibile solo facendo tabula rasa del mondo vecchio; sempre la pratica del Terrore; la subordinazione coercitiva di tutto e tutti al piano politico oggi per raggiungere la libertà assoluta domani.
La democrazia totalitaria: il teorico più eminente di essa è Jean Jacques Rousseau. Nega il peccato originale, l’uomo è intrinsecamente buono e viveva felice nello “stato di natura” (il buon selvaggio) ma l’evoluzione dei rapporti sociali, la nascita della proprietà privata lo corrompono. Occorre allora un contratto sociale: «Ciascuno di noi mette in comune la propria persona e ogni proprio potere sotto la suprema direzione della volontà generale» Nella dolce costrizione di Rousseau traspaiono in filigrana la ghigliottina e i GuLag. Perché «Come si pretenderà che una moltitudine cieca, spesso ignorante dei suoi stessi desideri possa esprimere una volontà comune? Si rende necessaria la sollecitudine operosa di una guida che incarni la volontà generale finché il popolo non sarà educato a volerla».
Dove nasce l’homo ideologicus? Nelle Società di pensiero (saloni filosofici, gruppi politici, logge massoniche e, più tardi, partiti ideologici). Vi si parla di tutto, sono fondate sulla parola, non sulla realtà; è il regno dell’opinione: bisogna abbattere gli ostacoli alla libertà, che sono l’esperienza, la tradizione, la fede. E qui Lazzari cita Augustin Cochin (Meccanica della Rivoluzione, Rusconi) La Rivoluzione si attua in tre fasi.
Un primo stadio dell’incubazione ideologica (1750-1789): dove il Terrore già domina sulle lettere, un Terrore incruento, del quale l’Enciclopedia fu il Comitato di Salute Pubblica e D’Alembert il Robespierre: con lo strumento della diffamazione (l’infamia). La rete di società sparse sull’intero territorio francese adotta questo metodo.
Poi, secondo stadio, la filosofia diventa azione politica per la realizzazione della volontà generale. Cochin porta prove delle manipolazioni mediante le quali le “società” riuscivano nelle assemblee a far passare deliberazioni decise prima del voto e, attraverso la rete societaria, a farle convergere speditamente su Parigi. Le istituzioni rappresentative del popolo di Parigi, la Comune e le Sezioni, finiscono per essere dominate da una piccola minoranza di rivoluzionari di professione, che a loro volta sono diretti da manovratori di fili, i capi giacobini. Bisognò creare un prodotto manovrabile, il cittadino, ossia un individuo senza protezioni sociali. E indebolire quindi i legami familiari “I figli appartengono alla Repubblica, prima che ai loro genitori” (G. J. Danton).
Terza fase (1793-94): lo Stato rivoluzionario. Chi incarna la volontà generale ha il dovere di allargare il campo dei nemici del popolo e di «punire non soltanto i traditori ma anche gli indifferenti» (Saint-Just, Terrore e libertà, Editori riuniti). Nemici del popolo: il termine (sinistramente abbondante nel vocabolario comunista) nasce col Terrore giacobino. Il diritto-dovere di esercitare il terrore: «il Terrore non è altro che la giustizia pronta, severa, inflessibile; esso è dunque un’emanazione della virtù». E la macchina del Terrore si nutre con la delazione, si copre col silenzio. Poi occorre ricercare i “colpevoli” degli insuccessi rivoluzionari (carestia, crollo della produzione, sconfitte militari, …). Infine, la Rivoluzione mangia i suoi figli.
Ecco le tappe della democrazia totalitaria ed ecco la Kampuchea Democratica.
a cura di DOMENICO BONVEGNA